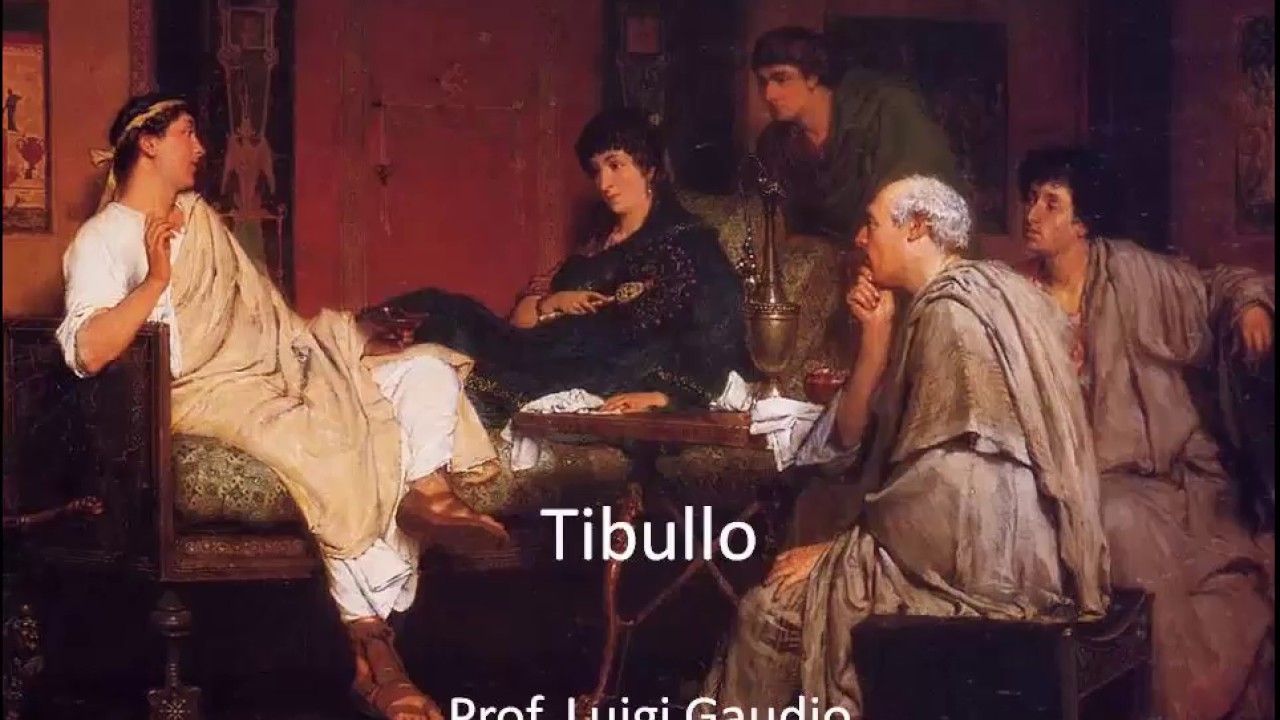Brani tradotti dal Satyricon di Petronio
28 Dicembre 2019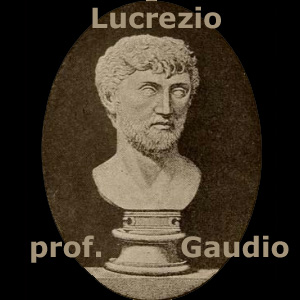
La passione d’amore dal De rerum natura di Lucrezio, IV, 1141-1159
28 Dicembre 2019I versi 13-24 della prima elegia del primo libro di Tibullo sviluppano ulteriormente l’ideale di vita semplice e bucolica del poeta, contrapponendolo agli orrori della guerra.
L’ideale di vita in Tibullo 1.1
L’elegia proemiale di Tibullo presenta un’articolata contrapposizione tra due modelli esistenziali: la vita attiva dedicata alla ricerca di ricchezze e gloria militare, e l’esistenza appartata nell’otium campestre. Nei primi versi (1-12), il poeta delinea chiaramente questa antitesi:
Divitias alius fulvo sibi congerat auro
et teneat culti iugera multa soli,
quem labor adsiduus vicino terreat hoste,
Martia cui somnos classica pulsa fugent:
me mea paupertas vita traducat inerti,
dum meus adsiduo luceat igne focus.
“Un altro accumuli per sé ricchezze con oro splendente e possieda molti iugeri di terra coltivata, che l’ansia continua per il nemico vicino lo atterrisca, a cui le trombe di Marte suonate tolgano il sonno: la mia povertà mi conduca a una vita tranquilla, purché il mio focolare brilli di fuoco continuo.”
I contenuti dei versi 13-24
| Testo latino
et quodcumque mihi pomum novus educat annus, |
Traduzione italiana
“E qualunque frutto mi produca il nuovo anno, viene posto come offerta davanti al dio protettore dei campi. Bionda Cerere, a te sia dedicata una corona di spighe dal nostro podere, che penda davanti alle porte del tempio; e sia posto il rosso Priapo custode nei frutteti rigogliosi, perché spaventi con la terribile falce gli uccelli. Anche voi, o Lari, custodi di un campo un tempo prospero, ora povero, ricevete i vostri doni. Allora una giovenca uccisa purificava innumerevoli giovenchi: ora una piccola agnella è vittima sacrificale di un esiguo podere. Un’agnella cadrà per voi, intorno alla quale la gioventù contadina griderà: ‘Evviva! Date messi abbondanti e vino buono’.” |
Tibullo, Le elegie, a cura di Francesco Della Corte, Milano, Valla-Mondadori, 1980 I, 1, vv. 13-24
Tibullo, Le elegie, a cura di Francesco Della Corte, Milano, Valla-Mondadori, 1980, I, 1, vv. 1-28
In questa sezione, Tibullo amplifica il motivo della vita campestre, descrivendo le gioie dell’agricoltura, la tranquillità del focolare domestico e la presenza dell’amata. Il poeta esprime il desiderio di piantare “tenere viti” e coltivare “grandi alberi da frutto”, invocando la protezione della dea Speranza perché offra “sempre mucchi di messi e denso mosto nel tino colmo”.
Analisi dell’ideale di vita
La religiosità agreste (vv. 13-18)
Tibullo presenta un ideale di vita profondamente integrato con la religiosità tradizionale romana legata al mondo agricolo. Il poeta sottolinea il rispetto scrupoloso verso le divinità campestri: ogni frutto viene offerto come libagione al dio agricolae, identificabile con i Lari o con divinità specifiche della fertilità.
La menzione di Cerere (v. 15), dea delle messi, evidenzia il legame indissolubile tra attività agricola e dimensione sacrale. La corona spicea che deve ornare il tempio rappresenta il riconoscimento della dipendenza umana dalla benevolenza divina per la prosperità dei raccolti.
Priapo (vv. 17-18), divinità apotropaica dei giardini, completa questo pantheon rurale. La sua funzione protettiva viene descritta attraverso l’immagine della “saeva falx” che allontana gli uccelli predatori, simboleggiando la necessità di difendere i frutti del lavoro agricolo.
La trasformazione della condizione economica (vv. 19-22)
Il poeta introduce una riflessione malinconica sul cambiamento delle proprie condizioni materiali. L’antitesi tra “felicis quondam” e “nunc pauperis agri” evidenzia il declino economico che ha colpito la proprietà familiare, probabilmente in conseguenza delle guerre civili e delle confische fondiarie dell’epoca.
La contrapposizione tra i sacrifici del passato (vitula… innumeros… iuvencos) e quelli attuali (agna… exigui… soli) sottolinea drammaticamente questa trasformazione, ma senza tono di lamentazione. Il poeta accetta serenamente la nuova condizione, adattando le pratiche religiose alle possibilità economiche ridotte.
La persistenza dei valori tradizionali (vv. 23-24)
Nonostante l’impoverimento, Tibullo mantiene fede alle tradizioni religiose ancestrali. Il sacrificio dell’agnella, pur modesto, conserva la sua efficacia rituale e la capacità di unire la comunità rurale nella celebrazione collettiva.
L’esclamazione “Io! messes et bona vina date” rappresenta l’espressione autentica della gioia contadina e della fiducia nella benevolenza divina. Questa invocazione corale della “rustica pubes” evidenzia la dimensione comunitaria dell’ideale tibulliano, che non è individualismo egoistico ma partecipazione alla vita della piccola comunità agricola.
La filosofia dell’accontentarsi
L’;ideale di vita delineato in questi versi si fonda sulla capacità di adattamento e sulla valorizzazione delle gioie semplici. Tibullo non rimpiange la ricchezza perduta, ma trova significato e appagamento nelle pratiche religiose tradizionali, nel rapporto diretto con la natura e nella solidarietà comunitaria.
Il valore paradigmatico
Questi versi rappresentano un modello alternativo ai valori dominanti della società romana contemporanea. Contro l’ambizione politica e militare, Tibullo propone una saggezza esistenziale che trova nell’accettazione dei limiti materiali e nella fedeltà alle tradizioni ancestrali una via di realizzazione umana autentica.
L’ideale tibulliano anticipa tematiche che ritroveremo nella letteratura pastorale successiva e costituisce una delle prime espressioni mature di quella sensibilità bucolica che influenzerà profondamente la tradizione letteraria europea.
L’ideologia dell’otium
L’ideale tibulliano si configura come una forma di otium che non è semplice ozio, ma scelta esistenziale consapevole. La paupertas rivendicata dal poeta non indica indigenza, ma una condizione di vita modesta che permette la libertà dalle preoccupazioni materiali e l’dedizione agli affetti privati.
La dimensione anti-eroica
La posizione di Tibullo rappresenta una consapevole presa di distanza dai valori tradizionali romani centrati sul cursus honorum e sulla gloria militare. Questo atteggiamento riflette la crisi dei valori repubblicani tradizionali e l’emergere di una nuova sensibilità esistenziale nell’età augustea.
La poetica dell’intimità
L’elegia tibulliana inaugura una poetica dell’intimità che privilegia la dimensione privata su quella pubblica, l’amore sulla guerra, la contemplazione sull’azione. Questo modello influenzerà profondamente la successiva tradizione elegiaca europea.
Testo integrale latino
Tibullo, Le elegie, a cura di Francesco Della Corte, Milano, Valla-Mondadori, 1980, I, 1, vv. 1-28
Divitias alius fulvo sibi congerat auro
et teneat culti iugera multa soli;
quem labor adsiduus vicino terreat hoste,
Martia cui somnos classica pulsa fugent.
Me mea paupertas vita traducat inerti, 5
dum meus adsiduo luceat igne focus.
Ipse seram teneras maturo tempore vites
rusticus et facili grandia poma manu;
nec Spes destituat, sed frugum semper acervos
praebeat et pleno pinguia musta lacu. 10
Nam veneror, seu stipes habet desertus in agris
seu vetus in trivio florida serta lapis;
et quodcumque mihi pomum novus educat annus,
libatum agricolae ponitur ante deo.
Flava Ceres, tibi sit nostro de rure corona 15
spicea, quae templi pendeat ante fores;
pomosisque ruber custos ponatur in hortis
terreat ut saeva falce Priapus aves.
Vos quoque, felicis quondam, nunc pauperis agri
custodes, fertis munera vestra, Lares. 20
Tunc vitula innumeros lustrabat caesa iuvencos:
nunc agna exigui est hostia parva soli.
Agna cadet vobis, quam circum rustica pubes
Clamet «Io! messes et bona vina date».
Iam modo iam possim contentus vivere parvo 25
nec semper longae deditus esse viae;
sed Canis aestivos ortus vitare sub umbra
arboris, ad rivos praetereuntis aquae.
Tibullo, Le elegie, a cura di Francesco Della Corte, Milano, Valla-Mondadori, 1980, I, 1, vv. 1-28