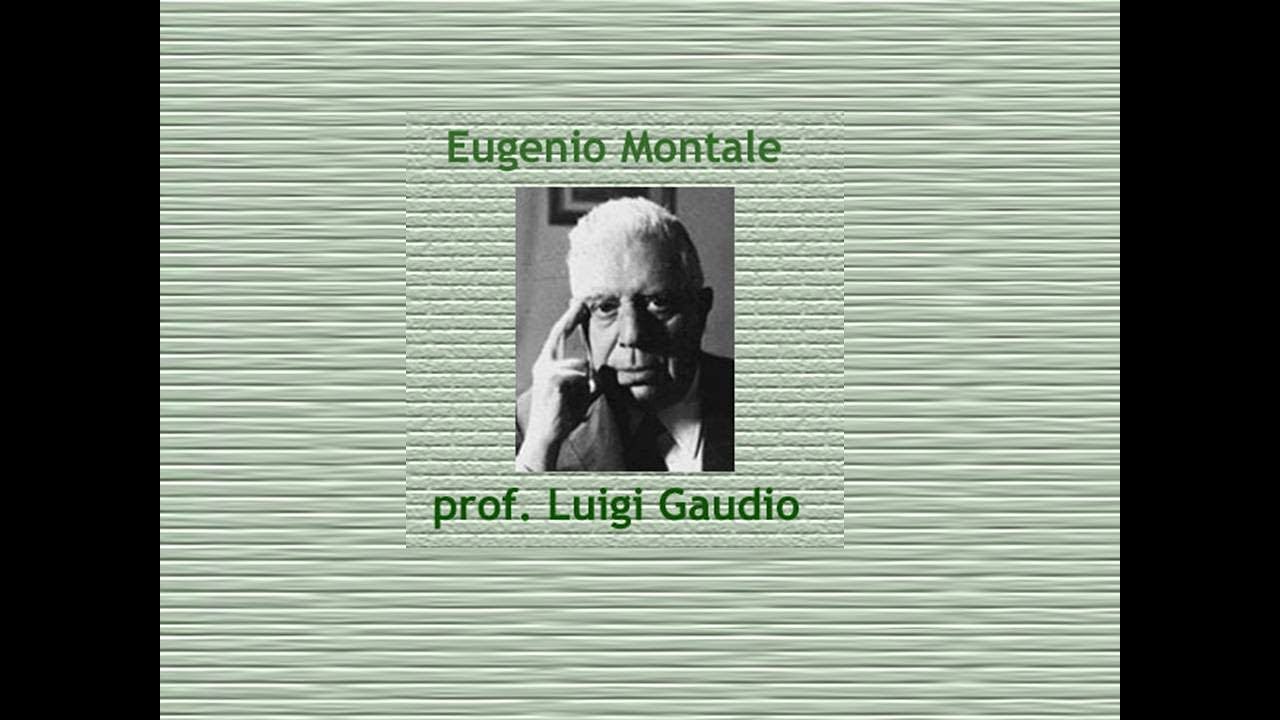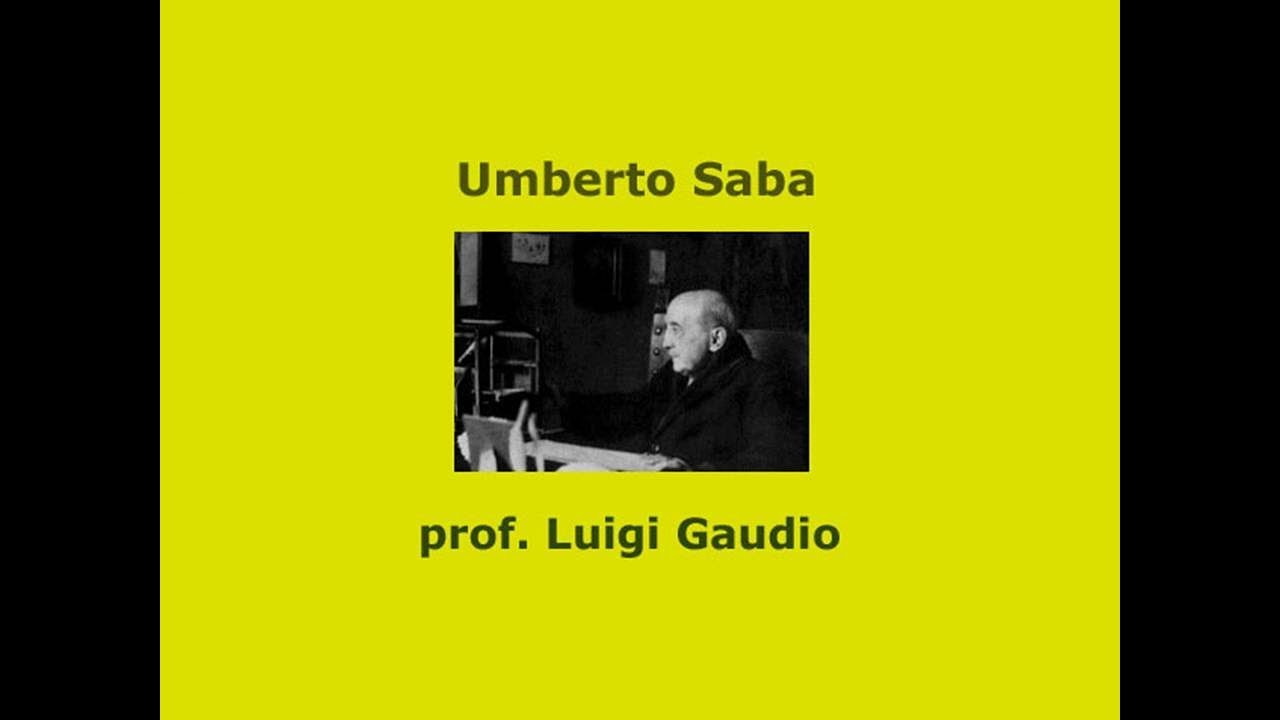
Il borgo di Umberto Saba
1 Agosto 2019
Complementi di rapporto, sostituzione, scambio, esclamativo e altri
1 Agosto 2019Analisi testuale di due terzine da Satura, Xenia II (la 6 e la 8) di Eugenio Montale, che hanno un titolo volutamente ironico e ambiguo: Inferno e Paradiso
Le due terzine di Montale tratte da Satura, Xenia II (6 e 8), rappresentano momenti di straordinaria intensità lirica all’interno del ciclo dedicato alla moglie scomparsa, Drusilla Tanzi, detta “Mosca”. Questi componimenti appartengono alla fase più matura della produzione montaliana, caratterizzata da un linguaggio più colloquiale ma non per questo meno profondo.
Testo delle Terzine
Inferno e Paradiso due poesie di Montale
due terzine da Satura, Xenia II, 6 e 8
6.
Il vinattiere ti versava un poco
d’Inferno. E tu, atterrita: “Devo berlo? Non basta
esserci stati dentro a fuoco lento?”
8.
“E il Paradiso? Esiste un paradiso?” .
“Credo di sì, signora, ma i vini dolci
non li vuol più nessuno” .
Due terzine da Satura, Xenia II, 6, 8

Analisi delle Terzine
Contesto e struttura del ciclo
Gli Xenia costituiscono un dialogo postumo con la moglie defunta, dove Montale rievoca episodi quotidiani trasfigurandoli in riflessione esistenziale. Il titolo richiama i doni ospitali della tradizione classica, qui trasformati in offerte memoriali. La numerazione discontinua (6 e 8) suggerisce una selezione di momenti significativi piuttosto che una narrazione lineare.
Analisi della terzina 6: “Il vinattiere ti versava un poco d’Inferno”
La prima terzina costruisce un parallelismo ironico tra la denominazione commerciale del vino (“Inferno”, probabilmente un vino della Valtellina) e l’esperienza esistenziale della sofferenza. Il vinattiere diventa figura quasi dantesca che offre una bevanda infernale, mentre la reazione della moglie rivela una saggezza acquisita attraverso l’esperienza del dolore. La domanda “Devo berlo?” esprime la riluttanza di chi ha già conosciuto la sofferenza, mentre l’espressione “a fuoco lento” suggerisce un tormento prolungato e domestico, diverso dalle pene dantesche ma altrettanto reale.
Analisi della terzina 8: “E il Paradiso? Esiste un paradiso?”
La seconda terzina sviluppa il contrappunto paradisiaco con identica struttura dialogica. La domanda esistenziale fondamentale (“Esiste un paradiso?”) riceve una risposta che mantiene l’ambiguità tra commercio e metafisica. L’osservazione sui “vini dolci” che “non li vuol più nessuno” funziona su due livelli: quello letterale del cambiamento dei gusti enologici e quello simbolico del disincanto contemporaneo verso le consolazioni tradizionali.
Tecnica poetica e linguaggio
Montale adopera qui il registro medio-basso del linguaggio quotidiano, inserendo termini prosaici (“vinattiere”, “vini dolci”) in un contesto di riflessione ultima sull’esistenza. Questa tecnica, caratteristica della sua produzione tarda, non diminuisce la densità semantica ma la rende più accessibile. Il dialogo riportato crea un effetto di immediatezza che contrasta con la distanza temporale della rievocazione.
Significato filosofico e religioso
Le due terzine affrontano i temi ultimi dell’esistenza umana attraverso la mediazione dell’esperienza coniugale. L’Inferno non è più la dimensione oltremondana dantesca ma la condizione terrena di sofferenza, mentre il Paradiso diventa interrogativo aperto sulla possibilità di consolazione. La risposta del vinattiere/poeta mantiene una posizione agnostica che non esclude ma non afferma, riflettendo la crisi delle certezze nella modernità.
Rapporto con la tradizione dantesca
Il richiamo esplicito all’Inferno e al Paradiso danteschi non costituisce imitazione ma rielaborazione critica. Montale trasferisce la geografia oltremondana nella dimensione esistenziale quotidiana, mostrando come le categorie dantesche mantengano validità antropologica pur perdendo la loro sistemazione teologica. La domesticità del dialogo contrasta volutamente con la solennità del modello.
Posizione nell’opera montaliana
Questi componimenti esemplificano la capacità di Montale di rinnovare il proprio linguaggio poetico senza tradire la profondità della riflessione. La stagione di Satura mostra un poeta che sa utilizzare la quotidianità per toccare i nodi essenziali dell’esistenza, preparando quella che sarà la sua produzione estrema degli anni successivi.
Le due terzine rappresentano quindi un momento di particolare equilibrio tra sperimentazione linguistica e fedeltà ai temi centrali della sua poetica, confermando la capacità di Montale di fare della memoria privata materia di riflessione universale.