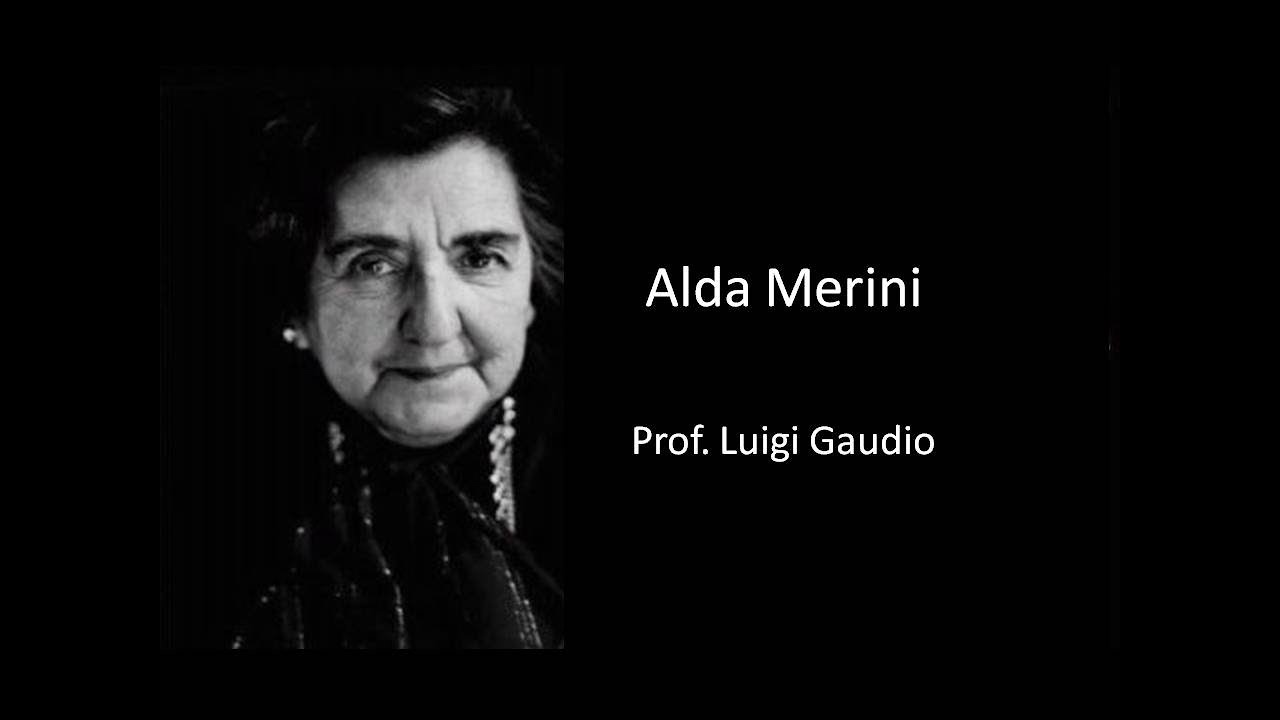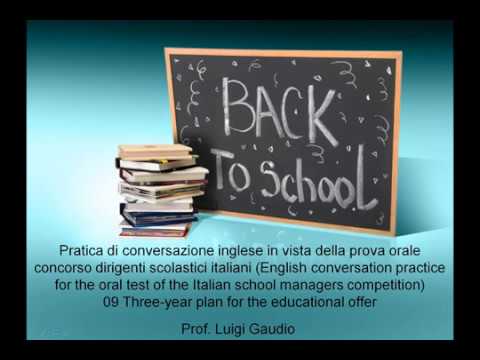
04 Right to education
28 Dicembre 2019
La repubblica ceca: lezione di geografia
28 Dicembre 2019“Il furto della verginità” di Alda Merini: testo, parafrasi e analisi
“Il furto della verginità” è una poesia di Alda Merini (1931-2010), poetessa italiana la cui opera è profondamente segnata dall’esperienza del manicomio, dalla spiritualità tormentata e da una viscerale esplorazione della condizione femminile, della maternità e della sofferenza.
Questo componimento, in particolare, affronta un tema estremamente delicato e doloroso: la violenza sessuale e le sue conseguenze sull’identità, sulla maternità e sul rapporto con il divino.
Questa poesia di Alda Merini affronta con una forza cruda il tema della violenza sessuale e delle sue conseguenze, esplorando la complessità dell’esperienza femminile attraverso la lente della maternità forzata.
1. Testo e Parafrasi della poesia
|
Testo Originale: Il mio primo trafugamento di madre O mai la luna gridò così tanto vedendo la mia verginità di madre Il mio primo trafugamento di donna ma nacque una bimba gentile Ma io non perdonerò mai e affidato a mani più “sante” , |
Parafrasi:
La prima volta che mi fu portata via (rubata) la mia essenza di madre Oh, mai la luna non aveva gridato così forte vedendo la mia innocenza di madre (la mia purezza materna) La prima volta che mi fu portata via (rubata) la mia essenza di donna ma da quell’unione nacque una bambina dolce Ma io non perdonerò mai (quella violenza), e affidato a persone considerate più “pure” o “giuste” (le mani “sante”),
|
2. Analisi del Componimento
2.1 Contesto e Temi Principali
La poesia di Alda Merini è spesso una testimonianza cruda e lirica del dolore, della follia e della sacralità della vita. In questo componimento, i temi centrali sono:
- La Violenza e il Trauma: Il “furto della verginità” è una metafora potente per indicare uno stupro, un atto di violenza che non è solo fisico ma che intacca l’essenza stessa della persona, la sua “verginità di madre” e di “donna”. L’aggressore è un “pazzo”, una figura anonima che incarna la brutalità e l’irrazionalità della violenza.
- La Maternità Violata e Sacra: Il paradosso centrale è la concezione di un figlio da un atto di violenza. La “verginità di madre” è “offesa dentro a un ludibrio”, ma da questo atto nasce una “genesi”, una vita. La maternità, anche se nata da un trauma, è per Merini un evento sacro, che eleva la donna a una dimensione quasi divina (“salii sopra i cieli”).
- Il Non Perdono e l’Oltraggio: Nonostante la nascita della “bimba gentile” sembri portare a un perdono (“e tutto fu perdonato”), la poetessa dichiara un “Ma io non perdonerò mai”. Questo non perdono non è rivolto alla bambina, ma all’atto di violenza e all’ingiustizia subita, in particolare il fatto che il figlio le sia stato “tolto dal grembo” e affidato a “mani più ‘sante'”. La vera “oltraggiata” è lei, la madre che ha dato la vita.
- La Sofferenza Cosmica e Spirituale: Il dolore della poetessa è così immenso da coinvolgere l’intero cosmo: “la luna gridò così tanto / contro le stelle offese”, “gridarono tanto i miei visceri”, e persino “il Signore volse mai il capo all’indietro”. Questa iperbole cosmica eleva il dramma personale a una dimensione universale, suggerendo che la violenza subita è un’offesa all’ordine divino e naturale.
- La Critica Sociale e Istituzionale: L’affidamento del figlio a “mani più ‘sante'” può essere letto come una critica implicita alle istituzioni (religiose o sociali) che, pur autoproclamandosi moralmente superiori, privano la madre del suo diritto naturale sul figlio, perpetrando un ulteriore oltraggio.
2.2 Linguaggio e Stile
- Crudezza e Lirismo: La poesia di Merini è caratterizzata dalla capacità di accostare termini crudi e diretti (“pazzo mi prese”, “visceri”, “ludibrio”) a immagini di grande lirismo e spiritualità (“luna gridò”, “stelle offese”, “verginità di madre”, “salii sopra i cieli”, “genesi”). Questa giustapposizione crea un effetto di potente contrasto e intensità emotiva.
- Immagini Forti e Viscerali: Le immagini sono spesso concrete e legate al corpo e alle sue reazioni (“visceri”, “grembo”, “calore impetuoso del sesso”). La luna e le stelle che “gridano” o sono “offese” sono personificazioni che amplificano il dramma interiore.
- Ossimori e Paradossi: “Verginità di madre offesa” è un ossimoro che esprime la contraddizione della violenza che genera vita. “Vive quando muore” (da un altro componimento, ma un concetto meriniano) è un’idea simile di vita che emerge dalla sofferenza.
- Tono Confessionale e Accusatorio: Il tono è profondamente personale e confidenziale, quasi un’auto-confessione, ma al contempo è accusatorio nei confronti dell’aggressore e del sistema che ha permesso la privazione del figlio.
- Verso Libero: La poesia è scritta in versi liberi, senza rima o schema metrico fisso, il che conferisce un andamento spontaneo e un ritmo dettato dall’emozione e dal flusso del pensiero. Le pause e gli a capo sono funzionali alla respirazione del verso e all’enfasi di determinate parole o concetti.
2.3 Struttura
La poesia si sviluppa in tre sezioni principali, che corrispondono a tre momenti del trauma e della sua elaborazione:
- Prima Sezione (vv. 1-12): Descrizione dell’atto di violenza e della sua risonanza cosmica e interiore. La “verginità di madre” è il fulcro di questa violazione.
- Seconda Sezione (vv. 13-18): Ripetizione del “trafugamento”, ma questa volta come “di donna”, con l’accento sul “calore impetuoso del sesso” e la nascita della “bimba gentile” che sembra portare un perdono.
- Terza Sezione (vv. 19-24): La negazione del perdono da parte della poetessa, la privazione del figlio e la riaffermazione dell’oltraggio subito, nonostante l’atto di “genesi” che l’ha elevata.
3. Conclusione
“Il furto della verginità” è una poesia di Alda Merini che colpisce per la sua forza emotiva e la sua audacia nel trattare un tema così doloroso. Merini non si limita a descrivere la violenza, ma ne esplora le profonde ripercussioni sull’identità femminile, sulla maternità e sulla spiritualità. La sua capacità di fondere la crudezza della realtà con un lirismo intenso e immagini potenti rende il componimento un grido di dolore, di ribellione e, al contempo, un inno alla sacralità della vita che, nonostante tutto, può nascere anche dal più profondo trauma. La poesia è una testimonianza della sua inconfondibile voce, capace di trasformare la sofferenza personale in un’esperienza universale.