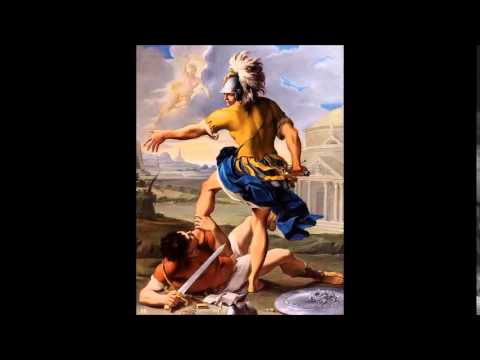
Il duello finale e la morte di Turno, Eneide, XII, 710-885
28 Dicembre 2019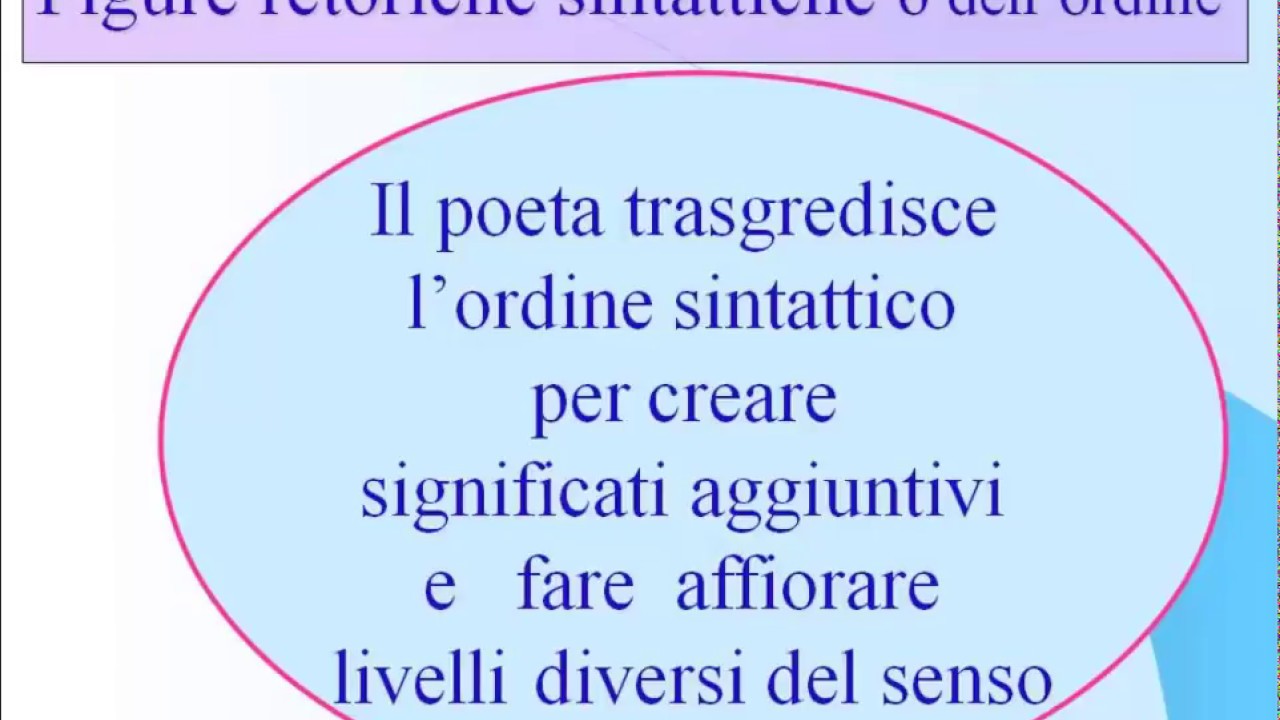
Figure retoriche di suono e di ordine
28 Dicembre 2019L’Ultimo Viaggio di Don Fabrizio dal Gattopardo: la morte come consapevolezza e fine di un mondo
Il brano “La morte del Principe”, che apre il capitolo “Luglio 1883” de Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, è uno dei passaggi più intensi e filosoficamente densi del romanzo. Esso descrive gli ultimi giorni di Don Fabrizio Salina, il protagonista, e in particolare il suo “ultimo viaggio” da Napoli a Palermo, un percorso che è al contempo fisico e spirituale, culminando nella sua lucida consapevolezza dell’imminente fine. La morte del Principe non è solo la fine di un individuo, ma il simbolo della definitiva estinzione di un’intera classe sociale e di un’epoca.
1. La Sensazione della Vita che Scorre: L’Orologio a Sabbia
Il brano si apre con una riflessione profonda e ricorrente di Don Fabrizio sulla propria mortalità:
“Don Fabrizio quella sensazione la conosceva da sempre. Erano decenni che sentiva come il fluido vitale, la facoltà di esistere, la vita insomma, e forse anche la volontà di continuare a vivere, andassero uscendo da lui lentamente ma continuamente, come i granellini si affollano e sfilano ad uno ad uno senza fretta e senza soste dinanzi allo stretto orifizio di un orologio a sabbia.”
Questa similitudine dell’orologio a sabbia è centrale: la vita è un flusso costante che si esaurisce, una perdita graduale ma inarrestabile. Inizialmente, questa percezione non è sgradevole per il Principe; al contrario, è una “prova, la condizione, per così dire, della sensazione di vita”. Per un uomo abituato a scrutare l’infinito (le stelle, il mare), questa “minutissimo sgretolamento della personalità” è quasi una promessa di una “riedificazione altrove di una personalità (grazie a Dio) meno cosciente ma più larga”, un’idea di fusione con l’universo. Egli si sente quasi privilegiato nell’avvertire questa fuga continua, disprezzando chi intorno a lui non la intuisce, come un “soldato anziano” che disprezza il “coscritto” ignaro del pericolo.
2. Il Cambiamento: La Cascata del Reno e la Fine del Corteggiamento
Nel luglio 1883, la sensazione cambia radicalmente. Non è più un lento sfilare di granelli, ma un’eruzione violenta:
“Adesso la faccenda era differente, del tutto diversa. Seduto su una poltrona… sentiva che la vita usciva da lui a larghe ondate incalzanti, con un fragore spirituale paragonabile a quello della cascata del Reno.”
La metafora della cascata del Reno sostituisce quella dell’orologio a sabbia: la morte non è più un corteggiamento, ma un’irruzione fragorosa e inarrestabile. Il “corteggiamento era finito: la bella aveva detto il suo ‘sì’, la fuga decisa, lo scompartimento del treno riservato.” Questa personificazione della morte come una “bella” che finalmente acconsente, con un linguaggio che richiama un appuntamento amoroso, è un esempio della raffinata ironia e del distacco intellettuale di Don Fabrizio.
3. Il Viaggio e la Rivelazione della Diagnosi
Il viaggio da Napoli a Palermo, intrapreso per consultare il professor Sémmola, si rivela un’odissea di sofferenza e rivelazione. È un “viaggio lugubre, lento come una cerimonia funebre”. Le condizioni fisiche di Don Fabrizio peggiorano, e il mondo circostante, con il suo “vocio incessante” e i “paesaggi malefici”, lo esaspera.
La vera diagnosi della sua condizione non gli viene rivelata dal medico con parole dirette, ma gli si manifesta attraverso un’intuizione sottile e dolorosa:
“Fu anzi dal sorriso consolatorio delle persone che lo aspettavano alla stazione, dal loro finto, e mal finto, aspetto rallegrato, che gli si rivelò il vero senso della diagnosi di Sémmola che a lui stesso aveva detto soltanto frasi rassicuranti; e fu allora… che si fece udire il fragore della cascata.”
Il “sorriso consolatorio” e il “finto, e mal finto, aspetto rallegrato” dei familiari sono la prova inequivocabile della sua condanna. La loro pietà, per quanto mascherata, gli comunica la verità che le parole del medico avevano taciuto. È in questo momento di lucidità che il “fragore della cascata” si fa di nuovo udire, confermando l’ineluttabilità della fine.
4. Gli Ultimi Momenti e le Riflessioni sulla Morte
Giunto all’albergo Trinacria, Don Fabrizio è perfettamente lucido. Osserva il nipote Tancredi, la cui “perpetua ironia si era adattata ad esser spazzata via dalla tenerezza”, un segno di affetto che gli conferma la gravità della situazione. L’incontro con il “povero diavolo” di medico di quartiere, un “testimonio impotente di mille agonie miserabili”, è un ulteriore confronto con la realtà della morte e della sofferenza, in contrasto con la sua stessa posizione privilegiata.
Le sue ultime riflessioni si concentrano sulla morte come disfacimento dell’identità:
“Perché mai Dio voleva che nessuno morisse con la propria faccia? Perché a tutti succede così: si muore con una maschera sul volto; anche i giovani; anche quel soldato col viso imbrattato; anche Paolo, quando lo avevano rialzato dal marciapiede con la faccia contratta e spiegazzata…”
La morte impone una “maschera”, una deformazione che cancella i tratti individuali, rendendo tutti uguali nel trapasso. Questa è una riflessione amara sull’annullamento dell’identità di fronte alla fine. Il fragore della vita che fugge dal suo corpo è paragonato al “tumulto di quei serbatoi ancora colmi che si svuotavano in un attimo da quei poveri corpi giovani”, un pensiero che lo lega, in un ultimo atto di empatia, ai giovani caduti in battaglia o per incidenti, la cui vita è stata strappata via con la stessa violenza, ma senza la consapevolezza che lui, vecchio, possiede.
5. Temi Centrali
- La Morte e il Morire: Il tema dominante è la rappresentazione della morte non come evento improvviso, ma come un processo graduale e consapevole, vissuto con lucidità e distacco filosofico.
- La Fine di un’Epoca: La morte di Don Fabrizio è simbolica. Rappresenta la fine del mondo aristocratico siciliano, l’estinzione di una classe sociale che non riesce più ad adattarsi ai tempi.
- Illusioni e Realtà: Il contrasto tra le rassicurazioni e le finzioni sociali e la cruda verità della malattia e della morte, che Don Fabrizio percepisce con acuta intelligenza.
- Solitudine dell’Individuo: La morte è un’esperienza profondamente solitaria, che nessuno può veramente condividere o comprendere appieno.
- Dignità nella Decadenza: Nonostante il declino fisico, Don Fabrizio mantiene una dignità intellettuale e una capacità di osservazione lucida fino all’ultimo.
- Il Corpo e la Coscienza: La distinzione tra il deterioramento fisico e la persistenza di una coscienza acuta e riflessiva.
6. Stile e Linguaggio
- Prosa Lirica e Riflessiva: Il linguaggio è elegante, ricco di metafore e similitudini, che elevano la descrizione della morte a un piano universale e filosofico.
- Flusso di Coscienza: Il brano è permeato dal flusso di pensieri e sensazioni di Don Fabrizio, permettendo al lettore di accedere alla sua interiorità.
- Dettagli Sensoriali: Lampedusa utilizza dettagli visivi (mare immobile, sole perpendicolare), uditivi (fragore della cascata, vocio), e fisici (gambe avviluppate, ansito, sudore) per rendere l’esperienza vivida.
- Ironia e Distacco: Don Fabrizio osserva la sua stessa fine con un’ironia sottile e un distacco intellettuale, che è una sua caratteristica distintiva.
Conclusione
L’ultimo viaggio di Don Fabrizio è un capolavoro di introspezione e di riflessione sulla morte. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, attraverso la figura del Principe, non solo descrive il processo fisico del morire, ma ne esplora le implicazioni filosofiche ed esistenziali. La sua morte, vissuta con lucida consapevolezza e un misto di rassegnazione e dignità, simboleggia la fine di un’era e di un mondo, lasciando al lettore una profonda meditazione sulla caducità della vita e sulla solitudine dell’individuo di fronte al proprio destino.

Testo del brano L’ultimo viaggio di don Fabrizio dal Gattopardo di Tomasi di Lampedusa – “La morte del Principe.“
Luglio 1883
Don Fabrizio quella sensazione la conosceva da sempre. Erano decenni che sentiva come il fluido vitale, la facoltà di esistere, la vita insomma, e forse anche la volontà di continuare a vivere, andassero uscendo da lui lentamente ma continuamente, come i granellini si affollano e sfilano ad uno ad uno senza fretta e senza soste dinanzi allo stretto orifizio di un orologio a sabbia. In alcuni momenti d’intensa attività, di grande attenzione, questo sentimento di continuo abbandono scompariva per ripresentarsi impassibile alla più breve occasione di silenzio o di introspezione: come un ronzio continuo all’orecchio, come il battito di una pendola s’impongono quando tutto il resto tace; ed allora ci rendono sicuri che essi sono sempre stati lí, vigili, anche quando non li udivamo.
In tutti gli altri momenti gli era sempre bastato un minimo di attenzione per avvertire il fruscio dei granelli di sabbia che sgusciavano via lievi, degli attimi di tempo che evadevano dalla sua mente e lo lasciavano per sempre. La sensazione del resto non era, prima, legata ad alcun malessere. Anzi, questa percettibile perdita di vitalità era la prova, la condizione, per così dire, della sensazione di vita; e per lui, avvezzo a scrutare spazi esteriori illimitati, a indagare vastissimi abissi interni, essa non era per nulla sgradevole: era quella di un continuo, minutissimo sgretolamento della personalità congiunto al presagio vago del riedificarsi altrove di una personalità (grazie a Dio) meno cosciente ma più larga. Quei granellini sabbia non andavano perduti, scomparivano ma si accumulavano chissà dove, per cementare una mole più dura tura. Mole, però, aveva riflettuto, non era la parola esatta, pesante come era; e granelli di sabbia, d’altronde, neppure. Erano più come delle particelle di vapor acqueo che esalassero da uno stagno costretto, per andar su nel cielo a formare le grandi nubi leggere e libere. Talvolta era sorpreso che il serbatoio vitale potesse ancora conte nere qualcosa dopo tanti anni di perdite. “Neppure se fosse grande come una piramide.” Tal altra volta, più spesso, si era inorgoglito di esser quasi solo ad avvertire questa fuga continua, mentre attorno a lui nessuno sembrava sentire lo stesso; e ne aveva tratto motivo di disprezzo per gli altri, come il soldato anziano disprezza il coscritto che si illude che le pallottole ronzanti intorno siano dei mosconi innocui. Queste son cose che, non si sa poi perché, non si confessano; si lascia che gli altri le intuiscano e nessuno intorno a lui le aveva intuite mai, nessuna delle figlie che sognavano un oltretomba identico a questa vita, completo di tutto, di magistratura, cuochi e conventi; non Stella che, divorata dalla cancrena del diabete, si era tuttavia aggrappata meschinamente a questa esistenza di pene. Forse solo Tancredi aveva per un attimo compreso, quando gli aveva detto con la sua ritrosa ironia: “Tu, zione, corteggi la morte.” Adesso il corteggiamento era finito: la bella aveva detto il suo “si,” la fuga decisa, lo scompartimento del treno riservato.
Perché adesso la faccenda era differente, del tutto di versa. Seduto su una poltrona, le gambe lunghissime avviluppate in una coperta, sul balcone dell’albergo Trinacria, sentiva che la vita usciva da lui a larghe ondate incalzanti, con un fragore spirituale paragonabile a quello della cascata del Reno. Era il mezzogiorno di un lunedì di fine luglio, ed il mare di Palermo, compatto, oleoso, inerte, si stendeva di fronte a lui, inverosimilmente immobile ed appiattito come un cane che si sforzasse di rendersi invisibile alle minacce del padrone; ma il sole immoto e perpendicolare stava li sopra piantato a gambe larghe, e Io frustava senza pietà. Il silenzio era assoluto. Sotto l’altissima luce don Fabrizio non udiva altro suono che quello interiore della vita che erompeva via da lui.
Era arrivato la mattina da Napoli, poche ore fa; vi si era recato per consultare il professore Sémmola. Accompagnato dalla quarantenne figlia Concetta, dal nipote Fabrizietto, aveva compiuto un viaggio lugubre, lento come una cerimonia funebre. Il tramestio del porto alla par tenza e quello dell’arrivo a Napoli, l’odore acre della cabina, il vocio incessante di quella città paranoica, lo avevano esasperato di quella esasperazione querula dei debolissimi, che li stanca e li prostra, che suscita l’esaspera zione opposta dei buoni cristiani che hanno molti anni di vita nelle bisacce. Aveva preteso di ritornare per via di terra: decisione improvvisa che il medico aveva cercato di combattere; ma lui aveva insistito, e così imponente era ancora l’ombra del suo prestigio che l’aveva spuntata. Col risultato di dover poi rimanere trentasei ore rintanato in una scatola rovente, soffocato dal fumo nelle gallerie che si ripetevano come sogni febbrili, accecato dal sole nei tratti scoperti, espliciti come tristi realtà, umiliato dai cento bassi servizi che aveva dovuto richiedere al nipote spaurito. Si attraversavano paesaggi malefici, giogaie maledette, pianure malariche e torpide; quei panorami calabresi e basilischi che a lui sembravano barbarici, mentre di fatto erano tali e quali quelli siciliani. La linea ferro-viaria non era ancora compiuta: nel suo ultimo tratto vicino a Reggio faceva una larga svolta per Metaponto attraverso plaghe lunari che per scherno portavano i nomi atletici e voluttuosi di Crotone e di Sibari. A Messina poi, dopo il mendace sorriso dello Stretto subito sbugiardato dalle riarse colline peloritane, di nuovo una svolta, lunga come una crudele mora procedurale. Si era discesi a Catania, ci si era arrampicati verso Castrogiovanni: la locomotiva annaspante su per i pendii favolosi sembrava dovesse crepare come un cavallo sforzato; e, dopo una discesa fragorosa, si era giunti a Palermo. All’arrivo le solite maschere di familiari con il dipinto sorriso di compiacimento per il buon esito del viaggio. Fu anzi dal sor riso consolatorio delle persone che lo aspettavano alla sta zione, dal loro finto, e mal finto, aspetto rallegrato, che gli si rivelò il vero senso della diagnosi di Sémmola che a lui stesso aveva detto soltanto frasi rassicuranti; e fu allora, dopo esser sceso dal treno, mentre abbracciava la nuora sepolta nelle gramaglie di vedova, i figli che mostravano i loro denti nei sorrisi, Tancredi con i suoi occhi timorosi, Angelica con la seta del corpetto ben tesa dai seni maturi, fu allora che si fece udire il fragore della cascata.
Probabilmente svenne, perché non ricordava come fosse arrivato alla vettura; si trovò disteso con le gambe rattrappite, col solo Tancredi vicino. La carrozza non si era ancora mossa, e da fuori gli giungeva all’orecchio il parlottare dei familiari. “Non è niente.” “Il viaggio è stato troppo lungo.” “Con questo caldo sveniremmo tutti.” “Arrivare sino alla villa lo stancherebbe troppo.” Era di nuovo perfettamente lucido: notava la conversazione seria che si svolgeva fra Concetta e Francesco Paolo, l’eleganza di Tancredi, il suo vestito a quadretti marrone e bigio, la bombetta bruna; e notò anche come il sorriso del nipote non fosse una volta tanto beffardo, anzi tinto di malinconico affetto; e da questo ricevette la sensazione agrodolce che il nipote gli volesse bene ed anche che sapesse che lui era spacciato, dato che la perpetua ironia si era adattata ad esser spazzata via dalla tenerezza. La carrozza si mosse e svoltò sulla destra. “Ma dove andiamo, Tancredi?” La propria voce lo sorprese. Vi avvertiva il riflesso del rombo interiore. “Zione, andiamo all’albergo Trinacria; sei stanco e la villa è lontana; ti riposerai una notte e do mani tornerai a casa. Non ti sembra giusto?” “Ma allora andiamo alla nostra casa di mare; è ancora più vicina.” Questo però non era possibile: la casa non era montata, come ben sapeva; serviva solo per occasionali colazioni in faccia al mare; non vi era neppure un letto. “All’albergo starai meglio, zio; avrai tutte le comodità.” Lo trattavano come un neonato; di un neonato del resto aveva appunto il vigore.
Un medico fu la prima comodità che trovò all’albergo; era stato fatto chiamare in fretta, forse durante la sua sincope. Ma non era il dottor Cataliotti, quello che sempre lo curava, incravattato di bianco sotto il volto sorridente e i ricchi occhiali d’oro; era un povero diavolo, il medico di quel quartiere angustiato, il testimonio impotente di mille agonie miserabili. Al di sopra della redingote sdrucita si allungava il povero volto emaciato irto di peli bianchi, un volto disilluso di intellettuale famelico; quando estrasse dal taschino l’orologio senza catena si videro le macchie di verderame che avevano trapassato la doratura posticcia. Anche lui era un povero otre che lo sdrucío della mulattiera aveva liso, e che spandeva senza saperlo le ultime gocce di olio. Misurò i battiti del polso, prescrisse delle gocce di canfora, mostrò i denti cariati in un sorriso che voleva essere rassicurante e che invece chiedeva pietà; se ne andò a passi felpati.
Presto dalla farmacia vicina giunsero le gocce; gli fecero bene; si senti un po’ meno debole, ma l’impeto del tempo che gli sfuggiva non diminuì la propria foga.
Don Fabrizio si guardò nello specchio dell’armadio: riconobbe più il proprio vestito che sé stesso: altissimo, allampanato, con le guance infossate, la barba lunga di tre giorni: sembrava uno di quegli inglesi maniaci che deambulano nelle vignette di Verne, che per Natale regalava a Fabrizietto. Un Gattopardo in pessima forma. Perché mai Dio voleva che nessuno morisse con la propria faccia? Perché a tutti succede così: si muore con una maschera sul volto; anche i giovani; anche quel soldato col viso imbrattato; anche Paolo, quando lo avevano rialzato dal marciapiede con la faccia contratta e spiegazzata mentre la gente rincorreva nella polvere il cavallo che lo aveva sbattuto giù. E se in lui, vecchio, il fragore della vita in fuga era tanto potente, quale mai doveva essere stato il tumulto di quei serbatoi ancora colmi che si svuotavano in un attimo da quei poveri corpi giovani?”




