
Giunone evoca la furia Aletto, Eneide, VII, 323-372
28 Dicembre 2019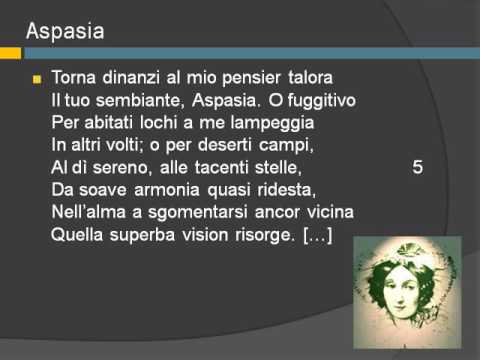
Il ciclo di Aspasia e i canti napoletani
28 Dicembre 2019Biografia del poeta ligure Eugenio Montale, che ha ricoperto il ruolo di modello di poeta novecentesco
Eugenio Montale (Genova, 12 ottobre 1896 – Milano, 12 settembre 1981) è stato uno dei più grandi poeti italiani del Novecento, figura centrale della letteratura europea e Premio Nobel per la Letteratura nel 1975. La sua opera, caratterizzata da una profonda riflessione esistenziale, un linguaggio asciutto e una costante ricerca di senso, ha segnato un’epoca e continua a influenzare generazioni di lettori e scrittori.
Infanzia e Formazione (1896-1925)
Nato a Genova da una famiglia borghese (il padre era un commerciante di prodotti chimici), Montale trascorse l’infanzia e l’adolescenza tra la città e Monterosso al Mare, nelle Cinque Terre, luogo che influenzerà profondamente la sua immaginazione e la sua poetica. La sua salute cagionevole gli impedì di frequentare regolarmente la scuola, ma si dedicò a studi irregolari e autodidatti, coltivando una vasta cultura letteraria e musicale.
Durante la Prima Guerra Mondiale, partecipò come ufficiale di fanteria, esperienza che, pur non essendo centrale nella sua poesia, contribuì a formare la sua visione disincantata del mondo. Dopo la guerra, si dedicò all’attività letteraria, frequentando gli ambienti culturali genovesi e stringendo amicizia con intellettuali come Camillo Sbarbaro e Roberto Bazlen. In questi anni, iniziò a pubblicare le sue prime poesie su riviste.
L’Esordio Poetico e gli Ossi di seppia (1925)
Il 1925 è un anno cruciale per Montale: pubblica la sua prima raccolta di poesie, Ossi di seppia, e firma il Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce, prendendo una chiara posizione contro il regime.
Ossi di seppia rappresenta una rottura con la tradizione poetica precedente (dannunzianesimo e crepuscolarismo), introducendo una lirica caratterizzata da:
- Linguaggio essenziale e scarno: Montale rifugge ogni retorica e ornamento, cercando una precisione quasi scientifica nel vocabolo.
- Paesaggio ligure: La natura aspra e assolata della Liguria diventa una metafora della condizione esistenziale, un “male di vivere” che si manifesta nell’aridità e nella desolazione.
- Correlativo oggettivo: Gli oggetti e i paesaggi non sono solo descritti, ma assumono un valore simbolico, diventando “correlativi oggettivi” di stati d’animo e riflessioni filosofiche.
- Pessimismo esistenziale: La poesia esprime un profondo senso di solitudine, di incomunicabilità e di incapacità di trovare un senso ultimo nell’esistenza.
Il Periodo Fiorentino e le Occasioni (1927-1948)
Nel 1927, Montale si trasferisce a Firenze, dove lavora presso il Gabinetto Vieusseux come direttore della biblioteca. Questo periodo è caratterizzato da un’intensa attività culturale e da importanti amicizie, tra cui quella con Elio Vittorini, Carlo Emilio Gadda e Mario Luzi. A Firenze conosce anche Drusilla Tanzi, che diventerà sua moglie (“Mosca”).
Nel 1939 pubblica la sua seconda raccolta, Le occasioni. In quest’opera, la poesia di Montale si fa più ermetica e complessa, incentrata su “occasioni” che sono momenti epifanici o oggetti che richiamano un significato profondo. La figura femminile (spesso identificata con Clizia, pseudonimo di Irma Brandeis, una studiosa americana) assume un ruolo centrale come “angelo” o “donna-salvatrice”, portatrice di un barlume di speranza in un mondo desolato.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, Montale vive il dramma del conflitto e la caduta del fascismo, mantenendo una posizione di dignità e resistenza morale.
Il Periodo Milanese e la Maturità Poetica (1948-1975)
Nel 1948, Montale si trasferisce a Milano, dove inizia la sua lunga collaborazione con il Corriere della Sera come redattore e critico musicale. Questa attività giornalistica gli permette di mantenere un contatto costante con la realtà e di commentare gli eventi del suo tempo.
Nel 1956 pubblica La bufera e altro, una raccolta che riflette il trauma della guerra e la disillusione del dopoguerra. La poesia si fa più cupa, ma anche più consapevole della propria funzione di testimonianza. La figura di Clizia scompare, sostituita da altre presenze femminili (come Volpe, pseudonimo di Maria Luisa Spaziani).
Seguono altre raccolte importanti:
- Satura (1971): Segna una svolta nella sua poetica. Il tono si fa più prosastico, ironico e disincantato. Montale si confronta con la banalità del quotidiano, con la perdita dei valori e con la decadenza della società contemporanea. Le figure di Mosca (la moglie Drusilla) e di altri familiari assumono un ruolo centrale.
- Diario del ’71 e del ’72 (1973)
- Quaderno di quattro anni (1977)
- Altri versi (postumo, 1981)
Il Premio Nobel e gli Ultimi Anni (1975-1981)
Nel 1975, Eugenio Montale viene insignito del Premio Nobel per la Letteratura con la motivazione: “per la sua poesia distinta da grande complessità artistica e da una grande sensibilità, che ha interpretato i valori umani in una prospettiva senza illusioni”. Il riconoscimento internazionale consolida la sua fama e lo consacra come uno dei massimi poeti del XX secolo.
Negli ultimi anni della sua vita, Montale continua a scrivere, pur con un tono sempre più intimo e riflessivo, segnato dalla vecchiaia e dalla consapevolezza della fine. Muore a Milano il 12 settembre 1981.
L’Eredità Poetica
La poesia di Eugenio Montale è un’indagine costante sulla condizione umana, sulla fragilità dell’esistenza e sulla ricerca di un “varco” in un mondo privo di certezze. Il suo stile, inizialmente ermetico e poi più colloquiale e ironico, ha sempre mantenuto una straordinaria coerenza e profondità. Montale ha saputo esprimere il “male di vivere” e la “disarmonia” del mondo moderno, ma anche la dignità della resistenza e la bellezza di un’esistenza vissuta con consapevolezza, lasciando un’eredità poetica che continua a interrogarci e a commuoverci.





