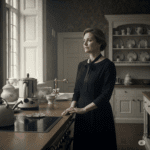
Un fiocco nero di Hans Christian Andersen
28 Dicembre 2019
Canto ventiquattresimo del Paradiso
28 Dicembre 2019Analisi e testo dei capitoli XXV e XXVI de “Il Principe” di Niccolò Machiavelli, con un focus, approfondimento sui concetti di Virtù e Fortuna e sullo stile dell’opera.
Analisi dei Capitoli XXV e XXVI de “Il Principe” di Niccolò Machiavelli
Questi due capitoli, posti alla fine de “Il Principe”, sono cruciali per comprendere appieno il pensiero di Machiavelli e la sua visione sulla politica, la storia e il destino umano. Essi rappresentano un tentativo di conciliare la visione realistica e pragmatica del potere con un appello appassionato per la redenzione dell’Italia.
CAPITOLO XXV: Quanto possa nelle umane cose la fortuna, e in che modo se gli possa ostare.
Questo capitolo affronta uno dei temi più dibattuti e affascinanti del pensiero machiavelliano: il rapporto tra Fortuna e Virtù.
- La Fortuna come Fiume Rovinoso: Machiavelli riconosce che molti credono che la vita sia interamente governata dalla fortuna e da Dio, rendendo inutile l’azione umana. Egli stesso ammette di essere in parte incline a questa visione, data l’imprevedibilità degli eventi. Tuttavia, per non annullare il libero arbitrio umano, propone una mediazione: la fortuna controlla metà delle nostre azioni, mentre l’altra metà è lasciata al nostro governo. Machiavelli usa una potente metafora: la fortuna è come un fiume rovinoso che, quando si adira, allaga e distrugge. Però, egli argomenta, quando il tempo è quieto, gli uomini possono costruire argini e ripari per contenerne l’impeto. Questo significa che, pur non potendo controllare la fortuna stessa, l’uomo virtuoso può prepararsi e prevenire i suoi effetti distruttivi.
- La Virtù come Argine: La chiave per opporsi alla fortuna è la Virtù. La fortuna mostra la sua potenza dove non trova una virtù organizzata a resisterle. L’Italia, in questo senso, è vista come una “campagna senza argini e senza alcun riparo”, a differenza di paesi come la Germania, la Spagna o la Francia, che, grazie alla loro virtù (intesa come organizzazione politica e militare), hanno saputo contenere le “inondazioni” della fortuna.
- Adattamento ai Tempi: Un altro punto cruciale è l’importanza di adattare il proprio modo di procedere alla qualità dei tempi. Un Principe può essere felice se il suo comportamento (impetuoso o rispettoso/cauto) si conforma ai tempi, e infelice se c’è discordanza. Machiavelli illustra questo concetto con l’esempio di Papa Giulio II, un uomo impetuoso che ebbe successo perché i tempi erano propizi al suo agire ardito. Se avesse dovuto affrontare tempi che richiedevano cautela, la sua natura ostinata lo avrebbe portato alla rovina. Questo mostra una profonda intuizione psicologica: gli uomini sono spesso incapaci di deviare dalla loro natura o dai metodi che hanno avuto successo in passato.
- La Fortuna è Donna: Il capitolo si chiude con una delle metafore più celebri e controverse: la Fortuna è donna. E come tale, per tenerla “sotto”, è necessario “batterla e urtarla”. Machiavelli suggerisce che la fortuna si lascia vincere più dagli uomini audaci e impetuosi, che da quelli che procedono con fredda cautela. Per questo, è “amica dei giovani”, che sono meno rispettivi, più feroci e più audaci nel comandarla. Questa immagine riflette il pragmatismo machiavelliano e la sua tendenza a usare metafore vivide per rendere i suoi concetti più incisivi.
CAPITOLO XXVI: Esortazione a liberare la Italia da’ barbari.
Questo capitolo è una vera e propria esortazione e un appello finale alla Casa Medici (all’epoca Lorenzo de’ Medici il Giovane) affinché assuma il compito di liberare l’Italia dal dominio straniero.
- L’Italia come Materia Pronta: Machiavelli sostiene che mai come in quel momento vi è stata un’occasione più propizia per un Principe nuovo e virtuoso di agire in Italia. Paragonando la situazione dell’Italia a quella degli Ebrei schiavi in Egitto sotto Mosè, dei Persiani oppressi dai Medi sotto Ciro, o degli Ateniesi dispersi sotto Teseo, egli descrive l’Italia come “più schiava che gli Ebrei, più serva che i Persi, più dispersa che gli Ateniesi, senza capo, senz’ordine, battuta, spogliata, lacera, corsa”. Questa immagine drammatica serve a sottolineare che la condizione di estrema sofferenza e disordine è la materia ideale su cui un grande Principe può mostrare la sua virtù e operare una redenzione.
- La Volontà di Dio e il Libero Arbitrio: Sebbene Machiavelli abbia accennato a “spiraculi” (segnali divini) di una possibile redenzione, egli insiste che Dio non vuole fare tutto, “per non ci torre il libero arbitrio, e parte di quella gloria che tocca a noi”. Questo rafforza l’idea che, pur essendoci un disegno divino, l’azione umana e la virtù sono indispensabili per il successo. La giustizia della causa è immensa: “quella guerra è giusta, che gli è necessaria; e quelle armi sono pietose, dove non si spera in altro, che in elle”.
- La Debolezza Militare Italiana: Machiavelli individua la causa della rovina italiana nella debolezza dei capi e nella mancanza di ordinamenti militari propri. Gli Italiani, seppur superiori individualmente in duelli, falliscono come esercito a causa della mancanza di un’unica guida e di una disciplina efficace. L’autore ribadisce l’importanza delle armi proprie come “vero fondamento d’ogni impresa”, sottolineando che soldati fedeli e valorosi nascono solo se comandati dal loro Principe e da lui onorati.
- Un Nuovo Ordine Militare: Machiavelli propone la possibilità di creare un nuovo ordine militare che possa superare i difetti delle fanterie svizzere (deboli contro la cavalleria) e spagnole (che non temono i fanti ma sono vulnerabili ai cavalieri). Non è la generazione delle armi, ma la “variazione degli ordini” che darà reputazione e grandezza a un nuovo Principe.
- L’Appello Finale: Il capitolo si chiude con un vibrante appello alla Casa Medici, esortandola a non lasciarsi sfuggire questa occasione storica. Machiavelli prevede con quale amore un liberatore sarebbe accolto dal popolo italiano, stanco del “barbaro dominio”. Il capitolo si conclude con una citazione dai Canzonieri di Petrarca: “Virtù contro al furore / Prenderà l’armi, e fia il combatter corto; / Chè l’antico valore / Negli Italici cuor non è ancor morto.” Questa chiusura poetica e patriottica eleva il tono dell’opera, trasformandola da trattato politico a manifesto per la rinascita italiana.
Lo Stile de “Il Principe”
Lo stile di Machiavelli ne “Il Principe” è distintivo e riflette il suo approccio pragmatico e razionale alla politica.
- Prosa Chiaro e Incisiva: Machiavelli adotta una prosa diretta, concisa e priva di fronzoli. Il suo obiettivo è comunicare idee complesse con la massima chiarezza e efficacia. Non si perde in digressioni retoriche o ornamentali, ma va dritto al punto.
- Lessico Specifico e Tecnico: Il linguaggio è quello della ragion di Stato, con termini precisi e spesso “tecnici” della politica e della guerra dell’epoca (es. “ordini”, “milizia”, “provvisioni”, “rispetti”, “impeto”).
- Costruzione Logica e DIMOSTRATIVA: Il testo è costruito con una rigorosa logica deduttiva. Machiavelli parte da un’affermazione generale, la supporta con argomentazioni e esempi storici o contemporanei (come quello di Papa Giulio II), e poi trae delle conclusioni. L’andamento è quasi scientifico, basato sull’osservazione della realtà (“la verità effettuale della cosa”).
- Uso di Esempi Storici e Contemporanei: Per rafforzare le sue tesi, Machiavelli ricorre costantemente a esempi tratti dalla storia antica (Mosè, Ciro, Teseo) e dalla politica del suo tempo (Giulio II, i principi italiani). Questi esempi non sono solo illustrativi, ma servono come prove empiriche delle sue teorie.
- Metafore e Similitudini Efficaci: Sebbene la prosa sia asciutta, Machiavelli utilizza metafore potenti e memorabili che rendono i suoi concetti più vividi e comprensibili (la fortuna come fiume rovinoso, la fortuna come donna).
- Tono Persuasivo e Pragmatico: Il tono generale è quello di un consigliere che si rivolge al Principe con l’obiettivo di istruirlo sul modo migliore di mantenere e accrescere il potere. È un tono pragmatico, a volte cinico, ma sempre finalizzato all’efficacia politica. Nel capitolo XXVI, il tono diventa anche passionale ed esortativo, rivelando il profondo patriottismo di Machiavelli.
In sintesi, lo stile di Machiavelli è funzionale al suo scopo: analizzare la politica in modo realistico e fornire indicazioni pratiche per l’azione, senza lasciarsi influenzare da moralismi astratti, ma con un occhio sempre attento alla “verità effettuale” e alla salvezza dello Stato.

Testo dei Capitoli XXV e XXVI de “Il Principe” di Niccolò Machiavelli
CAPITOLO XXV.
Quanto possa nelle umane cose la fortuna, e in che modo se gli possa ostare.
Non mi è incognito, come molti hanno avuto e hanno opinione, che le cose del mondo siano in modo governate dalla fortuna, e da Dio, che gli uomini con la prudenza loro non possino correggerle, anzi non vi abbino rimedio alcuno; e per questo potrebbono giudicare che non fusse da insudare molto nelle cose, ma lasciarsi governare dalla sorte. Questa opinione è suta più creduta ne’ nostri tempi per la variazione delle cose grandi che si sono viste, e veggonsi ogni dì fuori di ogni umana coniettura. A che pensando io qualche volta, sono in qualche parte inchinato nella opinione loro. Nondimanco, perchè il nostro libero arbitrio non sia spento, giudico potere esser vero, che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che ancora ella ne lasci governare l’altra metà, o poco meno, a noi. Ed assomiglio quella ad fiume rovinoso, che quando ei si adira, allaga i piani, rovina gli arbori e gli edifici, lieva da questa parte terreno, ponendolo a quell’altra; ciascuno gli fugge davanti, ognuno cede al suo furore, senza potervi ostare; e benchè sia così fatto, non resta però che gli uomini, quando sono tempi quieti, non vi possino fare provvedimenti e con ripari, e con argini, immodochè crescendo poi, o egli andrebbe per un canale, o l’impeto suo non sarebbe sì licenzioso, nè sì dannoso.
Similmente interviene della fortuna, la quale dimostra la sua potenzia dove non è ordinata virtù a resistere, e quivi volta i suoi impeti, dove la sa che non sono fatti gli argini, nè i ripari a tenerla. E se voi considererete l’Italia, che è la sede di queste variazioni, e quella che ha dato loro il moto, vedrete essere una campagna senza argini, e senza alcun riparo. Che se la fusse riparata da conveniente virtù, come è la Magna, la Spagna, e la Francia, questa inondazione non avrebbe fatto le variazioni grandi che l’ha, o la non ci sarebbe venuta. E questo voglio basti aver detto quanto all’opporsi alla fortuna in universale. Ma restringendomi più al particulare, dico, come si vede oggi questo Principe felicitare, e domani rovinare, senza vederli aver mutato natura o qualità alcuna. Il che credo nasca prima dalle cagioni che si sono lungamente per lo addietro trascorse; cioè, che quel Principe che si appoggia tutto in sulla fortuna, rovina come quella varia. Credo ancora, che sia felice quello, il modo del cui procedere suo si riscontra con la qualità de’ tempi, e similmente sia infelice quello, dal cui procedere si discordano i tempi. Perchè si vede gli uomini nelle cose che gl’inducono al fine, quale ciascuno ha innanzi, cioè gloria e ricchezze, procedervi variamente, l’uno con rispetti, l’altro con impeto; l’uno per violenza, l’altro per arte; l’uno con pazienza, l’altro col suo contrario; e ciascuno con questi diversi modi vi può pervenire. E vedesi ancora dui respettivi, l’uno pervenire al suo disegno, l’altro no; e similmente duoi equalmente felicitare con due diversi studi, essendo l’uno respettivo, l’altro impetuoso; il che non nasce da altro, se non da qualità di tempi che si conformino o no col procedere loro.
Di qui nasce quello ho detto che dui, diversamente operando, sortiscano il medesimo effetto; e dui equalmente operando, l’uno si conduce al suo fine, l’altro no. Da questo ancora dipende la variazione del bene; perchè se a uno, che si governa con rispetto e pazienza, i tempi e le cose girano in modo che il governo suo sia buono, esso viene felicitando; ma se li tempi e le cose si mutano, egli rovina, perchè non muta modo di procedere. Nè si trova uomo sì prudente, che si sappi accordare a questo, sì perchè non si può deviare da quello, a che la natura l’inclina; sì ancora perchè avendo sempre uno prosperato camminando per una via, non si può persuadere, che sia bene partirsi da quella; e però l’uomo rispettivo, quando gli è tempo di venire all’impeto non lo sa fare; donde egli rovina; che se si mutasse natura con li tempi e con le cose, non si muterebbe fortuna. Papa Iulio II procedette in ogni sua cosa impetuosamente, e trovò tanto i tempi e le cose conformi a quel suo modo di procedere, che sempre sortì felice fine. Considerate la prima impresa che fece di Bologna, vivendo ancora Messer Giovanni Bentivogli. I Viniziani non se ne contentavano, il Re di Spagna similmente con Francia aveva ragionamento di tale impresa; e lui nondimanco con la sua ferocità ed impeto si mosse personalmente a quella espedizione, la qual mossa fece star sospesi e fermi e Spagna, e i Viniziani; quelli per paura, quell’altro per il desiderio di ricuperare tutto il Regno di Napoli; e dall’altra parte si tirò dietro il Re di Francia, perchè vedutolo quel Re mosso, e desiderando farselo amico per abbassare i Viniziani, giudicò non poterli negare le sue genti senza ingiuriarlo manifestamente.
Condusse adunque Iulio con la sua mossa impetuosa quello che mai altro Pontefice con tutta l’umana prudenza non avria condutto; perchè se egli aspettava di partirsi da Roma con le conclusione ferme, e tutte le cose ordinate, come qualunque altro Pontefice arebbe fatto, mai non gli riusciva. Perchè il Re di Francia avria trovate mille scuse, e gli altri gli arebbero messo mille paure. Io voglio lasciare stare le altre sue azioni, che tutte sono state simili, e tutte gli sono successe bene, e la brevità della vita non gli ha lasciato sentire il contrario; perchè se fussero sopravvenuti tempi che fosse bisognato procedere con rispetti, ne seguiva la sua rovina; perchè mai non arebbe deviato da quelli modi, a’ quali la natura lo inchinava. Conchiudo adunque, che, variando la fortuna, e gli uomini stando nei loro modi ostinati, sono felici mentre concordano insieme, e come discordano sono infelici. Io giudico ben questo, che sia meglio essere impetuoso, che rispettivo, perchè la Fortuna è donna; ed è necessario, volendola tener sotto, batterla, ed urtarla; e si vede che la si lascia più vincere da questi che da quelli che freddamente procedono. E però sempre, come donna, è amica de’ giovani, perchè sono meno rispettivi, più feroci, e con più audacia la comandano.
CAPITOLO XXVI.
Esortazione a liberare la Italia da’ barbari.
Considerato adunque tutte le cose di sopra discorse, e pensando meco medesimo se al presente in Italia correvano tempi da onorare un Principe nuovo, e se ci era materia che desse occasione a uno prudente e virtuoso d’introdurvi nuova forma, che facesse onore a lui, e bene alla università degli uomini di quella, mi pare concorrino tante cose in beneficio d’un Principe nuovo, che non so qual mai tempo fusse più atto a questo. E se, come io dissi, era necessario, volendo vedere la virtù di Moisè, che il popolo d’Istrael fusse schiavo in Egitto, ed a conoscere la grandezza e l’animo di Ciro, che i Persi fussero oppressi da’ Medi, e ad illustrare l’eccellenza di Teseo, che gli Ateniesi fussero dispersi; così al presente, volendo conoscere la virtù di uno spirito Italiano, era necessario che l’Italia si conducesse ne’ termini presenti, e che la fusse più schiava che gli Ebrei, più serva che i Persi, più dispersa che gli Ateniesi, senza capo, senz’ordine, battuta, spogliata, lacera, corsa, ed avesse sopportato di ogni sorta rovine.
E benchè infino a qui si sia mostro qualche spiraculo in qualcuno da poter giudicare che fusse ordinato da Dio per sua redenzione; nientedimanco si è visto come dipoi nel più alto corso delle azioni è stato dalla fortuna reprobato in modo, che, rimasa come senza vita, aspetta qual possa esser quello che sani le sue ferite, e ponga fine alle direpzioni, e a’ sacchi di Lombardia, alle espilazioni, e taglie del Reame, e di Toscana, e la guarisca di quelle sue piaghe già per lungo tempo infistolite.
Vedesi come la prega Dio che gli mandi qualcuno che la redima da queste crudeltà ed insolenzie barbare. Vedesi ancora tutta pronta e disposta a seguire una bandiera, purchè ci sia alcuno che la pigli. Nè si vede al presente in quale la possa più sperare che nella illustre Casa Vostra, la quale con la sua virtù e fortuna, favorita da Dio e dalla Chiesa, della quale è ora Principe, possa farsi capo di questa redenzione. E questo non vi sarà molto difficile, se vi recherete innanzi le azioni e vite de’ soprannominati. E benchè quelli uomini siano rari e maravigliosi; nondimeno furono uomini, ed ebbe ciascuno di loro minore occasione, che la presente; perchè l’impresa loro non fu più giusta di questa, nè più facile; nè fu Dio più a loro amico, che a voi. Qui è giustizia grande, perchè quella guerra è giusta, che gli è necessaria; e quelle armi sono pietose, dove non si spera in altro, che in elle.
Qui è disposizione grandissima; nè può essere, dove è grande disposizione, grande difficultà; purchè quella pigli delli ordini di coloro che io vi ho proposto per mira. Oltre a questo, qui si veggono straordinari senza esempio, condutti da Dio: il mare s’è aperto, una nube vi ha scorto il cammino, la pietra ha versato l’acqua; qui è piovuto la manna, ogni cosa è concorsa nella vostra grandezza; il rimanente dovete far voi. Dio non vuole far ogni cosa, per non ci torre il libero arbitrio, e parte di quella gloria che tocca a noi. E non è maraviglia, se alcuno de’ prenominati Italiani non ha possuto far quello che si può sperare facci la illustre Casa Vostra, e se in tante revoluzioni d’Italia, e in tanti maneggi di guerra, e’ pare sempre che in quella la virtù militare sia spenta; perchè questo nasce che gli ordini antichi di quella non erano buoni, e non ci è suto alcuno che abbia saputo trovare de’ nuovi.
Nessuna cosa fa tanto onore ad uno uomo che di nuovo surga, quanto fanno le nuove leggi e nuovi ordini trovati da lui. Queste cose quando sono ben fondate, ed abbino in loro grandezza, lo fanno reverendo e mirabile, e in Italia non manca materia da introdurvi ogni forma. Qui è virtù grande nelle membra, quando ella non mancasse ne’ capi. Specchiatevi nelli duelli, e nei congressi de’ pochi, quanto gl’Italiani siano superiori con le forze, con la destrezza, con l’ingegno. Ma come si viene agli eserciti, non compariscono; e tutto procede dalla debolezza de’ capi, perchè quelli che sanno, non sono ubbedienti, ed a ciascuno par sapere, non ci essendo infino a qui suto alcuno che si sia rilevato tanto e per virtù e per fortuna, che gli altri cedino. Di qui nasce che in tanto tempo, in tante guerre fatte ne’ passati venti anni, quando gli è stato un esercito tutto Italiano, sempre ha fatto mala prova; di che è testimone prima il Taro, dipoi Alessandria, Capua, Genova, Vailà, Bologna, Mestri.
Volendo dunque la illustre Casa Vostra seguitare quelli eccellenti uomini, che redimerono le provincie loro, è necessario innanzi a tutte le altre cose, come vero fondamento d’ogni impresa, provvedersi d’armi proprie; perchè non si può avere nè più fidi, nè più veri, nè migliori soldati. E benchè ciascuno di essi sia buono, tutti insieme diventeranno migliori, quando si vedranno comandare dal loro Principe, e da quello onorare ed intrattenere.
È necessario pertanto prepararsi a queste armi, per potersi con virtù Italiana difendere dagli esterni. E benchè la fanteria Svizzera, e Spagnuola sia stimata terribile; nondimanco in ambedue è difetto, per il quale uno ordine terzo potrebbe non solamente opporsi loro, ma confidare di superargli. Perchè gli Spagnuoli non possono sostenere i cavalli, e gli Svizzeri hanno ad aver paura de’ fanti, quando gli riscontrino nel combattere ostinati come loro. Donde si è veduto, e vedrassi per isperienza, gli Spagnuoli non poter sostenere una cavalleria Francese, e gli Svizzeri essere rovinati da una fanteria Spagnuola. E benchè di questo ultimo non se ne sia vista intera sperienza; nientedimeno se ne è veduto uno saggio nella giornata di Ravenna, quando le fanterie Spagnuole si affrontarono con le battaglie Tedesche, le quali servano il medesimo ordine che i Svizzeri, dove gli Spagnuoli con l’agilità del corpo, e aiuti de’ loro brocchieri erano entrati tra le picche loro sotto, e stavano sicuri ad offendergli, senza che li Tedeschi vi avessino rimedio; e se non fusse la cavalleria che gli urtò, gli arebbono consumati tutti.
Puossi adunque, cognosciuto il difetto dell’una e dell’altra di queste fanterie, ordinarne una di nuovo, la quale resista a’ cavalli, e non abbia paura de’ fanti; il che lo farà non la generazione delle armi, ma la variazione degli ordini. E queste sono di quelle cose che di nuovo ordinate danno riputazione, e grandezza a un Principe nuovo. Non si deve adunque lasciar passare questa occasione, acciocchè la Italia vegga dopo tanto tempo apparire un suo redentore. Nè posso esprimere con quale amore ei fussi ricevuto in tutte quelle provincie che hanno patito per queste illuvioni esterne, con qual sete di vendetta, con che ostinata fede, con che pietà, con che lacrime. Quali porte se gli serrerebbono? Quali popoli li negherebbono la obbidienza? Quale invidia se gli opporrebbe? Quale Italiano gli negherebbe l’ossequio? Ad ognuno puzza questo barbaro dominio. Pigli adunque la illustre Casa Vostra questo assunto con quello animo, e con quelle speranze che si pigliano l’imprese giuste, acciocchè sotto la sua insegna questa patria ne sia nobilitata, e sotto i suoi auspicii si verifichi quel detto del Petrarca:
-
- Virtù contro al furore
- Prenderà l’armi, e fia il combatter corto;
- Chè l’antico valore
- Negli Italici cuor non è ancor morto.




