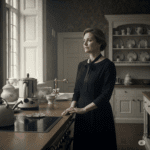
Un fiocco nero di Hans Christian Andersen
28 Dicembre 2019
Canto ventiquattresimo del Paradiso
28 Dicembre 2019Scomparsa e Ritorno del Teatro: Una Storia Ciclica
La storia del teatro è un flusso continuo di nascite, apogei, declini e rinascite. Lungi dall’essere una linea retta di sviluppo, la sua presenza e la sua forma nella società hanno subito profonde trasformazioni, spesso in risposta a mutamenti culturali, religiosi, politici ed economici. Parlare di “scomparsa” del teatro può sembrare eccessivo, data la sua resilienza, ma ci sono stati periodi in cui la sua funzione, la sua struttura e la sua visibilità pubblica sono state drasticamente ridimensionate, solo per riemergere in nuove e spesso sorprendenti vesti.
1. L’Antichità: Apogeo e Declino
Il teatro nasce e fiorisce nell’Antichità classica, in particolare nell’antica Grecia, dove raggiunge vette artistiche e filosofiche con la tragedia e la commedia. Era un’istituzione civica e religiosa fondamentale, parte integrante della vita della polis. Anche a Roma, pur con caratteristiche diverse (più orientato allo spettacolo e al divertimento), il teatro godeva di grande popolarità.
- Apogeo: Grecia (V-IV sec. a.C.) con Eschilo, Sofocle, Euripide, Aristofane; Roma (III sec. a.C. – IV sec. d.C.) con Plauto, Terenzio, Seneca.
- Declino: Con la crisi e la caduta dell’Impero Romano d’Occidente (V secolo d.C.) e l’affermarsi del Cristianesimo, il teatro classico subisce un forte declino. La Chiesa condanna gli spettacoli teatrali per la loro immoralità, la loro associazione con culti pagani e la loro natura spesso licenziosa. Gli attori vengono emarginati, le grandi strutture teatrali cadono in disuso o vengono distrutte.
2. Il Medioevo: La “Scomparsa” del Teatro Professionale e la Sua Rinascita Religiosa
Il Medioevo è spesso considerato un periodo di “scomparsa” del teatro nel senso classico e professionale del termine. Tuttavia, il bisogno umano di narrazione, rappresentazione e ritualità non svanisce, ma si trasforma e si rifugia in nuove forme.
- Periodo di “Scomparsa”: Non esistono più compagnie teatrali professionali stabili o grandi edifici dedicati. La drammaturgia classica è dimenticata o condannata.
- Ritorno in Nuove Forme:
- Dramma Liturgico: Il teatro rinasce all’interno della Chiesa stessa. Dalle semplici interpolazioni dialogate nelle liturgie pasquali e natalizie (Tropi), si sviluppano veri e propri drammi sacri rappresentati nelle chiese, che gradualmente escono all’esterno (sagrati, piazze).
- Sacre Rappresentazioni e Misteri: Nel Basso Medioevo, si affermano le Sacre Rappresentazioni (in Italia) e i Misteri (in Francia, Inghilterra), spettacoli di argomento biblico o agiografico, spesso di grande complessità scenica e durata, rappresentati da confraternite laiche.
- Forme Popolari: Accanto al teatro religioso, sopravvivono e si sviluppano forme di spettacolo itinerante e popolare: giullari, mimi, cantastorie, saltimbanchi, che portano intrattenimento nelle piazze e nelle corti, mantenendo viva una tradizione performativa.
3. Il Rinascimento: La Grande Riscoperta e la Professionalizzazione
Il Rinascimento segna una vera e propria rinascita del teatro classico e la sua progressiva professionalizzazione, gettando le basi per il teatro moderno.
- Riscoperta Classica: Si riscoprono i testi greci e latini, si studiano le teorie di Aristotele e Vitruvio sulla drammaturgia e l’architettura teatrale. Sorgono i primi teatri moderni (es. Teatro Olimpico di Vicenza).
- Nascita della Commedia dell’Arte: In Italia, a metà del XVI secolo, nasce la Commedia dell’Arte, un fenomeno teatrale rivoluzionario. Basata sull’improvvisazione (su canovacci), su personaggi fissi (le maschere) e sull’abilità degli attori professionisti, è la prima forma di teatro a pagamento e itinerante, che si diffonde in tutta Europa.
- Teatro di Corte e Accademico: Nelle corti rinascimentali fiorisce un teatro colto, spesso legato a feste e celebrazioni, con l’uso di scenografie elaborate e macchine teatrali.
- Drammaturgia Nazionale: In Inghilterra (Shakespeare), Spagna (Lope de Vega, Calderón de la Barca) e Francia (Molière, Racine, Corneille), si sviluppano grandi drammaturgie nazionali che definiscono i generi e le forme del teatro moderno.
4. Epoche Successive: Crisi, Riforme e Nuove Voci
Nei secoli successivi, il teatro continua a evolversi, affrontando nuove sfide e trovando nuove espressioni.
- Illuminismo e Riforma: Il XVIII secolo vede riforme del teatro (es. Goldoni in Italia) che mirano a una maggiore verosimiglianza, a testi scritti e a una critica sociale attraverso la commedia.
- Romanticismo e Rivoluzioni: Il teatro romantico esalta la libertà creativa, il dramma storico e l’espressione delle passioni individuali. Tuttavia, periodi di rivoluzioni e guerre possono portare a chiusure temporanee o a un ridimensionamento dell’attività teatrale.
- Naturalismo e Verismo: Nel XIX secolo, il teatro si fa più attento alla realtà sociale, ai problemi quotidiani e alla psicologia dei personaggi.
- Avanguardie del XX Secolo: Di fronte all’emergere di nuovi media (cinema, radio, TV), il teatro si interroga sulla propria identità, dando vita a movimenti d’avanguardia (futurismo, espressionismo, teatro dell’assurdo) che sperimentano nuove forme, linguaggi e ruoli dell’attore e dello spettatore.
5. Il Teatro Contemporaneo: Sfide e Resilienza
Nell’era digitale, il teatro affronta la sfida della competizione con media sempre più pervasivi, ma dimostra una straordinaria capacità di adattamento e rinnovamento.
- Competizione Mediatica: Cinema, televisione e internet offrono intrattenimento a basso costo e di facile accesso, mettendo a dura prova la frequentazione dei teatri.
- Nuove Forme e Linguaggi: Il teatro contemporaneo sperimenta con il teatro immersivo, il teatro partecipativo, il teatro-danza, le performance art, l’uso delle nuove tecnologie, cercando nuove modalità di interazione con il pubblico e di espressione artistica.
- Teatro Sociale e Politico: Molte compagnie utilizzano il teatro come strumento di denuncia sociale, di inclusione e di riflessione sui problemi contemporanei.
- Resilienza e Unicità: Nonostante le sfide, il teatro mantiene la sua unicità nell’essere un evento “qui e ora”, irripetibile, che crea una relazione diretta e viva tra attori e spettatori. La sua natura effimera e la sua capacità di affrontare temi complessi in modo diretto e provocatorio ne garantiscono la sopravvivenza.
Conclusione
La storia del teatro è una testimonianza della sua intrinseca vitalità e della sua capacità di adattarsi e reinventarsi. Nonostante periodi di oscurità o di marginalizzazione, il teatro non è mai veramente “scomparso”, ma ha sempre trovato il modo di riemergere, spesso in forme inattese, per continuare a svolgere la sua funzione essenziale: quella di specchio della società, di luogo di riflessione, di emozione e di incontro umano. La sua ciclicità è la prova della sua eterna necessità.
I Benefici della Mandragola di Niccolò Machiavelli
La Mandragola, scritta da Niccolò Machiavelli tra il 1518 e il 1520, è considerata uno dei capolavori della commedia rinascimentale italiana e una delle opere teatrali più significative di tutti i tempi. Lungi dall’essere una semplice farsa, la commedia è un’acuta e spietata analisi della società fiorentina del suo tempo e, per estensione, della natura umana. I suoi “benefici” non risiedono in un messaggio morale edificante, ma nella sua straordinaria capacità di smascherare le ipocrisie, le debolezze e le astuzie degli uomini, offrendo una lezione di realismo politico e psicologico in chiave comica.
1. La Critica della Corruzione Morale e Sociale
La Mandragola è un affresco impietoso della società fiorentina dell’epoca, ma i vizi che essa mette in scena sono universali. Machiavelli espone senza veli la corruzione morale che permea ogni strato sociale:
- L’avidità e la stoltezza della borghesia: Messer Nicia, il marito di Lucrezia, è l’emblema della stupidità e della vanità borghese. La sua ossessione per avere un figlio lo rende cieco e facilmente manipolabile, disposto a credere a qualsiasi inganno pur di raggiungere il suo scopo.
- La corruzione del clero: Fra Timoteo è forse il personaggio più cinico e scandaloso. Uomo di chiesa, è facilmente corrompibile con il denaro, disposto a piegare la morale e la religione ai propri interessi, diventando complice di un inganno sacrilego. La sua figura è una satira feroce della degenerazione morale di parte del clero rinascimentale.
- L’ipocrisia e l’opportunismo generale: Tutti i personaggi, a vario titolo, agiscono per interesse personale, celando le loro vere intenzioni dietro una facciata di rispettabilità o ingenuità.
2. Il Realismo Psicologico dei Personaggi
Uno dei maggiori “benefici” della Mandragola è la sua straordinaria profondità psicologica. I personaggi, pur essendo tipi comici, sono dotati di una verosimiglianza sorprendente, rivelando motivazioni complesse e spesso contraddittorie.
- Callimaco: Il giovane innamorato, non è un eroe romantico, ma un astuto manipolatore, disposto a tutto pur di soddisfare la sua passione.
- Ligurio: Il parassita e mezzano, è il vero motore dell’azione. La sua intelligenza e la sua capacità di tessere intrighi lo rendono un maestro della manipolazione, un “virtuoso” nel senso machiavelliano.
- Lucrezia: La moglie virtuosa e onesta, inizialmente reticente e timorosa, viene infine convinta dalla madre e dal confessore a cedere. La sua trasformazione, da donna timorata di Dio a complice attiva dell’inganno, è uno degli aspetti più inquietanti e realistici della commedia, mostrando come anche la virtù possa essere piegata dalle circostanze e dalla pressione sociale.
3. La Satira Affilata e Dissacrante
Machiavelli utilizza la commedia per una satira pungente e dissacrante.
- Satira religiosa: La figura di Fra Timoteo è una critica feroce alla corruzione della Chiesa e alla mercificazione della fede. Il suo cinismo e la sua capacità di giustificare ogni azione con pretesti religiosi sono un attacco diretto all’ipocrisia ecclesiastica.
- Satira sociale: La commedia si prende gioco delle convenzioni sociali, della credulità popolare e della superficialità della nobiltà e della borghesia.
- Satira della medicina: La “cura” con la mandragola è una parodia delle pratiche mediche dell’epoca, spesso basate su superstizioni e ciarlatanerie.
4. L’Applicazione dei Principi Machiavelliani
La Mandragola è spesso vista come un’applicazione pratica dei principi esposti da Machiavelli nel Principe.
- La “Virtù” (Astuzia) e la “Fortuna”: I personaggi che trionfano (Callimaco e Ligurio) sono quelli che possiedono la “virtù” machiavelliana, intesa come astuzia, determinazione e capacità di adattarsi alle circostanze per raggiungere i propri scopi. Essi sanno cogliere l’occasione offerta dalla “fortuna” (la credulità di Nicia, la disponibilità di Fra Timoteo).
- Il Fine Giustifica i Mezzi: La commedia dimostra come, per raggiungere un obiettivo (il piacere di Callimaco, il denaro di Ligurio e Fra Timoteo), si possano utilizzare l’inganno, la menzogna e la manipolazione, senza alcun riguardo per la moralità.
- La Conoscenza della Natura Umana: Machiavelli rivela una profonda e disillusa conoscenza della natura umana, fatta di egoismo, vizi e debolezze, che possono essere sfruttati da chi è più scaltro.
5. Il Capolavoro Comico e Stilistico
Oltre ai suoi contenuti profondi, La Mandragola è un “beneficio” per la sua eccellenza artistica.
- Costruzione Perfetta: La trama è ingegnosa, con un meccanismo comico impeccabile, un crescendo di situazioni paradossali e un finale che chiude il cerchio in modo beffardo.
- Dialoghi Brillanti: I dialoghi sono serrati, vivaci, ricchi di arguzia e di un linguaggio che mescola il fiorentino colto con espressioni popolari e proverbi.
- Comicità Amara: La comicità non è mai fine a sé stessa, ma è sempre intrisa di un’amarezza di fondo, di una riflessione sulla miseria morale dell’uomo.
- Attualità: Nonostante sia ambientata nel Cinquecento, la commedia mantiene una sorprendente attualità, poiché i vizi e le dinamiche umane che descrive sono senza tempo.
Conclusione
La Mandragola di Niccolò Machiavelli è un’opera che offre molteplici “benefici” al lettore e allo spettatore, nonché alla rinascita del teatro professionale. Non si tratta di benefici morali nel senso tradizionale, ma di una profonda e spesso scomoda lezione di realismo. La commedia ci costringe a guardare in faccia la corruzione, l’ipocrisia e la manipolazione che possono permeare le relazioni umane e le istituzioni. Attraverso la sua satira acuta e la sua brillante costruzione comica, Machiavelli ci invita a una riflessione disincantata sulla natura umana e sui meccanismi del potere, rendendo La Mandragola un classico intramontabile che continua a illuminare le zone d’ombra della nostra società.




