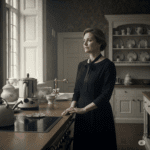
Un fiocco nero di Hans Christian Andersen
28 Dicembre 2019
Canto ventiquattresimo del Paradiso
28 Dicembre 2019La Mandragola di Niccolò Machiavelli è un capolavoro della commedia rinascimentale che, al di là della trama apparentemente semplice di un inganno amoroso, offre una profonda e disincantata analisi della natura umana e dei meccanismi del potere.
1. Ligurio: Il Maestro dell’Inganno e la Comicità della Manipolazione
Ligurio è il vero artefice della beffa, un parassita intelligente e senza scrupoli, la cui astuzia machiavelliana è costantemente in azione. I suoi dialoghi con Messer Nicia sono un esempio perfetto di come l’ambiguità e la comicità sottile si fondano per rivelare la stupidità del vecchio e la maestria del manipolatore.
Esempio 1: L’Introduzione della “Cura” (Atto II, Scena II)
Ligurio, dopo aver convinto Nicia a consultare Callimaco (travestito da medico), inizia a preparare il terreno per la “cura” con la mandragola. La sua abilità sta nel presentare l’inganno come una soluzione scientifica e inevitabile, sfruttando la vanità e l’ignoranza di Nicia.
LIGURIO:
“Egli è un uomo che ha studiato a Parigi, e che ha fatto grandissimi studi in medicina, e sa tutte le cose del mondo. E io vi dico che questa è la via, e non un’altra.”
MESSER NICIA:
“Oh, se è così, io mi rimetto a voi. Purché io abbia un figliuolo, io farò ogni cosa.”
Qui la comicità nasce dalla totale fiducia di Nicia in Ligurio e nel presunto sapere di Callimaco. Ligurio non dice esplicitamente che la cura è la mandragola, ma la introduce come “la via”, una soluzione unica e infallibile, giocando sull’ansia di Nicia. L’ambiguità sta nel fatto che Nicia non capisce che “la via” è in realtà un inganno.
Esempio 2: La Spiegazione del “Sacrificio” (Atto III, Scena IV)
Ligurio e Callimaco devono convincere Nicia che il primo uomo che giacerà con Lucrezia dopo la pozione di mandragola morirà. Ligurio orchestra la scena con maestria, usando un linguaggio pseudo-scientifico e religioso per terrorizzare Nicia e renderlo complice della scelta di un “sostituto”.
LIGURIO:
“Bisogna che il primo che abbia a giacere con lei, dopo che ella avrà preso la pozione, muoia infra otto giorni. E questo è il beneficio della mandragola.”
MESSER NICIA:
“Ohimè! E che faremo noi?”
LIGURIO:
“Non dubitate. Noi troveremo uno che per amore del bene comune si sacrifichi. È cosa di poco momento, e a lui sarà fatto onore.”
L’ambiguità è lampante: Ligurio presenta la morte del “sacrificato” come un “beneficio” della mandragola, una conseguenza necessaria e quasi onorevole. La “comicità sottile” sta nel vedere Nicia accettare questa logica perversa, pur di avere un figlio, e nel modo in cui Ligurio minimizza la morte di un uomo come “cosa di poco momento”. Nicia è così accecato dal suo desiderio che non coglie l’assurdità e la crudeltà della proposta.
2. Messer Nicia: La Stoltezza e la Comicità Involontaria
Messer Nicia è la vittima perfetta dell’astuzia di Ligurio. La sua stoltezza, la sua vanità e la sua ossessione per la prole lo rendono un personaggio intrinsecamente comico, ma anche patetico. La sua incapacità di comprendere le allusioni e le menzogne di Ligurio genera situazioni di grande ilarità.
Esempio: La Scena della Riconoscenza (Atto V, Scena VI)
Dopo che l’inganno è riuscito e Callimaco ha giaciuto con Lucrezia (con la benedizione di Nicia, che credeva fosse un poveraccio destinato a morire), Nicia è al colmo della felicità e della gratitudine.
MESSER NICIA:
“Oh, Ligurio mio, voi siete stato la salute mia! E voi, Maestro Callimaco, voi siete un santo uomo! Io vi giuro che io vi terrò sempre per mio padre e mio fratello. E voi, Lucrezia, non vi pare che noi si debba far onore a questi uomini che ci hanno fatto tanto bene?”
La comicità è amara: Nicia ringrazia i suoi ingannatori, che hanno appena violato sua moglie, credendoli i suoi salvatori. L’ambiguità è che il “bene” di cui parla Nicia è in realtà il “male” che gli è stato fatto, ma che lui percepisce come un trionfo. Lucrezia, ormai complice, risponde con un’acquiescenza che nasconde la sua nuova consapevolezza e la sua trasformazione.
3. Lucrezia: La Virtù Sconfitta e l’Ambiguità del Finale
Lucrezia è inizialmente il simbolo della virtù e dell’onestà. La sua resistenza all’inganno è forte, ma viene progressivamente erosa dalla pressione combinata della madre (Sostrata) e del confessore (Fra Timoteo), entrambi manipolati da Ligurio. La sua trasformazione nel finale è uno degli aspetti più complessi e ambiguamente comici della commedia.
Esempio: La Conversione di Lucrezia (Atto III, Scena XI)
Dopo le insistenze di Sostrata e le subdole argomentazioni di Fra Timoteo, Lucrezia cede, accettando di sottoporsi alla “cura” e di giacere con lo sconosciuto.
LUCREZIA:
“Poiché voi volete, io farò. Ma io non credo che questo sia bene, né che Dio mi perdonerà.”
FRA TIMOTEO:
“Figliuola, voi fate benissimo. La coscienza è una cosa vana. Non dubitate, io vi assolvo da ogni peccato.”
Qui l’ambiguità è nella “conversione” di Lucrezia. La sua frase “Poiché voi volete, io farò” mostra una rassegnazione più che una vera convinzione, ma è sufficiente per gli ingannatori. La comicità sottile è nella facilità con cui Fra Timoteo, con la sua cinica assoluzione (“La coscienza è una cosa vana”), dissolve ogni scrupolo morale. La virtù di Lucrezia non è vinta dalla passione, ma dalla pressione sociale e dalla manipolazione religiosa, un commento amaro sulla fragilità della moralità.
Esempio 2: L’Accettazione Finale (Atto V, Scena VI)
Nel finale, dopo la notte trascorsa con Callimaco, Lucrezia ha un monologo che rivela la sua completa trasformazione.
LUCREZIA:
“Poiché la tua astuzia, la stoltezza di mio marito, e la semplicità di mia madre, e la malizia di frate Timoteo, mi hanno condotta a fare quello che mai per me medesima arei fatto, io voglio credere che questo sia una disposizione del cielo, e non voglio pensare che sia male. E però, poiché tu sei stato mio marito, io ti prendo per signore e padrone, e voglio che tu venga a casa mia ogni volta che tu vorrai.”
Questo brano è il culmine dell’astuzia in scena e della comicità amara. Lucrezia, con una logica quasi machiavelliana, razionalizza l’accaduto come una “disposizione del cielo”, accettando la sua nuova condizione. La sua frase “io ti prendo per signore e padrone” è un’accettazione non solo dell’amante, ma del nuovo ordine delle cose. La comicità sta nel ribaltamento totale della sua moralità iniziale, avvenuto con una sorprendente rapidità e giustificato da una pseudo-provvidenza. È un finale che non offre redenzione, ma una lucida e cinica accettazione della realtà.
Conclusione
La Mandragola è un esempio magistrale di come Machiavelli utilizzi l’astuzia come motore narrativo e come strumento di analisi sociale. I dialoghi tra Ligurio, Messer Nicia e Lucrezia sono intrisi di ambiguità e comicità sottile, che emergono dalla disparità di intelligenza tra i personaggi e dalla loro capacità (o incapacità) di manipolare la realtà. La commedia non mira a far ridere di gusto, ma a sorridere amaramente di fronte alla natura umana, così facilmente corruttibile e così desiderosa di autoingannarsi. È una lezione di realismo che, attraverso la finzione scenica, svela le verità più scomode della società e dell’animo umano.




