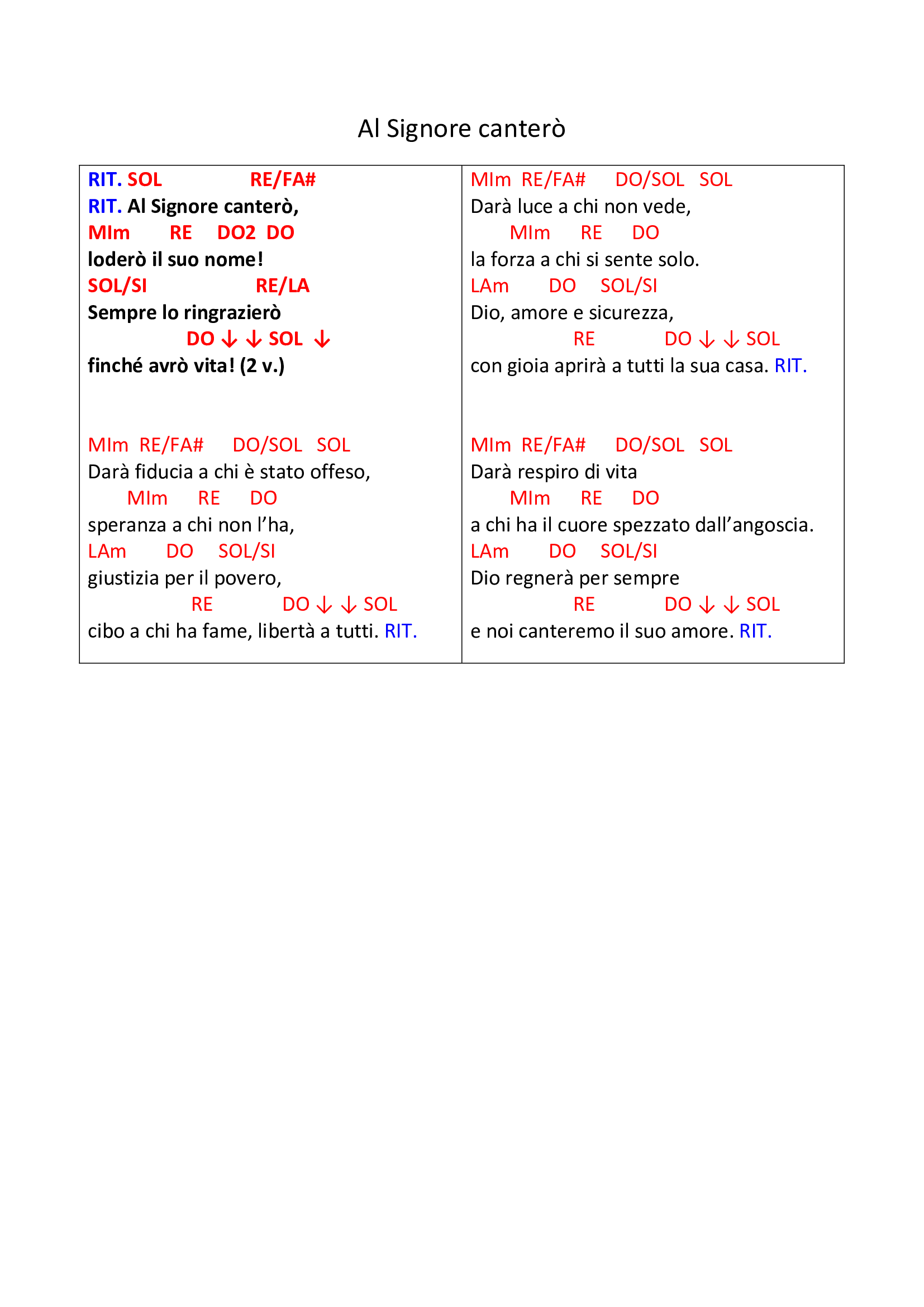
Al Signore canterò
28 Dicembre 2019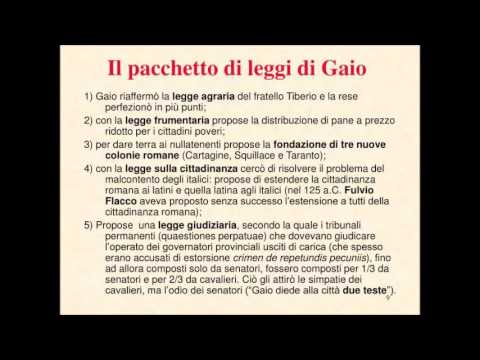
Le riforme dei Gracchi seconda parte: Caio Gracco
28 Dicembre 2019Analisi e testo dei primi 36 versi del Canto undicesimo del Paradiso
Il Canto XI del Paradiso si apre con una solenne e amara invettiva di Dante contro la “insensata cura de’ mortali”, ovvero le vane preoccupazioni terrene che distolgono gli uomini dalla vera beatitudine. Successivamente, il canto si sposta nel cielo del Sole, dove il beato che ha parlato nel canto precedente (San Tommaso d’Aquino) si prepara a sciogliere un dubbio di Dante, introducendo la lode di San Francesco d’Assisi, figura centrale per comprendere la Provvidenza divina.
1. L’Invettiva Contro le Vane Cure Terrene (vv. 1-12)
Il canto si apre con una forte apostrofe di Dante, che esprime il suo sdegno per la condotta degli uomini sulla terra, che si affannano dietro a beni effimeri e illusori.
O insensata cura de’ mortali, quanto son difettivi silogismi quei che ti fanno in basso batter l’ali! (vv. 1-3)
Dante definisce le preoccupazioni umane come “insensata cura” e “difettivi silogismi” (ragionamenti fallaci), che costringono l’anima a “batter l’ali in basso”, cioè a rimanere ancorata alla terra, impedendole di elevarsi verso Dio.
Il poeta elenca una serie di attività terrene che gli uomini perseguono con affanno, ma che sono tutte vane se paragonate alla beatitudine celeste:
Chi dietro a iura e chi ad amforismi sen giva, e chi seguendo sacerdozio, e chi regnar per forza o per sofismi, e chi rubare e chi civil negozio, chi nel diletto de la carne involto s’affaticava e chi si dava a l’ozio, (vv. 4-9)
Qui si delineano diverse categorie di uomini:
- Chi insegue la legge (iura) e la medicina (amforismi – aforismi di Ippocrate).
- Chi cerca il sacerdozio (la carriera ecclesiastica).
- Chi ambisce a regnare con la forza o con l’inganno (sofismi).
- Chi si dedica al furto o agli affari civili (civil negozio).
- Chi è immerso nei piaceri carnali (diletto de la carne) o chi si abbandona all’ozio.
Tutte queste attività, per quanto diverse, sono accomunate dalla loro vanità e dal fatto di distogliere l’uomo dalla vera meta.
Persone affaccendate in diverse attività mondane, che simboleggiano le “insensate cure de’ mortali”.
Il contrasto con la condizione di Dante è netto: mentre gli uomini si affannano sulla terra, lui è stato accolto gloriosamente in cielo con Beatrice.
quando, da tutte queste cose sciolto, con Bëatrice m’era suso in cielo cotanto glorïosamente accolto. (vv. 10-12)
Questo sottolinea la superiorità del percorso spirituale di Dante rispetto alle ambizioni terrene.
2. Il Ritorno dei Beati e la Preparazione al Discorso (vv. 13-18)
Dopo l’invettiva, la scena torna nel cielo del Sole. I beati, che nel canto precedente formavano una corona danzante, riprendono la loro posizione.
Poi che ciascuno fu tornato ne lo punto del cerchio in che avanti s’era, fermossi, come a candellier candelo. (vv. 13-15)
Si fermano immobili, come candele su un candeliere, pronti ad ascoltare. La luce di San Tommaso si fa più intensa, segno della sua volontà di parlare e della verità che sta per rivelare.
E io senti’ dentro a quella lumera che pria m’avea parlato, sorridendo incominciar, faccendosi più mera: (vv. 16-18)
La “lumera” (luce) di San Tommaso, che aveva già parlato, comincia a sorridere e a farsi più “mera” (pura, luminosa), indicando la sua gioia nel condividere la conoscenza divina.
Luci brillanti che formano un cerchio, che rappresentano i beati nel cielo del Sole.
3. Il Dubbio di Dante e l’Introduzione della Provvidenza (vv. 19-36)
San Tommaso, leggendo i pensieri di Dante nella luce divina, si prepara a sciogliere un suo dubbio.
«Così com’ io del suo raggio resplendo, sì, riguardando ne la luce etterna, li tuoi pensieri onde cagioni apprendo. (vv. 19-21)
Tommaso spiega di poter leggere i pensieri di Dante perché riflette il raggio della luce eterna di Dio. Il dubbio di Dante riguarda due affermazioni fatte in precedenza da Tommaso stesso, nel Canto X, sulla decadenza dell’ordine domenicano:
Tu dubbi, e hai voler che si ricerna in sì aperta e ’n sì distesa lingua lo dicer mio, ch’al tuo sentir si sterna, ove dinanzi dissi: “U’ ben s’impingua”, e là u’ dissi: “Non nacque il secondo”; e qui è uopo che ben si distingua. (vv. 22-27)
Le due frasi sono:
- “U’ ben s’impingua” (Paradiso X, v. 96): si riferisce a coloro che, nell’ordine domenicano, si dedicano alla speculazione teologica con profitto spirituale. Il dubbio di Dante è come questo possa conciliarsi con la critica alla decadenza dell’ordine.
- “Non nacque il secondo” (Paradiso X, v. 114): si riferisce a San Domenico, di cui non è nato un “secondo” uguale a lui, implicando che l’ordine non ha saputo mantenere la sua purezza originaria.
Per sciogliere questi dubbi, Tommaso introduce il concetto di Provvidenza Divina, che governa il mondo con un “consiglio” (disegno) imperscrutabile per la mente umana.
La provedenza, che governa il mondo con quel consiglio nel quale ogne aspetto creato è vinto pria che vada al fondo, (vv. 28-30)
Questa Provvidenza, per favorire la “sposa” di Cristo (la Chiesa), che Egli “disposò col sangue benedetto” (la fondò con il suo sacrificio), ordinò due “principi” (fondatori di ordini mendicanti) che le fossero di guida.
però che andasse ver’ lo suo diletto la sposa di colui ch’ad alte grida disposò lei col sangue benedetto, in sé sicura e anche a lui più fida, due principi ordinò in suo favore, che quinci e quindi le fosser per guida. (vv. 31-36)
Questi due principi sono San Francesco d’Assisi e San Domenico di Guzmán, che saranno i protagonisti delle lodi incrociate nei canti XI e XII. La loro missione è quella di sostenere la Chiesa, che rischia di deviare dal suo “diletto” (Cristo).
La Chiesa come sposa di Cristo, con due figure (San Francesco e San Domenico) che la guidano, che rappresenta il disegno della Provvidenza.
4. Temi Principali
- Vanità delle Cure Terrene: L’invettiva iniziale condanna le ambizioni mondane che distolgono l’uomo dalla vera felicità spirituale.
- La Provvidenza Divina: Il tema centrale del canto, che spiega come Dio intervenga nella storia umana per guidare la Chiesa e l’umanità.
- La Chiesa: Presentata come la “sposa” di Cristo, che necessita di guida per rimanere fedele al suo sposo.
- L’Ordine Domenicano e Francescano: Vengono introdotti i due ordini mendicanti come strumenti della Provvidenza per sostenere la Chiesa.
- Luce e Conoscenza: La luce dei beati e la capacità di Tommaso di leggere i pensieri di Dante sottolineano la natura della conoscenza in Paradiso, che è diretta e immediata.
5. Stile e Linguaggio
- Tono Solenne e Didattico: Il canto ha un tono elevato, sia nell’invettiva iniziale che nell’esposizione teologica.
- Metafore: La metafora marinaresca (“piccioletta barca”, “legno”, “pelago”, “solco”) è centrale nel proemio.
- Linguaggio Preciso e Concettuale: Soprattutto nella parte teologica, il linguaggio è rigoroso e preciso, tipico di Tommaso d’Aquino.
- Sintassi Complessa: La sintassi è elaborata, con subordinate e inversioni, che riflettono la complessità del pensiero.
- Rima: Il canto è in terzine incatenate (ABA BCB CDC), la forma metrica della Commedia.
Conclusione
I primi 36 versi del Canto XI del Paradiso fungono da ponte tra la contemplazione dei beati nel cielo del Sole e l’inizio delle lodi dei due grandi fondatori di ordini mendicanti. L’invettiva iniziale di Dante contro le illusioni terrene prepara il terreno per la rivelazione del disegno della Provvidenza, che interviene nella storia attraverso figure come San Francesco e San Domenico per guidare la Chiesa. Il canto si preannuncia come una profonda riflessione sulla storia della Chiesa e sul ruolo dei santi, il tutto immerso nella luce e nella conoscenza divina del Paradiso.

Testo originale di Paradiso, Canto XI, vv. 1-36 di Dante Alighieri
Dante Alighieri – Divina Commedia
Paradiso – Canto XI
(Argomento: San Tommaso d’Aquino celebra la vita di San Francesco e critica i frati che non seguono il suo esempio.)
Testo del Canto
1-3
«O insensata cura de’ mortali,
quanto son difettivi silogismi
quei che ti fanno in basso batter l’ali!»
4-9
(Dante critica le vanità umane:)
«Chi dietro a iura e chi ad amforismi
sen giva, e chi seguendo sacerdozio,
e chi regnar per forza o per sofismi,
e chi rubare e chi civil negozio,
chi nel diletto de la carne involto
s’affaticava e chi si dava a l’ozio»
10-12
(Contrasto con la beatitudine celeste:)
«quando, da tutte queste cose sciolto,
con Bëatrice m’era suso in cielo
cotanto glorïosamente accolto.»
13-18
(San Tommaso, nella luce dei beati, inizia a parlare:)
«Poi che ciascuno fu tornato ne lo
punto del cerchio in che avanti s’era,
fermossi, come a candellier candelo.
E io senti’ dentro a quella lumera
che pria m’avea parlato, sorridendo
incominciar, faccendosi più mera»
19-27
(San Tommaso spiega la Provvidenza divina:)
«”Così com’ io del suo raggio resplendo,
sì, riguardando ne la luce etterna,
li tuoi pensieri onde cagioni apprendo.
Tu dubbi, e hai voler che si ricerna
in sì aperta e ’n sì distesa lingua
lo dicer mio, ch’al tuo sentir si sterna,
ove dinanzi dissi: ‘U’ ben s’impingua’,
e là u’ dissi: ‘Non nacque il secondo’;
e qui è uopo che ben si distingua.”»
28-36
(Dio ordina due guide per la Chiesa: San Francesco e San Domenico:)
«”La provedenza, che governa il mondo
con quel consiglio nel quale ogne aspetto
creato è vinto pria che vada al fondo,
però che andasse ver’ lo suo diletto
la sposa di colui ch’ad alte grida
disposò lei col sangue benedetto,
in sé sicura e anche a lui più fida,
due principi ordinò in suo favore,
che quinci e quindi le fosser per guida.”»
Struttura e note
-
Versi 1-12: Dante condanna le ambizioni terrene, contrapponendole alla pace celeste.
-
Versi 13-27: San Tommaso, tra i beati, legge nel pensiero di Dante e si prepara a chiarire i suoi dubbi.
-
Versi 28-36: Introduzione al tema centrale del canto: la Provvidenza divina che manda San Francesco e San Domenico come guide della Chiesa.
Lessico chiave
-
“Silogismi difettivi” (v. 2): Ragionamenti umani fallaci.
-
“Lumera” (v. 16): La luce di San Tommaso, simbolo di sapienza.
-
“Due principi” (v. 35): Francesco (povertà) e Domenico (dottrina), pilastri della Chiesa.
Approfondimenti
-
San Francesco: La sua vita sarà narrata nei versi successivi (qui solo anticipata).
-
Critica ai frati: Il canto sottolinea la corruzione degli ordini monastici del tempo.




