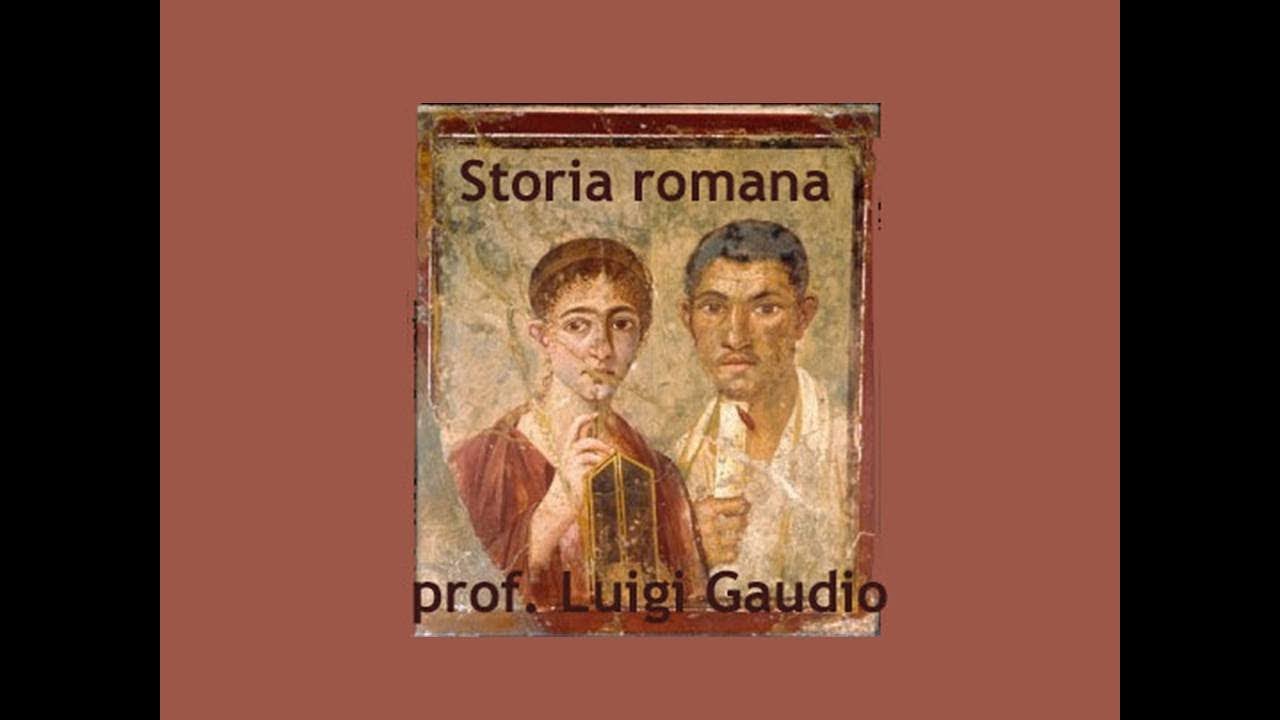Participio presente e perfetto latino
28 Dicembre 2019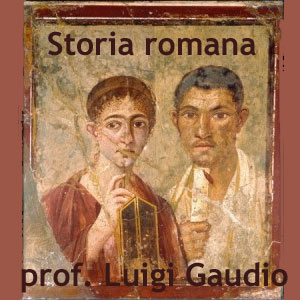
Una innovativa concezione di cittadinanza nella Antica Roma Repubblicana
28 Dicembre 2019La Prima Guerra Punica si concluse nel 241 a.C. con la vittoria di Roma e un trattato di pace che impose a Cartagine condizioni onerose.
Tuttavia, i diciassette anni che seguirono non furono un periodo di vera serenità, ma piuttosto una “pace precária”, un intervallo carico di tensioni e di nuove mosse strategiche da parte di entrambe le potenze, che avrebbero inevitabilmente condotto allo scoppio della Seconda Guerra Punica.
1. Il Peso della Sconfitta su Cartagine
La sconfitta nella Prima Guerra Punica lasciò Cartagine in una situazione disastrosa, alimentando un profondo risentimento:
- Crisi Finanziaria e Rivolta dei Mercenari: Le ingenti indennità di guerra imposte da Roma misero a dura prova le finanze cartaginesi. Questo portò a una grave rivolta dei mercenari (241-238 a.C.), che Cartagine aveva difficoltà a pagare. Questa rivolta, narrata anche da Polibio, fu estremamente violenta e minacciò l’esistenza stessa della città.
- L’Umiliazione di Sardegna e Corsica (237 a.C.): Roma, approfittando della debolezza di Cartagine impegnata a sedare la rivolta dei mercenari, impose con la forza la cessione anche della Sardegna e della Corsica. Questa annessione (che diventarono la seconda provincia romana) fu percepita dai Cartaginesi come un sopruso inaccettabile e una profonda umiliazione, in quanto avvenne senza un nuovo conflitto e violava lo spirito del trattato di pace.
- L’Ascesa dei Barcidi: In questo clima di risentimento, emerse la famiglia dei Barcidi, in particolare Amilcare Barca (già un valoroso generale nella Prima Guerra Punica) e in seguito i suoi figli. Essi divennero i portabandiera di una politica di rivincita e ricostruzione della potenza punica.
Mappa del Mediterraneo dopo la Prima Guerra Punica: la Sicilia è romana, ma Cartagine è ancora una potenza.
2. L’Espansione Cartaginese in Spagna: Una Nuova Base di Potere
Con le rotte marittime del Mediterraneo orientale sotto il controllo romano e la perdita delle isole, Cartagine guardò a occidente, verso la Penisola Iberica (l’attuale Spagna).
- Obiettivi: La Spagna offriva immense risorse:
- Miniere d’Argento: Essenziali per rifornire le casse dello stato e pagare l’indennità a Roma.
- Manodopera e Soldati: Un bacino inesauribile di guerrieri da arruolare negli eserciti cartaginesi.
- Basi Operative: La possibilità di creare una solida base territoriale, lontana dall’influenza diretta di Roma in Italia.
- Protagonisti:
- Amilcare Barca (237-229 a.C.): Sbarcò in Spagna e iniziò una metodica campagna di conquista e organizzazione dei territori meridionali, fondando città e stringendo alleanze.
- Asdrubale (229-221 a.C.): Subentrato ad Amilcare, continuò l’espansione, fondando Cartagena (Nova Carthago), una nuova capitale punica in Spagna, e siglando con Roma il Trattato dell’Ebro (226 a.C.). Questo trattato stabiliva che l’influenza cartaginese non dovesse superare il fiume Ebro a nord.
- Annibale (dal 221 a.C.): Alla morte di Asdrubale, il comando passò al giovane e carismatico Annibale, figlio di Amilcare. Annibale aveva giurato odio eterno a Roma fin da bambino e vedeva nella Spagna la base per una futura rivincita. La sua politica aggressiva fu la causa diretta dello scoppio del secondo conflitto.
Annibale Barca, il giovane generale che ereditò l’odio per Roma e l’ambizione di Cartagine in Spagna.
3. Le Mosse di Roma e le Prime Tensioni
Anche Roma non rimase inattiva in questo periodo, consolidando la sua egemonia in Italia e proiettandosi verso nuove aree di influenza:
- Consolidamento in Italia: Roma si dedicò alla sottomissione delle popolazioni celtiche della Pianura Padana (Galli Cisalpini) e all’espansione verso l’Adriatico, sconfiggendo i Pirati Illiri e stabilendo il suo protettorato sulla costa orientale dell’Adriatico (Prima e Seconda Guerra Illirica, 229-219 a.C.). Queste azioni, pur non dirette contro Cartagine, aumentavano la sfera d’influenza romana e accrescevano la preoccupazione punica.
- Il Trattato dell’Ebro (226 a.C.): Come già detto, questo trattato delimitava le sfere d’influenza in Spagna, ma la sua interpretazione futura sarebbe stata causa di scontro.
- Il Problema di Sagunto: La città di Sagunto, pur trovandosi a sud dell’Ebro (quindi nella sfera d’influenza cartaginese), aveva legami di amicizia con Roma. Quando Annibale la assediò e la conquistò nel 219 a.C., Roma interpretò questo come una violazione della pace, considerandola un’aggressione diretta ai suoi interessi.
Mappa della Penisola Iberica con l’espansione cartaginese e il fiume Ebro.
4. Perché una Pace Precária?
La pace fu precaria per diversi fattori:
- Mancanza di un Accordo Duraturo: Il trattato del 241 a.C. fu una pace imposta dal vincitore, non un accordo tra pari che risolvesse le cause profonde della rivalità. Lasciò intatto il desiderio di rivincita di Cartagine.
- Dinamismo di Entrambe le Potenze: Sia Roma che Cartagine erano potenze in piena espansione, con ambizioni che inevitabilmente si sarebbero scontrate nuovamente per il controllo del Mediterraneo.
- La Figura di Annibale: Il genio militare e l’odio personale di Annibale per Roma furono un catalizzatore decisivo. La sua determinazione a vendicare le umiliazioni subite dalla sua patria e dalla sua famiglia portò alla strategia audace di invadere l’Italia.
- Interpretazione Contraddittoria dei Trattati: Il Trattato dell’Ebro non impediva a Cartagine di espandersi a sud, ma la questione di Sagunto, alleata di Roma pur essendo a sud dell’Ebro, divenne il pretesto perfetto per la rottura definitiva.
5. La Scintilla Finale: L’Assedio di Sagunto
L’assedio e la caduta di Sagunto nel 219 a.C. furono la miccia che fece esplodere la Seconda Guerra Punica. Annibale, consapevole delle implicazioni, agì con determinazione, sapendo che Roma non avrebbe potuto tollerare l’attacco a un suo alleato senza perdere prestigio. Il rifiuto cartaginese di consegnare Annibale a Roma, come richiesto, segnò la fine della “pace precária” e l’inizio di uno dei conflitti più epocali della storia antica.
L’assedio di Sagunto da parte di Annibale, il casus belli della Seconda Guerra Punica.