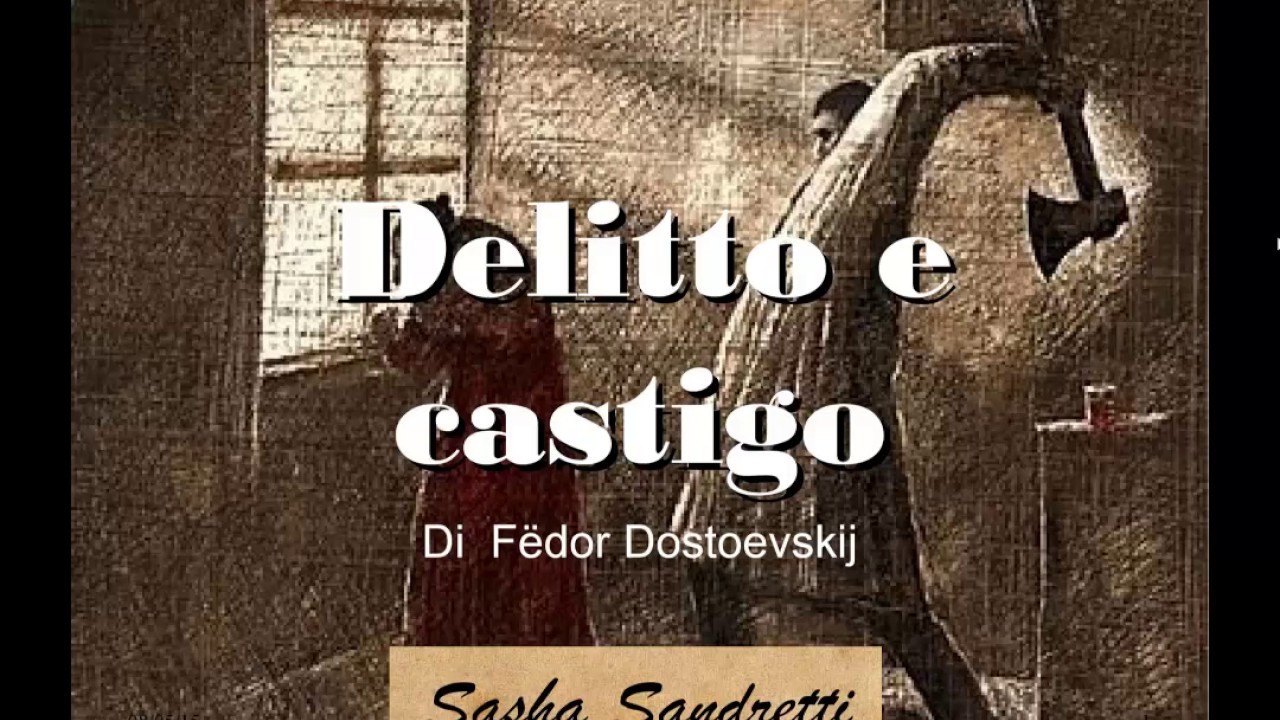
Delitto e castigo di Fedor Dostoevskij
28 Dicembre 2019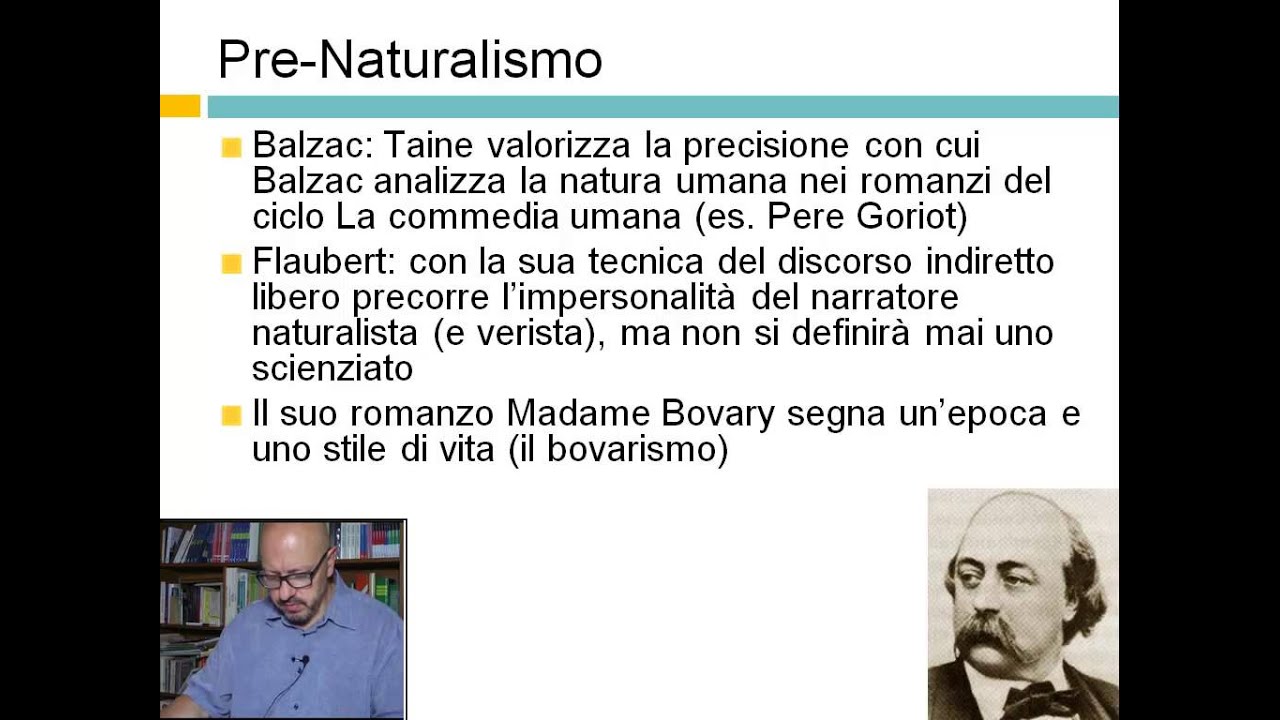
Edmond e Jules de Goncourt: Prefazione a Germinie Lacerteux (1864)
28 Dicembre 2019La nascita e lo sviluppo della lirica italiana sono profondamente legati alla tradizione poetica francese, in un processo di trasferimento culturale che rappresenta uno dei fenomeni più significativi della letteratura medievale europea.
Le origini provenzali: la poesia trobadorica
La lirica europea nasce nel XII secolo nella Francia meridionale, nelle corti di Provenza, con i trobadours. Questi poeti-musicisti, spesso di origine aristocratica, elaborano un nuovo codice poetico centrato sull’amor cortese (fin’amor), una concezione raffinata dell’amore che sublima il desiderio in devozione quasi religiosa verso la donna amata.
I primi grandi trobadours come Guglielmo IX d’Aquitania (1071-1127) e Bernart de Ventadorn (XII secolo) stabiliscono i fondamenti tematici e formali di questa tradizione: l’amore come esperienza totalizzante, la donna idealizzata come domna, il rapporto feudale tra amante e amata, l’elaborazione di un linguaggio poetico sofisticato e di forme metriche complesse.
La canso (canzone d’amore) diventa il genere principe, caratterizzata da strutture strofiche elaborate, rime complesse, un lessico prezioso e una sintassi ricercata. Altri generi come il planh (lamento), la pastorella e il sirventes (componimento politico-morale) completano il repertorio trobadorico.
La diffusione in Francia settentrionale
Nel corso del XII e XIII secolo, la tradizione provenzale si diffonde nella Francia settentrionale con i trouvères, che adattano i modelli meridionali alla lingua d’oïl. Poeti come Chrétien de Troyes e Gace Brulé sviluppano ulteriormente la tematica cortese, integrandola con la tradizione epica e romanzesca del Nord.
I trouvères introducono anche innovazioni formali significative, come il grand chant courtois, e contribuiscono alla codificazione di generi che avranno grande fortuna, come la chanson de toile e la reverdie.
Il trasferimento in Italia: contesti e modalità
La penetrazione della lirica francese in Italia avviene attraverso molteplici canali. Le corti italiane, in particolare quella di Federico II in Sicilia, accolgono trobadours provenzali come Aimeric de Peguilhan e Folquet de Marseille. Questi contatti diretti favoriscono la trasmissione non solo di testi, ma anche di tecniche compositive e concezioni estetiche.
Un ruolo fondamentale svolge la mobilità culturale: nobili italiani che partecipano alle crociate o intrattengono rapporti diplomatici con le corti francesi entrano in contatto con la tradizione poetica d’oltralpe. Allo stesso modo, la presenza di giullari e poeti itineranti facilita la circolazione di repertori e modelli.
La Scuola siciliana: la prima sintesi italiana
La Scuola siciliana (1230-1250 circa) rappresenta il momento cruciale di questa trasformazione. Alla corte di Federico II, poeti come Giacomo da Lentini, Pier della Vigna e Guido delle Colonne non si limitano a tradurre o imitare i modelli provenzali, ma operano una vera e propria ricreazione in volgare siciliano.
Giacomo da Lentini, tradizionalmente considerato l’inventore del sonetto, mostra come i poeti siciliani sappiano innovare anche sul piano formale. Il sonetto stesso nasce probabilmente dalla rielaborazione di modelli provenzali più complessi, ridotti a una forma più concentrata e equilibrata.
La lingua della Scuola siciliana presenta caratteristiche peculiari: pur partendo dal volgare siciliano, tende verso una koinè poetica che elimina i tratti più marcatamente dialettali, creando un linguaggio letterario di respiro soprannazionale.
Le trasformazioni tematiche e stilistiche
Il passaggio dalla Francia all’Italia comporta significative trasformazioni. L’amor cortese mantiene la sua centralità, ma si arricchisce di nuove sfumature. I poeti italiani tendono a una maggiore interiorizzazione dell’esperienza amorosa, sviluppando aspetti psicologici che saranno centrali nella lirica successiva.
Sul piano stilistico, si osserva una generale tendenza alla semplificazione delle strutture più complesse della tradizione provenzale, compensata da una maggiore attenzione alla musicalità del verso e alla densità semantica.
L’evoluzione nel Duecento italiano
Dopo la Scuola siciliana, la lirica italiana si sviluppa in diverse direzioni regionali. La scuola toscana con Guittone d’Arezzo introduce elementi morali e politici, mentre i poeti siculo-toscani operano una mediazione tra la tradizione siciliana e le nuove istanze espressive.
Il Dolce Stil Novo rappresenta l’approdo più maturo di questo processo evolutivo. Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti e infine Dante portano a compimento la trasformazione della lirica cortese, creando una poesia di straordinaria raffinatezza filosofica e tecnica.
L’eredità e l’originalità italiana
Il rapporto tra lirica francese e italiana non è di semplice derivazione, ma di creativa rielaborazione. Gli autori italiani assimilano i modelli d’oltralpe trasformandoli profondamente, creando tradizioni poetiche autonome che influenzeranno a loro volta lo sviluppo della lirica europea.
La capacità italiana di sintesi tra eredità classica, innovazione formale e profondità speculativa darà vita a una tradizione poetica di eccezionale ricchezza, che da Dante attraverso Petrarca giungerà fino al Rinascimento, mantenendo sempre un dialogo fecondo con le letterature europee pur conservando una spiccata originalità.
Questo processo testimonia come la cultura medievale fosse caratterizzata da una straordinaria mobilità di idee, forme e linguaggi, in cui le tradizioni nazionali nascevano proprio dall’incontro e dalla rielaborazione di patrimoni culturali diversi.
🎤🎧 Audio Lezioni di Letteratura delle origini, duecento e trecento del prof. Gaudio
Ascolta “Letteratura origini duecento e trecento” su Spreaker.




