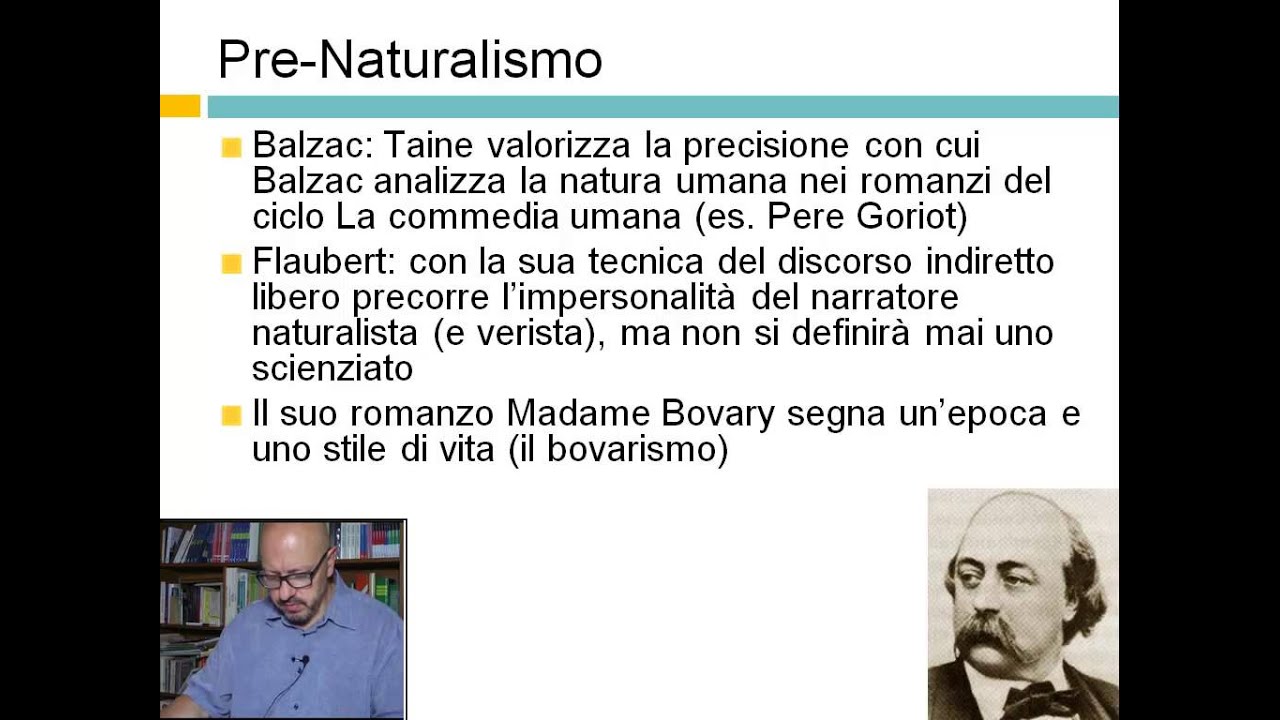I centri della cultura medievale e la figura del letterato
28 Dicembre 2019
La Matrona di Efeso dal Satyricon di Petronio
28 Dicembre 2019La Prefazione a Germinie Lacerteux, scritta dai fratelli Edmond (1822-1896) e Jules (1830-1870) de Goncourt per il loro romanzo del 1864, è un vero e proprio manifesto letterario. Con questo scritto polemico, i Goncourt si contrappongono apertamente alla falsità e alla convenzionalità del romanzo borghese dell’epoca, che mirava a offrire al pubblico «letture anodine» e consolatorie. Essi rivendicano la necessità di una letteratura che si faccia portavoce della «verità» e della «vita reale» delle classi più umili, annunciando un metodo che obbedisce all’analisi scientifica, trasformando il romanzo in una «Storia morale contemporanea». Questa prefazione è considerata un testo chiave per la nascita del Naturalismo francese.
Edmond e Jules de Goncourt, pionieri del Realismo e Naturalismo francese.
Testo della Prefazione
Dobbiamo chiedere scusa al pubblico per questo libro che gli offriamo e avvertirlo di quanto vi troverà.
Il pubblico ama i romanzi falsi: questo è un romanzo vero.
Ama i romanzi che danno l’illusione di essere introdotti nel gran mondo: e questo libro viene dalla strada.
Ama le operette maliziose, le memorie di fanciulle, le confessioni d’alcova, le sudicerie erotiche, lo scandalo racchiuso in un’illustrazione nelle vetrine dei librai: il libro che sta per leggere è severo e puro.
Che il pubblico non si aspetti la fotografia licenziosa del Piacere: lo studio che segue è la clinica dell’Amore.
Il pubblico apprezza ancora le letture anodine e consolanti, le avventure che finiscono bene, le fantasie che non sconvolgono la sua digestione né la sua serenità: questo libro, con la sua triste e violenta novità, è fatto per contrariare le abitudini del pubblico, per nuocere alla sua igiene.
Perché mai dunque l’abbiamo scritto? Proprio solo per offendere il lettore o scandalizzare i suoi gusti? No.
Vivendo nel diciannovesimo secolo, in un’epoca di suffragio universale, di democrazia, di liberalismo, ci siamo chiesti se le cosiddette «classi inferiori» non abbiano diritto al Romanzo; se questo mondo sotto un mondo, il popolo, debba restare sotto il peso del «vietato» letterario e del disdegno degli autori che sino ad ora non hanno mai parlato dell’anima e del cuore che il popolo può avere.
Ci siamo chiesti se possano ancora esistere, per lo scrittore e per il lettore, in questi anni d’uguaglianza che viviamo, classi indegne, infelicità troppo terrene, drammi troppo mal recitati, catastrofi d’un terrore troppo poco nobile.
Ci ha presi la curiosità di sapere se questa forma convenzionale di una letteratura dimenticata e di una società scomparsa, la Tragedia, sia definitivamente morta; se, in un paese senza caste e senza aristocrazia legale, le miserie degli umili e dei poveri possano parlare all’interesse, all’emozione, alla pietà, tanto quanto le miserie dei grandi e dei ricchi; se, in una parola, le lacrime che si piangono in basso possano far piangere come quelle che si piangono in alto.
Queste meditazioni ci hanno indotto a tentare l’umile romanzo di Suor Filomena, nel 1861; e adesso ci inducono a pubblicare Le due vite di Germinia Lacerteux.
Ed ora, questo libro viene pure calunniato: poco c’importa: oggi che il Romanzo si allarga e ingrandisce e comincia ad essere la grande forma seria, appassionata, viva, dello studio letterario e della ricerca sociale, oggi che esso diventa, attraverso l’analisi e la ricerca psicologica, la Storia morale contemporanea, oggi che il Romanzo s’è imposto gli studi e i compiti della scienza, può rivendicarne la libertà e l’indipendenza.
Ricerchi dunque l’Arte e la Verità; mostri miserie tali da imprimersi nella memoria dei benestanti di Parigi; faccia vedere alla gente della buona società quello che le dame di carità hanno il coraggio di vedere, quello che una volta le regine facevano sfiorare appena con gli occhi, negli ospizi, ai loro figli: la sofferenza umana, presente e viva, che insegna la carità.
Il Romanzo abbia quella religione, che il secolo scorso chiamava con il nome largo e vasto di Umanità; basterà questa coscienza: ecco il suo diritto.
Copertina di una delle edizioni di “Germinie Lacerteux”.
Analisi della Prefazione: Un Manifesto del Realismo Sociale
La Prefazione a Germinie Lacerteux non è un semplice introduzione a un romanzo, ma un vero e proprio manifesto programmatico che anticipa e definisce i principi del Realismo e del Naturalismo. I Goncourt intendono provocare e istruire il lettore, sfidando le convenzioni letterarie e sociali del loro tempo.
1. Il Rifiuto del Romanzo Convenzionale (“Romanzi Falsi”)
La prefazione si apre con una dichiarazione polemica. I Goncourt attaccano il romanzo borghese allora in voga, descrivendolo come “falso”, “malizioso”, “anodino” (che toglie il dolore, che non crea turbamento) e “consolante”. Questo tipo di letteratura, secondo loro, offriva al pubblico un’illusione di bellezza e armonia che non corrispondeva alla realtà, rassicurando il pubblico borghese e non disturbando la sua “digestione” né la sua “serenità”. Essi si pongono in netto contrasto con i romanzi “del gran mondo” o le “sudicerie erotiche” che campeggiavano nelle vetrine.
2. L’Adesione alla Verità e al Realismo Sociale
In opposizione alla falsità, i Goncourt propongono il “romanzo vero”. La loro scelta di narrare la storia di Germinie Lacerteux, una domestica con una doppia vita di rispettabilità diurna e dissolutezza notturna (basata su un fatto di cronaca vera che riguardò la loro governante), è una presa di posizione radicale. Essi affermano che il loro libro “viene dalla strada” e che è “severo e puro”, in quanto studio non giudicante della realtà umana.
Il focus si sposta sulle “classi inferiori” e sul “popolo”, un “mondo sotto un mondo” che fino ad allora era stato escluso o marginalizzato dalla rappresentazione letteraria. Questa è una novità rivoluzionaria, che i Goncourt giustificano richiamandosi al contesto del loro “diciannovesimo secolo, in un’epoca di suffragio universale, di democrazia, di liberalismo”. Se la società sta evolvendo verso l’uguaglianza politica, anche la letteratura deve adeguarsi, riconoscendo il diritto del popolo a essere rappresentato con la sua “anima e il suo cuore”, le sue “infelicità troppo terrene”, i suoi “drammi troppo mal recitati”. Essi demoliscono l’idea di “classi indegne” di essere soggetto letterario.
3. Il Romanzo come “Clinica dell’Amore” e “Scienza”
Una delle metafore più celebri della prefazione è quella del romanzo come “clinica dell’Amore”, in opposizione alla “fotografia licenziosa del Piacere”. Questa immagine sottolinea l’intento scientifico e quasi clinico dei Goncourt: il romanzo non deve divertire o eccitare, ma analizzare la passione umana con la stessa precisione e oggettività con cui un medico studia una malattia. Questo si collega direttamente all’affermazione finale che il romanzo “s’è imposto gli studi e i compiti della scienza”. Non è più solo arte, ma anche ricerca, analisi psicologica, studio della società. In questo senso, il romanzo diventa la “Storia morale contemporanea”, un documento del suo tempo.
4. La Morte della Tragedia e la Rinascita dell’Umanità
I Goncourt si interrogano sulla sopravvivenza della “Tragedia” come forma letteraria in una società “senza caste e senza aristocrazia legale”. Se la tragedia classica si occupava delle miserie dei “grandi e dei ricchi”, i Goncourt si chiedono se “le lacrime che si piangono in basso possano far piangere come quelle che si piangono in alto”. Questa è una dichiarazione di principio fondamentale: la sofferenza degli umili ha la stessa dignità letteraria e la stessa capacità di commuovere.
Il romanzo, quindi, ha un’importante funzione sociale e quasi “religiosa”. Deve “ricercare l’Arte e la Verità”, ma anche “mostrare miserie tali da imprimersi nella memoria dei benestanti di Parigi”. Deve educare alla carità, mostrando “la sofferenza umana, presente e viva”. Il romanzo deve incarnare quella “religione che il secolo scorso chiamava con il nome largo e vasto di Umanità”. Questa coscienza etica è, per i Goncourt, il vero “diritto” e fondamento del romanzo.
5. L’Influenza e l’Eredità
La Prefazione a Germinie Lacerteux è un testo chiave che precede di qualche anno il più famoso manifesto di Émile Zola, Il Romanzo Sperimentale. Tuttavia, i Goncourt furono i primi a formulare in modo così esplicito i principi che avrebbero guidato il Naturalismo: l’osservazione scientifica della realtà, la rappresentazione delle classi umili, la convinzione che l’ambiente e l’ereditarietà determinino il comportamento umano, e la funzione sociale della letteratura come strumento di analisi e denuncia. La loro opera e questa prefazione aprirono la strada a una nuova era del romanzo, più attenta al reale, più scomoda e, per questo, più potente.