
Il bambino col pigiama a righe di John Boyne
28 Dicembre 2019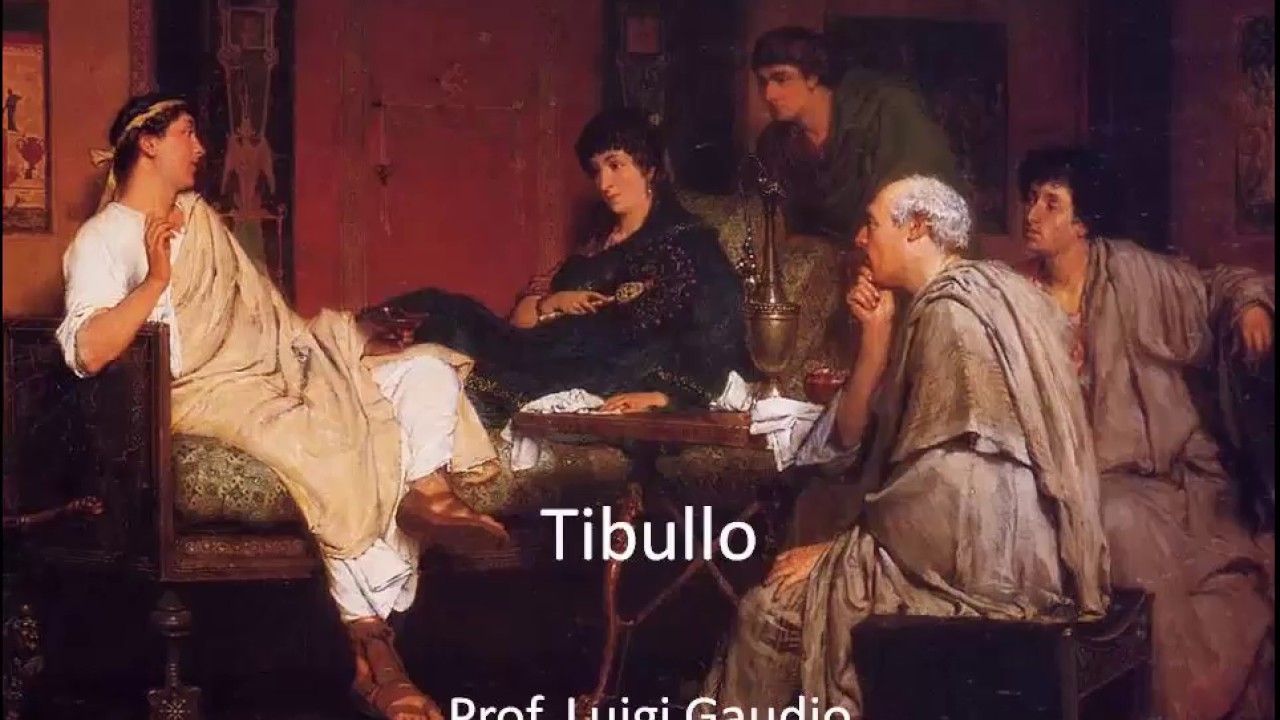
2. Ideale di vita. Prima elegia del primo libro del Corpus tibullianum, vv 13-24
28 Dicembre 2019Il “Diario di Anna Frank” è uno dei documenti più significativi e commoventi della letteratura testimoniale del Novecento, pubblicato per la prima volta nel 1947 per volontà del padre Otto Frank, unico sopravvissuto della famiglia.
Contesto storico e biografico Anna Frank nacque a Francoforte nel 1929 in una famiglia ebraica benestante. Nel 1933, con l’ascesa del nazismo, la famiglia si trasferì ad Amsterdam dove Otto Frank avviò un’attività commerciale. L’invasione tedesca dei Paesi Bassi nel 1940 e l’inasprimento delle leggi razziali costrinsero la famiglia alla clandestinità dal luglio 1942.
La vita nell’Alloggio Segreto Per oltre due anni, otto persone vissero nascoste in un appartamento segreto ricavato nei piani superiori dell’edificio al 263 di Prinsengracht, dove Otto Frank aveva la sua ditta. Oltre alla famiglia Frank (Otto, Edith, Margot e Anna), si nascondevano la famiglia van Pels e Fritz Pfeffer. La sopravvivenza era garantita da alcuni collaboratori fidati che procuravano cibo e notizie dall’esterno, rischiando la propria vita.
Struttura e contenuto del diario Anna iniziò a scrivere il diario il 12 giugno 1942, giorno del suo tredicesimo compleanno, quando ricevette in dono un quaderno a quadretti rossi. Le prime pagine descrivono la vita normale di una ragazzina olandese, ma ben presto documentano l’esperienza della clandestinità. Anna si rivolge al diario come a un’amica immaginaria chiamata “Kitty”, creando un dialogo intimo e confidenziale.
Il diario rivela la straordinaria maturazione psicologica di Anna durante i mesi di reclusione. Dalle preoccupazioni tipicamente adolescenziali – i rapporti con i genitori, i primi innamoramenti, la scoperta della sessualità – si passa a riflessioni profonde sulla natura umana, sulla guerra, sul significato dell’esistenza e sulla propria identità ebraica.
Temi centrali L’opera affronta molteplici livelli tematici. C’è la cronaca quotidiana della vita in clandestinità, con le sue tensioni, paure e piccole gioie. Anna descrive minuziosamente la convivenza forzata, i conflitti generazionali, le difficoltà materiali e la costante paura di essere scoperti. Emergono però anche temi universali: la ricerca dell’identità durante l’adolescenza, il rapporto conflittuale con la madre, l’amore per Peter van Pels, la passione per la scrittura e il sogno di diventare giornalista.
Particolarmente significative sono le riflessioni di Anna sulla natura umana. Nonostante viva sulla propria pelle l’orrore della persecuzione, mantiene una straordinaria fiducia nell’umanità, scrivendo la celebre frase: “Nonostante tutto, credo ancora che la gente sia davvero buona di cuore”.
Valore letterario e stile Dal punto di vista letterario, il diario mostra l’evoluzione stilistica di Anna, che passa da una scrittura inizialmente semplice e spontanea a una prosa sempre più matura e consapevole. Anna dimostra notevoli doti narrative, capacità di introspezione psicologica e un senso dell’ironia che la aiuta a sopportare le difficoltà. La scrittura diventa per lei rifugio, mezzo di elaborazione delle emozioni e strumento di conservazione della memoria.
Il tragico epilogo Il 4 agosto 1944, in seguito a una denuncia anonima, la polizia tedesca scoprì l’Alloggio Segreto. Tutti gli abitanti furono arrestati e deportati. Anna e la sorella Margot morirono nel campo di concentramento di Bergen-Belsen tra febbraio e marzo 1945, poche settimane prima della liberazione del campo. Solo Otto Frank sopravvisse e, al ritorno ad Amsterdam, ricevette da Miep Gies, una delle persone che li aveva aiutati, i quaderni del diario che aveva conservato.
Impatto culturale e educativo Il diario è diventato uno dei libri più letti al mondo, tradotto in oltre 70 lingue. La casa di Amsterdam è ora un museo visitato da oltre un milione di persone ogni anno. L’opera ha ispirato numerosi adattamenti teatrali, cinematografici e televisivi, diventando simbolo universale della Shoah e strumento pedagogico fondamentale per l’educazione alla memoria.
Il valore del diario risiede nella sua capacità di rendere concrete e personali le tragedie della Storia attraverso gli occhi di una ragazza normale, trasformando le statistiche della persecuzione in esperienza umana tangibile e universale.
🎤🎧 Audio Lezioni, ascolta il podcast sulla Letteratura del novecento del prof. Gaudio
Ascolta “Letteratura del novecento” su Spreaker.
🎤🎧 Audio Lezioni, ascolta il podcast di Storia moderna e contemporanea del prof. Gaudio




