
Il bambino col pigiama a righe di John Boyne
28 Dicembre 2019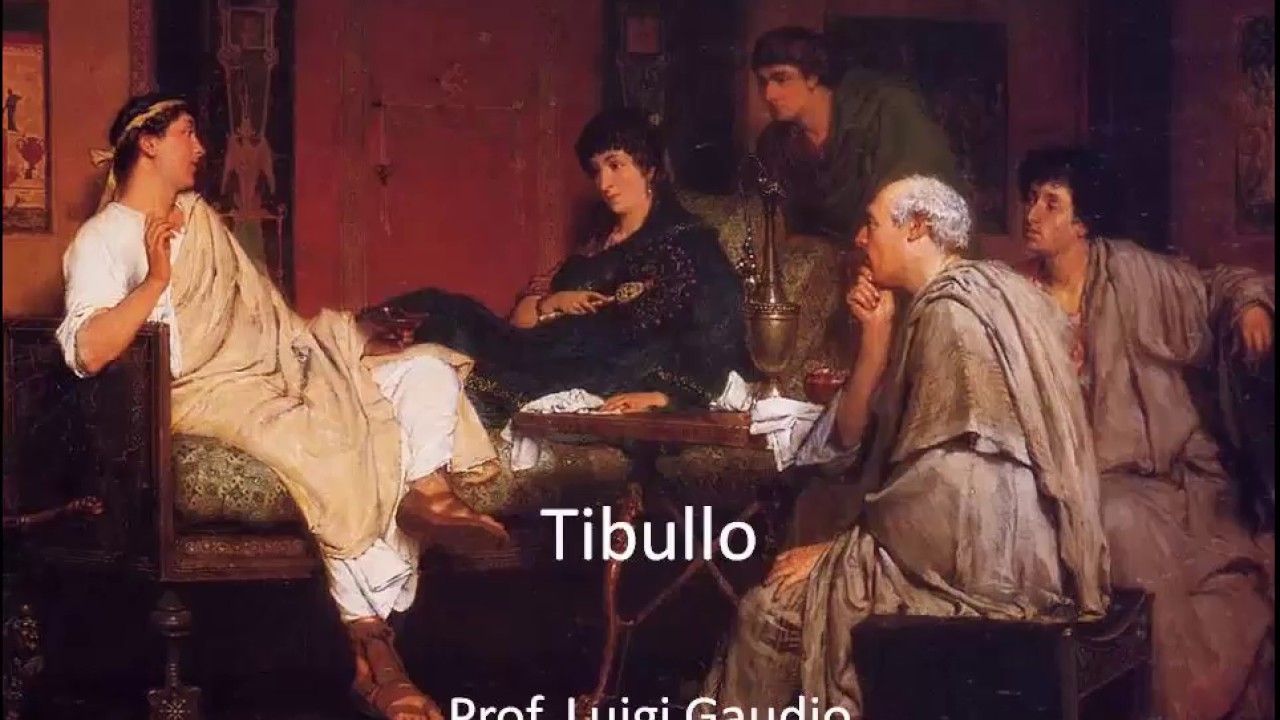
2. Ideale di vita. Prima elegia del primo libro del Corpus tibullianum, vv 13-24
28 Dicembre 2019Lo Stile di Marco Anneo Lucano e letture della Pharsalia
Marco Anneo Lucano (39-65 d.C.) è una delle voci più originali e drammatiche della poesia latina di età imperiale. La sua unica opera giunta a noi, il Bellum Civile (comunemente noto come Pharsalia), è un poema epico incompiuto in dieci libri, incentrato sulla guerra civile tra Cesare e Pompeo (49-48 a.C.). Lo stile di Lucano è notoriamente “antitradizionale”, in netta opposizione al modello classico virgiliano, e riflette la sua visione pessimistica della storia e il suo disprezzo per la tirannide.
1. Le Caratteristiche dello Stile di Lucano: Un’Epica dell’Orrore e della Passione
Lucano si allontana radicalmente dall’armonia, dalla moderazione e dal messaggio provvidenziale dell’Eneide di Virgilio. La sua è un’epica della violenza, del furor e della disillusione.
- Assenza del Numen (Intervento Divino): A differenza dell’epica tradizionale, in Lucano gli dèi sono assenti o indifferenti alle vicende umane. Il destino di Roma è interamente plasmato dalle passioni e dalle azioni dei mortali, in particolare dalla cieca violenza e dalla sete di potere. Questo rende il dramma umano ancora più cupo e senza speranza di redenzione.
- L’Anti-eroe: Non c’è un eroe positivo e guidato dal destino come Enea.
- Cesare: È la personificazione del furor (follia, violenza irrazionale), un uomo d’azione implacabile, ma privo di pietas. È una forza distruttrice, un tiranno la cui ambizione porta alla rovina della Repubblica.
- Pompeo: È una figura ambigua e tragica, un’ombra della sua passata grandezza, caratterizzato da inertia (indolenza) e rassegnazione. È un eroe del passato, incapace di affrontare il presente.
- Catone Uticense: È l’unico personaggio che incarna valori etici e morali (in particolare quelli stoici: libertà, coerenza, virtù), ma è un eroe tragico e perdente, destinato a soccombere al fatum (destino avverso) e alla fortuna (sorte cieca) che favoriscono i malvagi.
- Il Pathos Esasperato: Lucano ricerca costantemente l’emozione forte, il pathos intenso. Le descrizioni sono spesso iperboliche, esagerate, mirate a suscitare orrore, sdegno o commozione estrema nel lettore. Ogni episodio è caricato di tensione drammatica.
- Gusto del Macabro e dell’Orrido: L’autore non esita a descrivere con crudezza dettagli raccapriccianti di battaglie, ferite, morti e orrori della guerra civile. Questa predilezione per il grottesco e il macabro riflette un gusto tipico dell’età neroniana e serve a sottolineare l’assurdità e la disumanità del conflitto.
- Concettismo e Sententiae: Lo stile di Lucano è denso di sententiae (massime, aforismi) e concetti (pensieri acuti, spesso paradossali). La poesia è ricca di riflessioni morali e politiche, espresse in modo incisivo e memorabile, che interrompono il flusso narrativo per offrire spunti di meditazione sul significato degli eventi. Questa caratteristica deriva in parte dalla retorica e dalla filosofia stoica, in particolare dallo zio Seneca.
- Aderenza alla Storia (ma non troppo!): Sebbene Lucano racconti eventi storici recenti e ben noti, non esita a piegare i fatti storici alle sue esigenze ideologiche e drammatiche, enfatizzando o alterando dettagli per rafforzare il suo messaggio anti-tirannico.
- L’Esametro “Violentato”: Lucano utilizza l’esametro, il metro epico per eccellenza, ma lo manipola in modo da renderlo meno armonioso e fluido rispetto a Virgilio. Spesso ci sono cesure anomale, enjambements forzati e un’assenza di fluidità che ne sottolinea la drammaticità e la concitazione.
2. Brani Esemplari dalla Pharsalia
Ecco alcuni passaggi significativi che illustrano lo stile e le tematiche di Lucano:
A) L’Introduzione: La Guerra Civile come Male Assoluto (Libro I, vv. 1-7)
In questo famoso proemio, Lucano dichiara subito il suo argomento e la sua visione. Notate la cruda onestà nel definire la guerra civile, in contrasto con l’invocazione alle Muse virgiliana.
Testo Latino:
Bella per Emathios plus quam ciuilia campos,
iusque datum sceleri canimus, populumque potentem
in sua uictrici conuersum uiscera dextra,
cognatasque acies, et rupto foedere regni
certatum totis concussi uiribus orbis
in commune nefas, infestisque obuia signis
signa, pares aquilas et pila minantia pilis.
Traduzione Italiana: Canto le guerre più che civili nei campi d’Emazia, e il diritto concesso al crimine, e un popolo potente rivoltosi contro le proprie viscere con la mano vincitrice, e schieramenti consanguinei, e rotta la legge del potere si lottò con tutte le forze di un mondo sconvolto verso una comune sciagura, e contro insegne ostili si opposero insegne, aquile pari e giavellotti che minacciavano giavellotti.
Commento: Fin dalle prime parole, Lucano definisce la sua epica come “più che civile” (plus quam ciuilia), sottolineando l’innaturalità e l’orrore del conflitto fratricida. L’assenza di divinità è subito evidente. La “mano vincitrice” che si rivolge contro “le proprie viscere” è un’immagine potente di autodistruzione. L’insistenza sulla parità degli schieramenti (“aquile pari e giavellotti che minacciavano giavellotti”) evidenzia la tragedia di una lotta senza un vero nemico esterno, ma un nemico interno.
B) Il Ritratto di Cesare: Furor e Ambizione (Libro I, vv. 150-157)
Lucano presenta Cesare come una forza travolgente, priva di freni, che agisce mossa da una sete inarrestabile di potere.
Testo Latino:
Ille [Caesar] auidus caedis et rapiendi,
nec non et ad arma furentem
fortunam spectans, cui numen inanis
semper inanis est. Hic est ille,
qui non hostibus, sed sibi metuit;
qui non parcit ulla caede, nec ullos
superat, nisi quos prius fecerit inimicos.
Traduzione Italiana: Egli [Cesare], avido di strage e di rapina, e anche contemplando la fortuna che lo spinge alle armi, per cui la divinità è sempre vana e inutile. Egli è colui che non teme i nemici, ma se stesso; che non risparmia nessuna strage, né supera alcuno, se non coloro che prima ha reso nemici.
Commento: Cesare è descritto come “avido di strage e di rapina”, guidato da una “fortuna” che lo spinge al “furor“. L’affermazione “per cui la divinità è sempre vana e inutile” sottolinea l’assenza di un ordine provvidenziale e l’autonomia distruttiva di Cesare. L’ultima frase, paradossale, evidenzia la sua natura di distruttore che crea nemici per poterli sconfiggere, a dimostrazione di una violenza intrinseca e non reattiva.
C) La Morte di Pompeo: Il Gusto del Macabro e il Pessimismo (Libro VIII, vv. 663-670)
Questo passaggio descrive la decapitazione di Pompeo, un episodio centrale e orribile, con un’attenzione quasi morbosa ai dettagli.
Testo Latino:
At non ille iacet, qualem se Particus hostis
sperarat: truncum, sine nomine, sine ore,
sed iam diu notum, nullo coniectum in tumulo,
nullaque signatum lapide;
et in exanima ora iacenti,
semper in ore, moritur.
Traduzione Italiana: Ma egli non giace quale il nemico Parto avrebbe sperato: un tronco, senza nome, senza volto, ma ormai da tempo noto, gettato in nessuna tomba, e segnato da nessuna pietra; e nella sua faccia esanime che giace, per sempre sulla bocca, egli muore.
Commento: La descrizione del corpo decapitato di Pompeo è un esempio lampante del gusto del macabro. Il “tronco, senza nome, senza volto” enfatizza la degradazione finale di un uomo che fu grande, privato della sua identità anche nella morte. L’assenza di una sepoltura dignitosa sottolinea l’orrore e l’anti-eroismo della guerra civile. Il “per sempre sulla bocca, egli muore” può riferirsi all’ultimo respiro o al terrore impresso sul volto, accentuando la tragicità e la deformità della fine.
Attraverso questi e altri brani, Lucano costruisce un’epica che è allo stesso tempo un lamento, un’accusa e una meditazione sulla distruzione politica e morale che la guerra civile aveva portato a Roma. Il suo stile, seppur aspro e a volte eccentrico, è un potente veicolo per esprimere la sua visione tragica e disillusa della storia e del potere.




