Brani tradotti dal Satyricon di Petronio
28 Dicembre 2019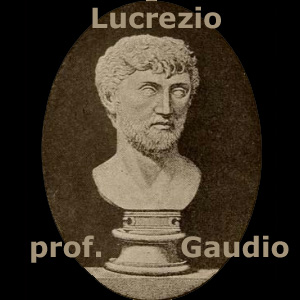
La passione d’amore dal De rerum natura di Lucrezio, IV, 1141-1159
28 Dicembre 2019Testo, traduzione e analisi di un testo di Lucrezio: La Passione d’Amore (De Rerum Natura, Libro IV, vv. 1123-1128)
Ecco la traduzione e l’analisi di questo celebre passo lucreziano sugli effetti devastanti della passione amorosa:
Traduzione
1. Testo Latino e Traduzione Italiana
| Lucrezio, De Rerum Natura, Libro IV, vv. 1121-1128
Adde quod absumunt viris pereuntque labore, 1121
adde quod alterius sub nutu degitur aetas, languent officia atque aegrotat fama vacillans. Labitur interea res et Babylonia fiunt unguenta et pulchra in pedibus Sicyonia rident, 1125 scilicet et grandes viridi cum luce zmaragdi auro includuntur teriturque thalassina vestis adsidue et Veneris sudorem exercita potat. |
Traduzione italiana
Aggiungi che si consumano le forze e periscono nella fatica, |
2. Analisi del Brano: La Disillusione della Passione
Analisi del brano
Contesto nella critica dell’amore
Questo passo rappresenta uno dei momenti più incisivi della celebre diatriba lucreziana contro la passione amorosa. Il poeta ha appena descritto i tormenti psicologici dell’innamorato e ora passa a catalogare sistematicamente le conseguenze pratiche e sociali di questa “malattia”.
La struttura dell’argomentazione
Lucrezio procede per accumulo, usando l’anafora “adde quod” che scandisce inesorabilmente la lista dei danni. La progressione va dal personale al sociale, dal fisico all’economico:
Deterioramento fisico (v. 1121): “absumunt viris pereuntque labore” – la passione letteralmente consuma le energie vitali, trasformando l’amante in un essere debilitato.
Perdita di autonomia (v. 1122): “alterius sub nutu degitur aetas” – la vita non appartiene più al soggetto ma è governata dai capricci dell’amato/a. È una forma di schiavitù volontaria.
Degrado sociale (v. 1123): “languent officia atque aegrotat fama” – i doveri civici vengono trascurati e la reputazione si deteriora. Lucrezio usa un linguaggio medico (“aegrotat”) che equipara il danno sociale a una malattia.
La sezione economica (vv. 1124-1128)
Questa parte è particolarmente efficace perché descrive la dissipazione del patrimonio attraverso un catalogo di beni di lusso:
Unguenti di Babilonia: profumi esotici e costosi, simbolo di raffinatezza orientale Calzature di Sicione: famose per la loro eleganza, rappresentano la vanità del vestire Smeraldi incastonati nell’oro: il culmine del lusso, pietre preziose in montature d’oro Tessuti color del mare (thalassina): stoffe pregiate tinte con la porpora marina
Aspetti stilistici
Il linguaggio combina precisione tecnica ed effetto poetico. La personificazione delle calzature che “ridono” (rident) sui piedi crea un’immagine vivace e ironica. Il climax finale “Veneris sudorem exercita potat” è di grande efficacia: i tessuti preziosi “bevono” letteralmente il sudore degli amplessi, trasformando il sublime in prosaico.
L’allitterazione (“pulchra… pedibus”, “grandes… viridi”, “teritur… thalassina”) e l’assonanza creano un effetto musicale che contrasta ironicamente con la durezza del contenuto morale.
Significato filosofico
Lucrezio non condanna l’amore per moralismo tradizionale, ma perché rappresenta una forma di ataraxia negativa – il contrario della serenità epicurea. L’amante perde la libertà interiore, diventa schiavo dei sensi e delle apparenze, disperde le energie che dovrebbero essere dedicate al raggiungimento della saggezza.
La critica del lusso
Il catalogo dei beni di lusso non è casuale: Lucrezio critica una società che confonde il piacere autentico (semplice, naturale, duraturo) con il piacere artificiale (costoso, esibito, effimero). Gli “unguenti di Babilonia” e i tessuti preziosi sono metafore di una civiltà che ha perduto il contatto con i bisogni naturali.
Modernità della critica
Questo passo anticipazione le critiche moderne alla società dei consumi. Lucrezio descrive con precisione chirurgica come la passione amorosa si intrecci con il consumismo, creando un circolo vizioso di desiderio, spesa e insoddisfazione che prefigura le dinamiche del capitalismo contemporaneo.
Immagine di un busto di Lucrezio, il filosofo-poeta autore del De Rerum Natura.




