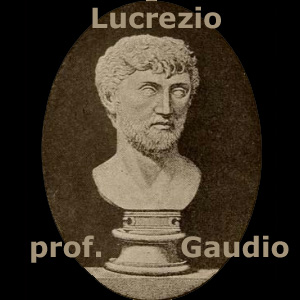
La passione d’amore dal De rerum natura di Lucrezio IV 1129-1140
28 Dicembre 2019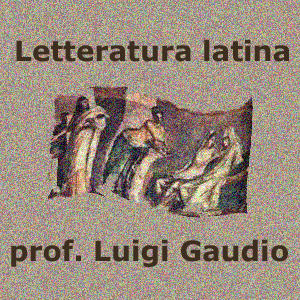
Testimonianze poetiche preletterarie in latino
28 Dicembre 2019Testo, traduzione e analisi di un testo di Lucrezio: La Passione d’Amore (De Rerum Natura, Libro IV, vv. 1141-1159)
In questa seconda parte del suo excursus sull’amore, Lucrezio continua a delineare i pericoli della passione, offrendo al lettore una sorta di “terapia” epicurea: la prevenzione è meglio della cura, e la lucidità mentale è essenziale per riconoscere e sfuggire alle trappole dell’amore ossessivo, che spesso porta all’idealizzazione illusoria della persona amata.
1. Testo Latino e Traduzione Italiana
| Lucrezio, De Rerum Natura, Libro IV, vv. 1141-1159
Atque in amore mala haec proprio summeque secundo 1141
inveniuntur; in adverso vero atque inopi sunt, prendere quae possis oculorum lumine operto. innumerabilia; ut melius vigilare sit ante, qua docui ratione, cavereque, ne inliciaris. 1145 nam vitare, plagas in amoris ne iaciamur, non ita difficile est quam captum retibus ipsis exire et validos Veneris perrumpere nodos. et tamen implicitus quoque possis inque peditus effugere infestum, nisi tute tibi obvius obstes 1150 et praetermittas animi vitia omnia primum aut quae corporis sunt eius, quam praepetis ac vis. nam faciunt homines plerumque cupidine caeci et tribuunt ea quae non sunt his commoda vere. multimodis igitur pravas turpisque videmus 1155 esse in deliciis summoque in honore vigere. atque alios alii inrident Veneremque suadent ut placent, quoniam foedo adflictentur amore, nec sua respiciunt miseri mala maxima saepe. 1159 |
Traduzione italiana
E questi mali si trovano nell’amore anche se fortunato e pienamente ricambiato; nell’amore avverso e privo di speranza, invece, ve ne sono |
2. Analisi del Brano: Prevenzione e “Cecità del Desiderio”
Dopo aver elencato i mali intrinseci all’amore, Lucrezio passa a una fase di esortazione e ammonimento, sottolineando l’importanza della ragione epicurea per sfuggire a questa passione devastante.
- La Universalità del Male e la Prevenzione (vv. 1141-1145): Il poeta inizia affermando che i mali appena descritti si manifestano anche nell’amore proprio summeque secundo (persino nell’amore fortunato e pienamente ricambiato). Questo rafforza la sua tesi che l’amore passionale è intrinsecamente negativo. Se in un amore felice i mali sono evidenti, in quello adverso vero atque inopi (avverso e senza speranza) sono innumerabilia (innumerevoli) e così evidenti che possis oculorum lumine operto (potresti coglierli anche a occhi chiusi). Questa constatazione porta all’imperativo categorico: ut melius vigilare sit ante… cavereque, ne inliciaris (così è meglio essere vigili prima… e stare attenti a non farsi adescare). La prevenzione è la chiave di volta della “terapia” lucreziana contro l’amore.
- La Difficoltà della Liberazione (vv. 1146-1150): Lucrezio paragona l’amore a una trappola o una rete: vitare, plagas in amoris ne iaciamur, non ita difficile est quam captum retibus ipsis exire et validos Veneris perrumpere nodos (evitare di cadere nelle trappole dell’amore non è così difficile quanto, una volta preso nelle reti stesse, uscirne e rompere i forti nodi di Venere). Questa immagine delle reti di Venere è un topos poetico, ma qui usata per evidenziare la tenacia e la difficoltà di liberarsi da un amore che si è ormai radicato. Tuttavia, il poeta non dispera completamente: et tamen implicitus quoque possis inque peditus effugere infestum, nisi tute tibi obvius obstes (E tuttavia, anche intrappolato e impigliato, potresti sfuggire a questo male, a meno che tu stesso non ti ci opponga). C’è una via d’uscita, ma richiede uno sforzo attivo e razionale dell’individuo, senza ostacolare se stessi.
- La “Cecità del Desiderio” e l’Idealizzazione (vv. 1151-1159): La condizione fondamentale per liberarsi dall’amore è la lucidità intellettuale. Bisogna smettere di trascurare (praetermittas) tutti i difetti, sia animi (dell’anima, del carattere) sia corporis (del corpo) della persona amata. Questo introduce il concetto centrale di cupidine caeci (ciechi dal desiderio). Lucrezio afferma che gli uomini, accecati dalla passione, tribuunt ea quae non sunt his commoda vere (attribuiscono a lei qualità che in realtà non possiede). Questa è la radice dell’illusione amorosa. L’autore prosegue con un’osservazione ironica e disincantata: multimodis igitur pravas turpisque videmus esse in deliciis summoque in honore vigere (Così vediamo in molti modi donne deformi e brutte essere in preda a deliri d’amore e godere di sommo onore). Questo passo è una critica diretta alla capacità dell’amore di distorcere la percezione della realtà, rendendo l’amante incapace di vedere i difetti dell’amata. La chiusa del brano è particolarmente amara: atque alios alii inrident Veneremque suadent ut placent, quoniam foedo adflictentur amore, nec sua respiciunt miseri mala maxima saepe (E gli uni si prendono gioco degli altri e si esortano a compiacere Venere, poiché sono tormentati da un amore vergognoso, e spesso non si accorgono, infelici, dei loro stessi, gravissimi mali). Questo evidenzia l’autoinganno e l’ipocrisia degli amanti, che, pur soffrendo e riconoscendo la follia negli altri, non riescono a vedere i propri mala maxima (i propri gravissimi mali).
3. Connessioni Filosofiche e Stilistiche
- Epicureismo e Atarassia: L’intero brano è un’applicazione pratica del precetto epicureo di evitare il dolore e il turbamento (atarassia). L’amore passionale è presentato come la fonte per eccellenza di turbamento mentale, e la ragione è lo strumento per evitarlo o liberarsene. Lucrezio, come Epicuro, non condanna il piacere in sé, ma il piacere che genera più dolore e inquietudine.
- Didattismo: Il tono è esplicitamente didascalico (qua docui ratione), con l’autore che si rivolge direttamente al lettore per impartire insegnamenti.
- Ironia e Critica Sociale: Lucrezio osserva la follia degli amanti con un distacco che sfocia nell’ironia, mettendo in ridicolo le loro illusioni e la loro auto-ciecità. Questa critica si estende anche a un certo costume sociale, che spinge all’amore come fonte di prestigio, ignorandone le reali conseguenze.
- Linguaggio e Immagini: Il linguaggio è conciso ma efficace. L’immagine delle “reti di Venere” è evocativa e ben rende l’idea dell’amore come trappola. Il concetto di “cecità” (caeci) è una metafora chiave per l’irrazionalità della passione.
In sintesi, Lucrezio, in questi versi, non si limita a denunciare i mali dell’amore, ma offre anche una via d’uscita, basata sulla consapevolezza razionale e sull’eliminazione delle illusioni. Il messaggio è chiaro: la vera felicità non risiede nel lasciarsi travolgere dalla passione, ma nel mantenere la propria lucidità e nel riconoscere la realtà delle cose, anche se ciò significa smascherare le proprie stesse illusioni e quelle degli altri.
Immagine di un busto di Lucrezio, il filosofo-poeta autore del De Rerum Natura.



