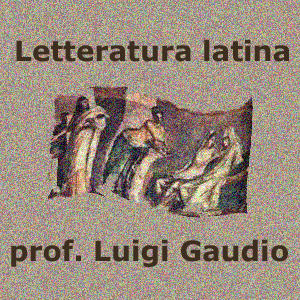
Il teatro italico delle origini
28 Dicembre 2019
La Germania nel trecento: declino dell’Impero medievale
28 Dicembre 2019Le testimonianze poetiche preletterarie in lingua latina si riferiscono a quel corpus di testi (spesso frammentari e giunti a noi indirettamente) che precedono la vera e propria produzione letteraria di autori riconosciuti, come Livio Andronico, Nevio o Ennio.
Si tratta di espressioni linguistiche e ritmiche legate prevalentemente alla tradizione orale, a contesti rituali, religiosi, sociali o ludici, e che ci offrono uno spaccato prezioso sull’uso più antico della lingua latina e sulla mentalità arcaica dei Romani.
Queste testimonianze, pur essendo “poetiche” nel senso di avere una forma metrica o ritmica riconoscibile, non sono “letterarie” nel senso di essere state create per un pubblico di lettori o per un valore estetico autonomo. Erano strettamente funzionali a un rito, a una celebrazione, a un gioco.
Caratteristiche delle Testimonianze Poetiche Preletterarie:
- Oralità: Erano concepite per essere recitate o cantate, spesso accompagnate da gesti o musiche. La memorizzazione era fondamentale.
- Funzionalità: Servivano a scopi pratici: invocare divinità, accompagnare riti agricoli, celebrare defunti, schernire, ecc.
- Anonimato: Non erano attribuite a singoli autori, ma appartenevano al patrimonio collettivo.
- Formalismo e Ripetitività: La loro natura rituale o magica implicava spesso formule fisse, ripetizioni, allitterazioni e assonanze, elementi che ne favorivano la memorizzazione e ne accentuavano l’efficacia rituale.
- Semplicità Linguistica: Il lessico è arcaico e spesso essenziale, con strutture sintattiche paratattiche.
- Metro Indigeno: Utilizzavano un ritmo proprio della lingua latina, diverso da quelli greco-ellenistici che sarebbero stati importati successivamente. Il metro più caratteristico era il verso saturnio.
Principali Esempi e Categorie:
-
Carmina Saliaria:
- Inni recitati dai sacerdoti Salii (danzatori), un collegio sacerdotale dedito al culto di Marte e Quirino.
- Testi estremamente oscuri e di difficile interpretazione anche per gli stessi Romani di epoche successive (come Cicerone o Varrone), a causa della loro antichità e del linguaggio arcaico.
- Contenevano invocazioni a divinità e descrizioni di riti guerrieri. Ci sono giunti solo frammenti e citazioni.
-
Carmina Arvalia:
- Inno recitato dai Fratelli Arvali, un collegio sacerdotale dedito al culto della dea Dea Dia, divinità della fertilità agraria.
- Testimonianza di un rito propiziatorio per la fertilità dei campi. Un frammento ci è giunto per iscritto (inciso su una lapide nel III secolo d.C.), il che testimonia la sua persistenza rituale.
- Il testo è caratterizzato da ripetizioni e invocazioni (“Enos Lases iuvate!” – “O Lari, aiutateci!”).
-
Fescennina Versa:
- Canti popolari, spesso improvvisati, di carattere rustico, scherzoso, a volte osceno e offensivo.
- Erano recitati durante feste di ringraziamento agricolo, matrimoni o trionfi. Avevano una funzione apotropaica (per allontanare il malocchio) e catartica.
- Rappresentano la radice più antica della comicità e della satira latina. Cicerone e Livio ne fanno menzione.
-
Neniae (Lamentazioni Funebri):
- Canti funebri intonati da donne professioniste (praeficae) durante i funerali, per celebrare le virtù del defunto e esprimere il dolore.
- Avevano una funzione rituale e sociale, contribuendo a mantenere viva la memoria degli antenati.
-
Leges Regiae e Tracce nel Diritto:
- Alcune delle più antiche leggi romane (attribuite al periodo monarchico) e formule giuridiche presentano una marcata ritmicità e allitterazione, suggerendo un’origine orale e la necessità di facilitarne la memorizzazione e l’applicazione pubblica. Ad esempio, la formula del giuramento o alcune massime legali.
-
Carmen Saliare (in senso lato) e Carmen Conviale:
- Oltre agli inni specifici dei Salii, il termine carmen indicava genericamente una formula ritmica.
- I carmina convivalia erano canti celebrativi delle virtù degli antenati, eseguiti durante i banchetti, spesso accompagnati dalla lira. Erano un modo per tramandare la storia familiare e civica.
-
Il Verso Saturnio:
- È il metro indigeno per eccellenza della poesia latina arcaica. La sua struttura è complessa e discussa, ma si basa su un’alternanza di sillabe lunghe e brevi, con una marcata cesura centrale.
- Fu utilizzato anche dai primi poeti “letterari” come Livio Andronico (nella traduzione dell’Odissea) e Nevio (nel Bellum Poenicum), prima di essere soppiantato dai metri di derivazione greca (esametro).
Importanza e Significato:
Le testimonianze poetiche preletterarie, sebbene frammentarie, sono fondamentali per diverse ragioni:
- Linguistica: Ci offrono il quadro più antico della lingua latina, con le sue peculiarità fonetiche, morfologiche e lessicali, aiutandoci a comprendere l’evoluzione della lingua.
- Culturale e Sociale: Rivelano aspetti cruciali della mentalità romana arcaica: il forte legame con la religione agraria e guerriera, l’importanza del rito, della memoria collettiva e della celebrazione degli antenati.
- Origini della Letteratura: Dimostrano l’esistenza di una sensibilità ritmica e di forme espressive strutturate nel latino molto prima dell’arrivo dell’influenza greca. Sono le radici su cui si sarebbe innestata la grande tradizione letteraria latina.
In definitiva, queste “voci” antiche ci permettono di intravedere un universo culturale in cui la parola, il ritmo e il rito erano indissolubilmente legati, fornendoci un ponte verso le origini della civiltà romana e della sua lingua.



