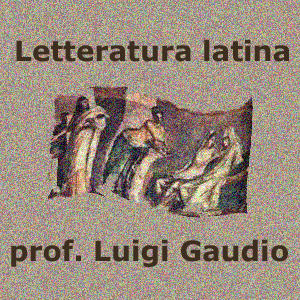
Il teatro italico delle origini
28 Dicembre 2019
La Germania nel trecento: declino dell’Impero medievale
28 Dicembre 2019Cola di Rienzo rappresenta una delle figure più affascinanti e contraddittorie del XIV secolo italiano, incarnando tanto le aspirazioni di rinnovamento politico e sociale quanto le contraddizioni strutturali che caratterizzavano l’Italia comunale del suo tempo.
Origini e formazione
Niccolò di Lorenzo, detto Cola di Rienzo, nacque a Roma intorno al 1313 da una famiglia di estrazione popolare. Il padre era oste e la madre lavandaia, ma il giovane riuscì a ottenere un’educazione che lo mise a contatto con la cultura classica e la tradizione giuridica romana. Questa formazione autodidatta, unita a una naturale eloquenza, gli permise di acquisire una conoscenza approfondita della storia romana antica, che divenne il fondamento ideologico della sua azione politica.
La Roma del primo Trecento in cui Cola crebbe era una città profondamente degradata. L’assenza del papato, trasferitosi ad Avignone nel 1309, aveva lasciato un vuoto di potere riempito dalle grandi famiglie baronali, principalmente Colonna e Orsini, che si contendevano il controllo della città attraverso continue faide. La popolazione romana viveva in condizioni di insicurezza costante, mentre i monumenti antichi cadevano in rovina e l’autorità municipale risultava praticamente inesistente.
La prima esperienza di potere (1347)
L’ascesa di Cola al potere nel 1347 fu preparata da un’intensa attività di agitazione popolare. Utilizzando la sua capacità oratoria e la suggestione dei richiami alla grandezza romana antica, riuscì a coalizzare il malcontento dei ceti medi e popolari contro il dominio baronale. Il 20 maggio 1347, con un colpo di mano, assunse il titolo di “Tribuno della libertà, della pace e della giustizia, liberatore della sacra repubblica romana”.
Il programma di Cola si fondava su una visione utopistica della restaurazione romana. Egli intendeva ricostituire l’antica repubblica, estendendo la cittadinanza romana a tutti gli italiani e rivendicando per Roma un ruolo di guida politica sulla penisola. Questa concezione, per quanto visionaria, intercettava aspirazioni reali di unificazione e pacificazione che trovavano eco in diversi ambienti intellettuali dell’epoca, come testimonia l’iniziale sostegno di Petrarca.
Le prime misure del governo tribunizio furono efficaci: Cola riuscì a imporre l’ordine pubblico, a ridurre il potere delle fazioni baronali e a introdurre riforme amministrative e giudiziarie che migliorarono le condizioni di vita della popolazione. Tuttavia, la sua politica si caratterizzò ben presto per un crescente autoritarismo e per iniziative di politica estera sempre più ambiziose e irrealistiche.
Il declino e l’esilio
L’isolamento di Cola si accentuò progressivamente. La sua pretesa di estendere l’autorità romana su tutta l’Italia suscitò l’ostilità delle altre città e dei signori della penisola. Il papa Clemente VI, inizialmente favorevole, si allarmò per le implicazioni delle rivendicazioni tribunizie sul potere temporale della Chiesa. I baroni romani, momentaneamente messi a tacere, organizzarono la resistenza.
La battaglia di Porta San Lorenzo del novembre 1347, in cui Cola sconfisse una coalizione baronale, rappresentò paradossalmente l’inizio della sua fine. La vittoria accentuò infatti le sue tendenze megalomani, portandolo a comportamenti sempre più eccentrici che alienarono il sostegno popolare. Nel dicembre 1347 fu costretto ad abdicare e a fuggire da Roma.
Il periodo praghese e i rapporti con Carlo IV
L’esilio di Cola lo condusse prima tra i francescani spirituali d’Abruzzo, poi alla corte di Carlo IV a Praga. Questo periodo, spesso trascurato, fu in realtà cruciale per comprendere l’evoluzione del pensiero politico di Rienzo. A Praga entrò in contatto con ambienti intellettuali che elaboravano teorie sulla renovatio imperii, trovando nel progetto carolino di restaurazione imperiale una possibile sintesi tra le proprie aspirazioni e la realtà politica del tempo.
Carlo IV, pur trattenendo Cola come “prigioniero dorato”, era interessato alle sue conoscenze della situazione italiana e alle sue capacità di mobilitazione popolare. Questa fase permise a Rienzo di raffinare la propria visione politica, integrando elementi dell’ideologia imperiale con le originarie aspirazioni repubblicane romane.
Il ritorno e la morte (1354)
Il ritorno di Cola a Roma nel 1354, sostenuto dal nuovo papa Innocenzo VI e dal cardinale Albornoz, si inseriva nella più ampia strategia pontificia di restaurazione dell’autorità papale nello Stato della Chiesa. Tuttavia, il secondo governo tribunizio si rivelò ben diverso dal primo. Cola, ormai segnato dall’esilio e dalle delusioni, governò con metodi sempre più dispotici, alienandosi rapidamente il sostegno popolare.
L’introduzione di nuove tasse per finanziare progetti grandiosi e la repressione violenta del dissenso trasformarono l’antico tribuno del popolo in un tiranno. Il 8 ottobre 1354, durante una rivolta popolare, Cola fu ucciso davanti al Campidoglio, chiudendo tragicamente una parabola politica che aveva incarnato tanto le speranze quanto le illusioni del suo tempo.
Significato storico e culturale
L’esperienza di Cola di Rienzo va oltre la dimensione della cronaca locale romana per assumere un significato paradigmatico nella storia italiana del Trecento. La sua vicenda illustra le contraddizioni di un’epoca di transizione, in cui aspirazioni di rinnovamento si scontravano con strutture politiche e sociali consolidate.
Dal punto di vista ideologico, Cola anticipò temi che sarebbero divenuti centrali nel pensiero politico rinascimentale: il richiamo all’antichità classica come modello di organizzazione politica, l’idea di una missione italiana di Roma, la tensione tra repubblicanesimo e necessità di un governo forte. La sua elaborazione teorica, pur ingenua in molti aspetti, contribuì a mantenere viva una tradizione di pensiero che avrebbe trovato espressione più matura in autori successivi.
L’influenza di Cola si estese anche al campo letterario e artistico. Petrarca, che aveva inizialmente salutato con entusiasmo la sua ascesa, elaborò attraverso il confronto con l’esperienza rienzeana alcune delle sue riflessioni più mature sul rapporto tra letteratura e politica. La figura del tribuno divenne inoltre un topos della cultura italiana, simbolo dell’eterna tensione tra ideale e realtà che caratterizza la storia della penisola.
La vicenda di Cola di Rienzo rimane quindi emblematica di un momento cruciale della storia italiana, in cui si delinearono aspirazioni e contraddizioni destinate a caratterizzare a lungo il dibattito politico e culturale del paese.



