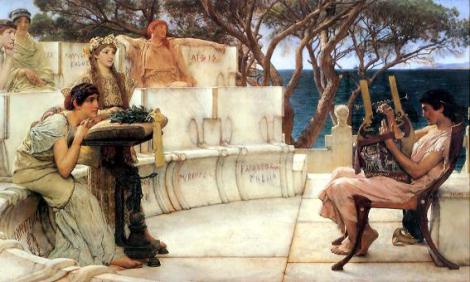Cola di Rienzo
28 Dicembre 2019
Le crociate
28 Dicembre 2019Il I secolo a.C. rappresenta un periodo di svolta nella letteratura latina, in particolare per lo sviluppo della lirica.
Prima di allora, la poesia latina era stata dominata da forme epiche, drammatiche o celebrative, spesso con finalità didascaliche o politiche. I primi veri “lirici” latini, nel senso di poeti che esprimono sentimenti personali e intimi, emergono proprio in questo contesto di grandi cambiamenti culturali e sociali.
I Primi Lirici Latini (Prima di Catullo)
Prima dell’affermazione di Catullo, la lirica latina come genere autonomo era ancora in fase embrionale. Non esisteva una tradizione consolidata di poesia soggettiva e intimista come quella greca arcaica (di Archiloco, Saffo, Alceo). La poesia romana delle origini era più legata a contesti rituali (Carmina Saliaria, Arvalia), celebrativi (Carmina Convivalia) o teatrali (la satira e la fabula Atellana).
Tuttavia, alcuni autori iniziarono a mostrare un interesse per l’espressione di sentimenti personali e a sperimentare con forme metriche nuove, pur rimanendo spesso legati a generi più tradizionali:
- Valerio Catone (Valerius Cato): Nonostante il suo nome, non si tratta di Catone il Censore. Valerio Catone fu un poetae novi (o “neoteroi”, come vedremo), ma è più noto come grammatico e maestro di poesia. La sua produzione lirica è andata perduta, ma è considerato un precursore di Catullo per l’attenzione alla forma, alla brevità e alla raffinatezza stilistica. Rappresenta la transizione verso la nuova sensibilità poetica.
- Levio (Laevius): Fu un autore di Erotopaegnia, ovvero “scherzi d’amore”. Anche di lui ci sono giunti solo pochi frammenti, ma il titolo stesso suggerisce una poesia leggera, dedicata a temi amorosi e a esperienze personali, con un linguaggio ricercato e una tendenza all’originalità metrica. Si colloca tra la vecchia tradizione e la sensibilità dei poetae novi.
Questi autori, pur minoritari rispetto ai giganti dell’epica e della commedia, gettarono le basi per l’emergere di una poesia più soggettiva e raffinata, che avrebbe trovato la sua massima espressione in Catullo.
Gaio Valerio Catullo (circa 84 a.C. – 54 a.C.)
Catullo è unanimemente considerato il più grande lirico latino, la voce più originale e intensa della poesia romana prima di Orazio e Virgilio. La sua opera è un punto di svolta, rappresentando l’introduzione di una lirica di stampo personale, che celebra l’amore, l’amicizia, il dolore, l’odio e le esperienze quotidiane con una sincerità e una profondità senza precedenti.
1. Il Contesto Culturale: I Poetae Novi (Neoteroi) Catullo fu il principale esponente dei poetae novi o neoteroi (“i nuovi poeti”). Questo gruppo di giovani intellettuali, attivi a Roma e in particolare nell’ambiente colto di Verona (la città di Catullo), si ribellava alla poesia tradizionale romana, considerata magniloquente, didascalica e impegnata in grandi temi pubblici (epica storica, tragedia). I neoteroi si ispiravano ai poeti ellenistici (in particolare a Callimaco di Cirene), che prediligevano:
- Brevitas: Brevità e concisione nelle composizioni.
- Labor Limæ: Cura estrema della forma, ricerca lessicale, perfezione stilistica.
- Lepton: Delicateszza, leggerezza, raffinatezza.
- Temi Quotidiani e Personali: Si concentravano su argomenti leggeri, amorosi, elegiaci, scherzosi, di amicizia, di vita quotidiana.
- Avanguardia Culturale: Erano intellettuali raffinati, che spesso disdegnavano la carriera politica per dedicarsi interamente alla poesia e alla vita mondana.
2. Il Liber di Catullo: Temi e Struttura L’opera di Catullo ci è giunta in un’unica raccolta, il Liber Catullianus, composta da 116 poesie (carmi) di varia lunghezza e metro. Tradizionalmente, il Liber è diviso in tre sezioni:
- Carmi 1-60 (Nugae): Le “sciocchezze”, “inezie”. Sono carmi brevi, leggeri, di varia tematica: poesie d’amore, invettive, scherzi, dediche, epigrammi. Qui spiccano i carmi dedicati all’amore per Lesbia.
- Carmi 61-68 (Carmina Docta): I “carmi dotti”. Sono poesie più lunghe e complesse, spesso di ispirazione ellenistica, con riferimenti mitologici e stilistici eruditi. Includono epitalami (canti nuziali), elegie e un carme epillico (una sorta di piccolo poema epico).
- Carmi 69-116 (Epigrammata): Carmi brevi, spesso di carattere satirico, scherzoso o di invettiva, con un tono più aspro e diretto.
3. L’Amore per Lesbia: Un Vortice di Emozioni Il tema centrale e più celebre della poesia di Catullo è l’amore per Lesbia. Sotto questo pseudonimo si cela Clodia, una donna nobile e influente, sorella del tribuno della plebe Publio Clodio Pulcro, nota per la sua bellezza e la sua vita dissoluta. L’amore di Catullo per Lesbia è un’esperienza totalizzante, che lo porta a esplorare l’intera gamma delle emozioni umane:
- L’Entusiasmo Iniziale: La gioia, la passione bruciante, la felicità di un amore che si crede eterno (celeberrimi i Basia: “Dammi mille baci, poi cento, poi altri mille…” – carme 5).
- La Delusione e il Conflitto: Il tradimento, la gelosia, la sofferenza per l’infedeltà di Lesbia.
- L’Odio e l’Amore (Odi et Amo): Il celeberrimo carme 85 (“Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. Nescio, sed fieri sentio et excrucior.” – “Odio e amo. Forse mi chiedi come faccia. Non lo so, ma sento che accade e mi tormento.”) esprime la contraddizione lacerante di un sentimento che non può più essere solo amore.
- L’Invettiva: L’amore si trasforma in odio e in feroci invettive contro Lesbia e i suoi amanti.
4. Altri Temi e la Lingua di Catullo: Oltre all’amore, Catullo esplora:
- L’Amicizia: Carmi dedicati agli amici, con toni affettuosi, scherzosi o di rimprovero.
- L’Invettiva: Forti attacchi contro personaggi politici e sociali (come Cesare, Cicerone, Mamurra), spesso con un linguaggio scurrile e volgare, che riflette la libertà espressiva del poeta.
- Il Dolore Personale: Il lutto per la morte del fratello (carme 101, una commovente elegia).
- La Vita Quotidiana: Descrizioni di viaggi, banchetti, situazioni comuni.
La lingua di Catullo è straordinariamente innovativa:
- Combina il linguaggio aulico e raffinato tipico della poesia ellenistica con espressioni colloquiali, gergali e persino oscene.
- Utilizza neologismi, diminutivi e un lessico ricco e variegato.
- Sperimenta con una vasta gamma di metri greci, adattandoli al latino con maestria.
L’Eredità di Catullo
L’opera di Catullo rappresentò una rivoluzione nella poesia latina. Fu il primo a portare sulla scena letteraria romana l’individuo con tutte le sue passioni, le sue gioie e i suoi dolori, con una sincerità e una modernità che avrebbero influenzato profondamente la poesia successiva. Orazio, pur con uno stile più equilibrato e classicista, e Tibullo e Properzio, grandi elegiaci, furono debitori della sua lezione. Catullo dimostrò che la lirica personale poteva raggiungere vette altissime anche in latino, aprendo la strada a generazioni di poeti.