
Un sopruso feudale Lucia e Don Rodrigo
28 Dicembre 2019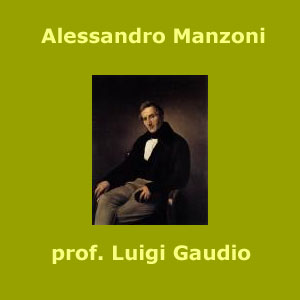
L’ironia manzoniana
28 Dicembre 2019Saggio sulla Storia della colonna infame e la responsabilità degli uomini
“La Storia della colonna infame” di Alessandro Manzoni, saggio storico pubblicato in appendice all’edizione definitiva de I Promessi Sposi nel 1840, è un’opera di straordinaria potenza e lucidità che, partendo da un tragico episodio della Milano del Seicento, si interroga profondamente sulla responsabilità degli uomini di fronte al male, alla giustizia e alla verità. L’opera non è solo una ricostruzione storica, ma una riflessione etica e giuridica che condanna non solo l’ignoranza dei tempi, ma soprattutto la malvagità e la colpevolezza morale di individui che, pur rivestendo cariche pubbliche, si resero protagonisti di un’aberrante ingiustizia.
La Tragedia degli Untori: Contesto e Fatti
Manzoni ricostruisce il processo avvenuto a Milano durante la terribile peste del 1630 (la stessa che flagella i personaggi de I Promessi Sposi). In un clima di terrore, superstizione e disperazione per un morbo incomprensibile, si diffuse la credenza negli “untori”: individui che avrebbero sparso il contagio ungendo porte e muri con sostanze velenose. Questa credenza, frutto della paura e dell’ignoranza scientifica dell’epoca, fu alimentata dalla propaganda delle autorità stesse, che trovarono in essa un facile capro espiatorio per deviare l’attenzione dalla loro inefficienza nella gestione dell’epidemia.
La vicenda centrale narrata da Manzoni è quella di Guglielmo Piazza, un commissario di sanità, e Gian Giacomo Mora, un barbiere, accusati di essere untori. Le prove contro di loro erano inesistenti o del tutto inconsistenti, basate su delazioni, malintesi e dicerie popolari. Nonostante ciò, i due furono sottoposti a tortura feroce, un metodo di interrogatorio accettato dalla giurisprudenza del tempo per estorcere confessioni. Sotto la tortura, Piazza e Mora confessarono crimini mai commessi e, per alleviare le proprie sofferenze, accusarono a loro volta innocenti, trascinandoli in un infernale circolo vizioso di menzogne e dolore. Alla fine, nonostante le loro ritrattazioni e l’evidenza della loro innocenza, furono condannati a morte con pene atroci e la bottega di Mora fu rasa al suolo, e sulle sue ceneri fu eretta la Colonna Infame a “perenne monito” del loro presunto crimine.
La Responsabilità dei Giudici: Ignoranza o Malvagità?
Il fulcro dell’indagine di Manzoni non è tanto l’esistenza della superstizione degli untori (che egli riconosce come frutto dei “tempi”), quanto la responsabilità dei giudici che condussero il processo e pronunciarono le sentenze. Manzoni si oppone alla tesi, sostenuta da altri illuministi come Pietro Verri (Osservazioni sulla tortura), che attribuivano la tragedia unicamente all’ignoranza e alla barbarie del Seicento. Per Manzoni, se è vero che il contesto era quello di un’epoca meno “illuminata”, ciò non assolve gli uomini di legge.
La tesi di Manzoni è chiara: i giudici (come Monti, Trotti e Visconti) furono pienamente colpevoli e moralmente responsabili delle loro azioni. Egli argomenta che, sebbene le leggi del tempo permettessero la tortura e fossero imperfette, esse non imponevano le conclusioni assurde a cui giunsero i magistrati. Anzi, le stesse norme e i testi giuridici citati nel processo avrebbero dovuto portare a risultati diversi se fossero stati applicati con diligenza e onestà intellettuale.
Manzoni sottolinea come l’ignoranza in fisica (l’incapacità di capire la vera natura del contagio) non potesse in alcun modo giustificare le iniquità giuridiche. L’errore fatale dei giudici non fu dovuto a una fatalità storica, ma a una concatenazione di:
- Viltà e cedimento alla pressione popolare: Di fronte al terrore della peste e alla rabbia della folla che esigeva colpevoli, i giudici, pur consapevoli delle assurdità delle accuse e delle prove, non ebbero il coraggio di opporsi. Essi diventarono “complici o ministri d’una moltitudine che, accecata, non dall’ignoranza, ma dalla malignità e dal furore, violava con quelle grida i precetti più positivi della legge divina”.
- Malignità e malafede: Manzoni evidenzia una vera e propria malizia nell’agire dei giudici. Non si limitarono a sbagliare in buona fede, ma agirono con una “malvagità” calcolata, ignorando le prove a favore degli accusati e applicando la tortura in modo spietato per estorcere confessioni preordinate. Essi scelsero di perseguitare innocenti per apparire efficaci e per placare la folla.
- Orgoglio professionale: Forse c’era anche un orgoglio professionale che impediva loro di ammettere l’assurdità delle accuse e di affrontare la rabbia popolare, preferendo condannare pur di mantenere la propria autorità e il proprio ruolo.
- Mancanza di pietà umana: La crudeltà delle torture e delle condanne, descritte con orrore da Manzoni, mostra una totale assenza di compassione e di senso di umanità.
Manzoni, a differenza di altri storici o filosofi, non accetta di ridurre la colpa a un mero “effetto dei tempi e delle circostanze”. Egli insiste sul libero arbitrio e sulla responsabilità individuale. I giudici, pur operando in un contesto di terrore e ignoranza, fecero delle scelte precise, e per quelle scelte erano e restano colpevoli. La “Storia della colonna infame” è un’indagine morale sulla capacità dell’uomo di deviare dal bene, anche in condizioni estreme, e sulla terribile responsabilità che deriva dall’esercizio del potere.
La Colonna Infame: Da Infamia dei Condannati a Onore dei Giudici
Il simbolo più eloquente della riflessione manzoniana è la Colonna Infame stessa. Originariamente eretta per infamare i presunti untori e per ammonire la popolazione, essa si trasforma, nella visione di Manzoni (e già in quella illuminista di Pietro Verri), in un monumento all’infamia dei giudici. È un rovesciamento di significato che avviene nel corso dei secoli: la lapide incisa sul monumento, che avrebbe dovuto condannare Piazza e Mora, diventa invece una testimonianza eterna dell’abuso di potere, della crudeltà e dell’ingiustizia di coloro che agirono in nome della legge. L’abbattimento della Colonna nel 1778, voluto dagli illuministi, simboleggia la vittoria della ragione e della giustizia sulla barbarie. Manzoni, quindi, opera una rilettura del passato non solo storiografica, ma etica, riscattando la memoria degli innocenti e condannando i veri colpevoli.
Un Monito per l’Eternità: L’Attualità della Responsabilità
“La Storia della colonna infame” è un’opera di un’attualità sconvolgente. Il suo messaggio sulla responsabilità degli uomini è universale e intramontabile. Manzoni ci insegna che, anche in tempi di crisi, di paura collettiva o di isteria sociale, l’individuo (soprattutto chi detiene il potere) non può esimersi dalla propria responsabilità morale. Questo si collega al tema della responsabilità individuale in contesti di violenza o di oppressione, come il caso dei “burocrati del Male” di cui parla Leonardo Sciascia, che rileggono Manzoni per analizzare figure che, pur colte e insospettabili, si rendono complici di orrori. L’opera manzoniana è un monito contro:
- Il fanatismo e l’irrazionalità: Che possono portare a cercare capri espiatori e a sospendere il pensiero critico di fronte alla paura (come la ricerca degli “untori” nella pandemia di Covid-19 o le teorie complottiste).
- L’abuso di potere: La facilità con cui la legge può essere piegata, e la giustizia travolta, quando è al servizio della prepotenza o della paura.
- La viltà e la compiacenza: La condanna non è solo per i carnefici, ma anche per coloro che, pur non agendo direttamente, non si oppongono all’ingiustizia per paura o convenienza (come Don Abbondio in I Promessi Sposi).
- La negazione del libero arbitrio: Manzoni ci ricorda che anche in contesti storici difficili, l’uomo conserva la capacità di scegliere tra il bene e il male, e per quelle scelte è moralmente responsabile.
In un’epoca in cui le fake news, i bias cognitivi (come quelli degli algoritmi dell’IA, vedi B3 Sessione straordinaria 2024) e la polarizzazione dell’opinione pubblica possono generare nuove forme di “caccia all’untore”, il saggio di Manzoni ci invita a una costante vigilanza critica, a difendere la ragione contro l’irrazionalità e a non delegare mai la nostra coscienza morale, specialmente quando si tratta di giudicare e di agire sulla vita degli altri. La sua lezione sulla responsabilità individuale rimane un pilastro fondamentale del pensiero etico moderno.




