
Un sopruso feudale Lucia e Don Rodrigo
28 Dicembre 2019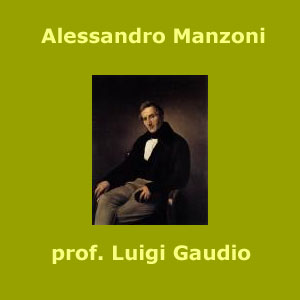
L’ironia manzoniana
28 Dicembre 2019Dopo “I Promessi Sposi”: La Storia della Colonna Infame come complemento necessario
Introduzione: Due Opere, Un Unico Progetto
Quando Alessandro Manzoni pubblicò “I Promessi Sposi” nella sua edizione definitiva del 1840-42, allegò a quest’opera un testo che considerava inscindibile dal romanzo: “Storia della colonna infame”. Questa scelta editoriale non fu casuale, ma rispondeva a una precisa volontà dell’autore di completare il proprio discorso sulla giustizia, sulla verità storica e sulla responsabilità umana di fronte al male.
La “Storia della colonna infame” racconta un episodio realmente accaduto durante la peste del 1630 a Milano: l’ingiusta condanna a morte di Guglielmo Piazza e Gian Giacomo Mora, accusati di essere untori, ovvero di diffondere volontariamente il contagio spalmando unguenti pestiferi sui muri della città. Il processo, conclusosi con l’esecuzione dei due innocenti e l’erezione di una colonna infame nel luogo dove sorgeva la casa del Mora, rappresenta uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia italiana.
Il Rapporto Organico tra le Due Opere
Complementarità Tematica
La relazione tra “I Promessi Sposi” e la “Storia della colonna infame” si articola su diversi livelli. Innanzitutto, entrambe le opere sono ambientate nella Milano del Seicento, durante il periodo della dominazione spagnola, e hanno come sfondo storico la terribile peste del 1629-1631. Tuttavia, mentre nel romanzo la peste costituisce uno degli episodi della narrazione, nella “Storia” diventa il pretesto che scatena l’ingiustizia giudiziaria.
Nel romanzo, Manzoni aveva già affrontato il tema della superstizione popolare legata agli untori, dedicando alcuni capitoli memorabili alla descrizione del clima di terrore e sospetto che accompagnava l’epidemia. La “Storia della colonna infame” approfondisce questa tematica, mostrandone le conseguenze più tragiche quando la superstizione si trasforma in strumento di oppressione giudiziaria.
La Questione della Giustizia
Entrambe le opere pongono al centro la riflessione sulla giustizia terrena e sui suoi limiti. Nei “Promessi Sposi”, i protagonisti subiscono ingiustizie ma trovano alla fine una riparazione, sia pure parziale; la Provvidenza divina sembra guidare gli eventi verso un esito positivo, nonostante le sofferenze patite. Nella “Storia della colonna infame”, invece, l’ingiustizia trionfa completamente: gli innocenti muoiono tra i tormenti, i veri responsabili dell’errore giudiziario non vengono puniti, e solo la storia potrà ristabilire la verità.
Il Metodo Storiografico di Manzoni
Dalle Fonti alla Narrazione
La “Storia della colonna infame” rappresenta un esempio paradigmatico del metodo storiografico manzoniano. L’autore non si limita a narrare i fatti, ma li sottopone a un’analisi critica rigorosa, confrontando le diverse fonti disponibili e mettendo in luce le contraddizioni e le assurdità del processo. Manzoni consulta gli atti processuali, le cronache dell’epoca, le opere di storici precedenti come Pietro Verri, ma non si accontenta di ripetere quanto già scritto: vuole capire le ragioni profonde dell’errore giudiziario.
Il confronto con Pietro Verri, che aveva già trattato lo stesso episodio nelle sue “Osservazioni sulla tortura”, è particolarmente significativo. Verri aveva attribuito l’ingiustizia principalmente all’uso della tortura e all’ignoranza dei giudici. Manzoni, pur riconoscendo il peso di questi fattori, va oltre: individua nelle scelte consapevoli dei magistrati, nella loro volontà di trovare colpevoli a ogni costo, la vera causa dell’errore.
La Responsabilità Individuale
Una delle innovazioni più importanti della “Storia della colonna infame” rispetto alla storiografia precedente è l’accento posto sulla responsabilità individuale. Manzoni rifiuta le spiegazioni che attribuiscono l’ingiustizia solamente ai tempi, alle circostanze, all’ignoranza generale dell’epoca. I giudici del processo agli untori avevano a disposizione tutti gli elementi per comprendere l’innocenza degli accusati, ma scelsero deliberatamente di ignorarli.
Questa impostazione rivela la modernità del pensiero manzoniano: mentre la cultura del suo tempo tendeva a giustificare gli errori del passato con il progresso della civiltà, Manzoni sostiene che la responsabilità morale dell’individuo rimane costante attraverso i secoli. Non esistono epoche che giustifichino l’ingiustizia consapevole.
La Critica al Sistema Giudiziario
L’Analisi del Processo
La ricostruzione del processo agli untori occupa la parte centrale della “Storia della colonna infame” e costituisce un capolavoro di analisi giuridica e psicologica. Manzoni segue passo dopo passo lo svolgersi delle indagini e del dibattimento, mostrando come ogni elemento a discarico degli accusati venga sistematicamente ignorato o travisato.
Il caso inizia con la denuncia di una donna, Caterina Rosa, che sostiene di aver visto Guglielmo Piazza, commissario di sanità, toccare i muri di alcune case con le mani unte. L’accusa è palesemente assurda: perché mai un commissario di sanità, il cui compito era proprio quello di combattere la peste, avrebbe dovuto diffonderla? Eppure i giudici decidono di procedere, forse spinti dalla pressione popolare, forse dalla volontà di trovare un capro espiatorio per la tragedia che sta colpendo la città.
La Tortura come Strumento di Ingiustizia
L’uso della tortura nel processo viene analizzato da Manzoni non solo come pratica crudele, ma come strumento che corrompe la ricerca della verità. La tortura non serve a far confessare i colpevoli, ma a far dire agli innocenti quello che i giudici vogliono sentire. Il caso di Gian Giacomo Mora è emblematico: sottoposto a tormenti atroci, finisce per accusare se stesso e altri innocenti, pur di far cessare le sofferenze.
Manzoni mostra come la tortura crei un circolo vizioso: più gli accusati, sotto il dolore, inventano particolari fantasiosi per soddisfare i giudici, più questi si convincono della fondatezza dell’accusa. La verità viene così definitivamente sepolta sotto le menzogne estorte con la violenza.
Il Valore Universale dell’Opera
Oltre la Cronaca Storica
Sebbene la “Storia della colonna infame” racconti un episodio specifico del Seicento milanese, il suo valore trascende i limiti cronologici e geografici. L’opera affronta temi universali che mantengono la loro attualità: il rapporto tra potere e giustizia, il pericolo rappresentato dai pregiudizi e dalla superstizione, la facilità con cui l’opinione pubblica può essere manipolata dalla paura.
Il meccanismo del capro espiatorio, descritto con lucidità da Manzoni, si ripete ciclicamente nella storia umana. Di fronte a calamità inspiegabili, le società tendono a cercare responsabili da punire, spesso tra i più deboli e indifesi. La peste del 1630 diventa così metafora di tutte le crisi che inducono le comunità umane a sacrificare la giustizia sull’altare della rassicurazione psicologica.
La Lezione per il Presente
Manzoni scrive la “Storia della colonna infame” anche per mettere in guardia i suoi contemporanei. L’Ottocento, con le sue rivoluzioni e i suoi cambiamenti, poteva sembrare definitivamente libero dai pregiudizi e dalle superstizioni del passato. L’autore invece avverte che i meccanismi psicologici e sociali che portarono alla condanna degli untori rimangono sempre possibili.
La modernità della riflessione manzoniana emerge chiaramente nella sua analisi della comunicazione e dell’opinione pubblica. L’autore mostra come le voci, i sospetti, le dicerie si diffondano e si amplifichino fino a diventare “verità” incontestabili. In questo senso, la “Storia della colonna infame” anticipa molte delle riflessioni contemporanee sui meccanismi della disinformazione e della manipolazione dell’opinione pubblica.
Lo Stile e la Struttura Narrativa
Tra Storia e Letteratura
La “Storia della colonna infame” si colloca in una posizione particolare nel panorama letterario italiano: non è un romanzo, ma non è nemmeno una fredda ricostruzione storiografica. Manzoni riesce a coniugare il rigore documentario con la potenza narrativa, creando un’opera che coinvolge emotivamente il lettore senza mai tradire la verità storica.
Lo stile è più asciutto e severo rispetto a quello dei “Promessi Sposi”, ma non mancano momenti di alta tensione drammatica, come la descrizione delle torture o il racconto dell’esecuzione. L’autore sa alternare l’analisi razionale dei documenti con la partecipazione umana alle sofferenze degli innocenti.
La Struttura Argomentativa
L’opera è strutturata come una dimostrazione logica: Manzoni presenta la tesi (l’innocenza degli accusati), esamina le prove (gli atti del processo), confuta le obiezioni (le giustificazioni dei contemporanei e degli storici precedenti), e giunge alla conclusione (la condanna dei veri responsabili dell’ingiustizia).
Questa impostazione argomentativa conferisce al testo una forza persuasiva straordinaria. Il lettore viene guidato attraverso un percorso logico ineccepibile che lo porta a condividere non solo le conclusioni dell’autore, ma anche il suo sdegno morale per l’ingiustizia compiuta.
L’Eredità dell’Opera
Influenza sulla Cultura Italiana
La “Storia della colonna infame” ha avuto un’influenza profonda sulla cultura italiana successiva. Ha contribuito a diffondere una concezione moderna della giustizia, basata sul rispetto dei diritti dell’accusato e sulla presunzione di innocenza. Ha anche sensibilizzato l’opinione pubblica sui pericoli rappresentati dai pregiudizi e dalle superstizioni.
L’opera ha ispirato numerosi scrittori e intellettuali, da Giovanni Verga a Leonardo Sciascia, che hanno affrontato il tema dell’ingiustizia giudiziaria riprendendo spesso le metodologie e le intuizioni manzoniane. Anche il cinema e il teatro hanno tratto ispirazione da quest’opera, dimostrando la sua persistente vitalità artistica.
Attualità del Messaggio
Nel mondo contemporaneo, caratterizzato da rapidi cambiamenti e da nuove forme di comunicazione, il messaggio della “Storia della colonna infame” mantiene tutta la sua attualità. I social media, con la loro capacità di amplificare e distorcere le informazioni, possono facilmente dar vita a campagne di odio che ricordano da vicino il clima di sospetto e di paura descritto da Manzoni.
I casi di cronaca giudiziaria, con il loro carico di errori e distorsioni, mostrano come i meccanismi analizzati dall’autore rimangano ancora operanti. La lezione manzoniana sulla necessità di distinguere tra verità processuale e verità storica, tra giustizia formale e giustizia sostanziale, conserva quindi tutto il suo valore.
Conclusione: Un Monito Perenne
La “Storia della colonna infame” rappresenta il completamento naturale del progetto letterario e morale dei “Promessi Sposi”. Mentre il romanzo mostrava come la Provvidenza potesse far trionfare la giustizia attraverso le vicende private di umili persone, la “Storia” dimostra che questo trionfo non è automatico né garantito: richiede l’impegno costante degli uomini di buona volontà.
L’opera si configura così come un monito perenne contro l’indifferenza morale e l’acquiescenza di fronte all’ingiustizia. Manzoni ci ricorda che ogni generazione deve conquistarsi nuovamente i valori della giustizia e della verità, senza mai dare per scontato che il progresso della civiltà li garantisca automaticamente.
La colonna infame, eretta per perpetuare la memoria di un’infamia inesistente, fu abbattuta alla fine del Settecento. Ma Manzoni, con la sua opera, ha eretto un monumento ben più duraturo: quello alla memoria delle vittime dell’ingiustizia e alla necessità di vigilare perché simili errori non si ripetano. In questo senso, la “Storia della colonna infame” non è solo il complemento dei “Promessi Sposi”, ma ne rappresenta il necessario contrappunto morale, dimostrando che la letteratura può e deve farsi carico della responsabilità di educare le coscienze e di difendere i valori umani fondamentali.




