
Gloria del disteso mezzogiorno, Casa sul mare e Dora Markus di Montale
28 Dicembre 2019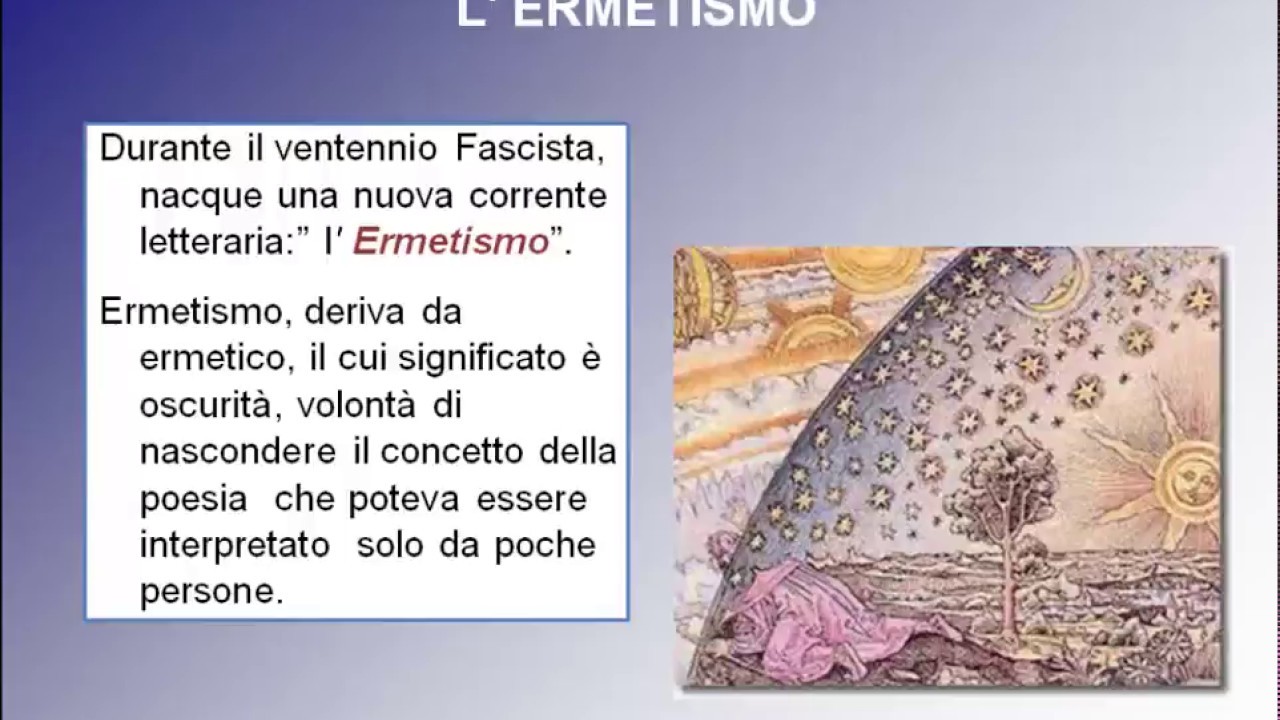
La poesia “La preghiera” in Sentimento del tempo di Giuseppe Ungaretti
28 Dicembre 2019Ungaretti vs. Montale: due voci inconfondibili della poesia italiana del ‘900
Giuseppe Ungaretti e Eugenio Montale rappresentano due pilastri fondamentali della poesia italiana del ventesimo secolo, pur distinguendosi per sensibilità poetiche, percorsi stilistici e visioni del mondo profondamente diversi. Sebbene entrambi abbiano attraversato le tormentate vicende storiche e culturali del Novecento, le loro risposte artistiche hanno dato vita a opere di inestimabile valore che li pongono su fronti solo apparentemente distanti.
Ungaretti, considerato l’iniziatore dell’Ermetismo, emerge dalle trincee della Prima Guerra Mondiale con una poesia scarnificata, essenziale, quasi un grido primordiale di fronte all’orrore e alla fragilità dell’esistenza. La sua ricerca si concentra sulla parola isolata, liberata dai vincoli metrici e sintattici tradizionali, caricata di un intenso valore evocativo e analogico. L’esperienza autobiografica, il dolore, il rapporto con la fede e la memoria diventano linfa vitale per componimenti brevissimi ma densissimi di significato, come quelli raccolti ne L’allegria. La sua poetica mira a restituire alla parola la sua purezza originaria, in un tentativo di cogliere l’attimo fuggente e rivelare un senso recondito della vita e del cosmo. Successivamente, in opere come Sentimento del tempo e Il Dolore, la sua poesia evolve verso forme più distese e un recupero della tradizione lirica italiana, pur mantenendo l’intensità emotiva e la profondità esistenziale.
Montale, dal canto suo, si presenta con una voce più misurata e meditativa, caratterizzata da un profondo pessimismo esistenziale e da una costante interrogazione sul senso della condizione umana. La sua poesia, spesso definita “oggetto correlativo”, non esprime direttamente i sentimenti del poeta, ma li affida a immagini concrete, a paesaggi aspri e quotidiani, a oggetti umili che diventano simboli di un malessere universale e di una ricerca di un varco, di un “miracolo” laico in un’esistenza percepita come un muro invalicabile. Le raccolte come Ossi di seppia, Le occasioni e La bufera e altro delineano un universo poetico popolato da figure femminili salvifiche (le “figure angeliche” o “meduse”) e da un paesaggio ligure desolato che riflette l’aridità interiore. La sua lingua è colta, ricca di riferimenti letterari e classici, con una sintassi più articolata rispetto a Ungaretti, sebbene lontana da ogni forma di retorica vuota.
Le principali differenze tra i due poeti risiedono dunque nell’approccio al linguaggio, nella struttura del verso e nella visione del mondo. Mentre Ungaretti cerca l’essenzialità e l’illuminazione attraverso la singola parola e un lirismo immediato, Montale costruisce il suo significato attraverso la rete di corrispondenze tra il soggetto e il mondo esterno, mediata dall’oggetto. Se la poesia ungarettiana si nutre di un impeto quasi mistico e di un’apertura verso l’assoluto, quella montaliana è più radicata nella realtà fenomenica, indagata con lucidità disincantata e venata da una sottile ironia.
Nonostante le divergenze, entrambi i poeti hanno condiviso la consapevolezza della crisi del linguaggio poetico tradizionale e la necessità di una sua rifondazione di fronte alle sfide della modernità e alla tragedia della storia. Entrambi hanno cercato nuove forme per esprimere l’indicibile, lasciando un’eredità inestimabile che ha profondamente influenzato le generazioni successive di poeti italiani. Il confronto tra Ungaretti e Montale non si risolve in una semplice contrapposizione, ma rivela la ricchezza e la complessità della poesia italiana del Novecento, capace di confrontarsi con l’esistenza umana in tutte le sue sfaccettature.
🎤🎧 Audio Lezioni, ascolta il podcast su Giuseppe Ungaretti del prof. Gaudio
Ascolta “Giuseppe Ungaretti” su Spreaker.



