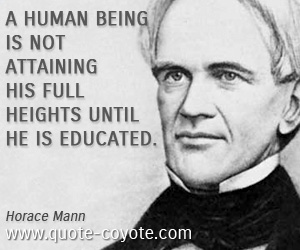
L’istruzione pubblica per Horace Mann
28 Dicembre 2019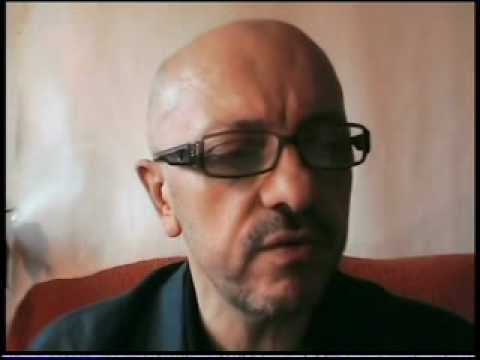
Riappropriamoci di Don Milani
28 Dicembre 2019Orizzonti nelle letture e nell’orientamento dei ragazzi di scuola media: percorsi formativi per la costruzione dell’identità, riflessioni su incontro video con Cristina Casaschi
Introduzione
L’età della scuola secondaria di primo grado rappresenta una fase cruciale nello sviluppo cognitivo, emotivo e sociale degli adolescenti. In questo periodo di transizione, caratterizzato da profondi cambiamenti fisici e psicologici, la lettura e l’orientamento formativo assumono un ruolo fondamentale nella costruzione dell’identità personale e nel processo di socializzazione. Il presente contributo intende analizzare l’importanza delle pratiche di lettura e delle attività di orientamento come strumenti pedagogici complementari, capaci di ampliare gli orizzonti culturali ed esistenziali degli studenti in questa delicata fase evolutiva.
1. La lettura come strumento di formazione identitaria
1.1 Caratteristiche psicologiche del lettore preadolescente
Il ragazzo di scuola media si trova in una fase di sviluppo caratterizzata da una progressiva ristrutturazione dell’identità personale. Come evidenziato da studi psicopedagogici (Erikson, 1968; Bruner, 1986), in questa età emerge con forza la necessità di confrontarsi con modelli di identificazione diversi da quelli familiari e di esplorare nuove possibilità esistenziali. La lettura, in questo contesto, può configurarsi come un “laboratorio protetto” in cui sperimentare, attraverso l’identificazione con i personaggi, molteplici ruoli e possibilità di essere.
Il lettore preadolescente manifesta alcuni tratti caratteristici:
- Una curiosità esplorativa verso tematiche precedentemente ignorate
- Una capacità crescente di analisi critica, pur con limiti legati allo sviluppo cognitivo
- Un bisogno di confronto con esperienze e modelli diversificati
- Un’oscillazione tra la ricerca di realismo e il bisogno di evasione fantastica
1.2 Criteri di selezione dei testi
La scelta dei testi da proporre agli studenti di questa fascia d’età dovrebbe rispondere a criteri pedagogicamente fondati:
- Adeguatezza linguistica: testi che presentino una complessità lessicale e sintattica progressivamente crescente, in grado di stimolare l’arricchimento linguistico senza generare frustrazione
- Pertinenza tematica: opere che affrontino questioni rilevanti per questa fascia d’età (amicizia, relazioni familiari, prime esperienze sentimentali, confronto con le regole sociali, ricerca di significato)
- Pluralità di generi e forme testuali: dalla narrativa al testo poetico, dal fumetto al testo teatrale, offrendo un panorama diversificato di modalità espressive
- Equilibrio tra tradizione e contemporaneità: affiancando classici della letteratura giovanile a opere contemporanee che parlino del presente con linguaggi attuali
- Multiculturalità: proposte che favoriscano l’apertura a contesti culturali diversificati, stimolando il confronto interculturale
1.3 Pratiche didattiche efficaci
L’approccio didattico alla lettura nella scuola media dovrebbe superare modelli puramente trasmissivi per privilegiare pratiche attive e partecipative:
- Circoli di lettura: spazi di condivisione in cui gli studenti possano confrontarsi liberamente sulle proprie esperienze di lettura
- Laboratori di scrittura creativa: attività che permettano di rielaborare i contenuti delle letture attraverso produzioni personali
- Incontri con autori: momenti di dialogo diretto con scrittori che possano testimoniare il valore dell’esperienza letteraria
- Approcci multimediali: integrazione tra lettura tradizionale e nuovi media, favorendo percorsi di lettura transmediale
- Biblioteche di classe: creazione di spazi dedicati alla lettura libera e alla consultazione autonoma
2. L’orientamento come processo di scoperta di sé e del mondo
2.1 Ripensare l’orientamento in chiave formativa
Le attuali concezioni pedagogiche invitano a superare un approccio all’orientamento limitato alla scelta della scuola superiore per abbracciare una visione più ampia, intesa come processo continuo di costruzione del sé in relazione alle proprie attitudini, interessi e al contesto sociale. L’orientamento formativo si configura come:
- Un percorso di auto-conoscenza e valorizzazione delle proprie caratteristiche distintive
- Un’esplorazione delle possibilità offerte dal contesto sociale e dal mondo del lavoro
- Un’educazione alla scelta consapevole e alla progettualità personale
- Un’acquisizione di competenze trasversali utili in molteplici contesti di vita
2.2 Pratiche di orientamento nella scuola media
Le attività di orientamento, per risultare efficaci, dovrebbero articolarsi lungo tutto il triennio della scuola media secondo una progressione che preveda:
- Primo anno: attività centrate sull’auto-conoscenza, l’analisi delle proprie attitudini e la valutazione realistica dei propri punti di forza e debolezza
- Secondo anno: esplorazione del territorio, delle sue risorse formative e lavorative, con attività di conoscenza dei diversi settori professionali
- Terzo anno: percorsi di decisione consapevole, con approfondimenti sulle opportunità scolastiche post-medie e simulazioni di scelta
Gli strumenti didattici possono includere:
- Questionari di auto-valutazione: strumenti strutturati per l’analisi delle proprie caratteristiche personali
- Visite a scuole secondarie di secondo grado: momenti di contatto diretto con le possibili scelte future
- Testimonianze di professionisti: incontri con figure rappresentative di diversi settori lavorativi
- Progetti ponte: attività congiunte con istituti superiori che permettano di sperimentare ambienti e metodologie diverse
- Colloqui individuali: momenti di riflessione guidata con supporto di docenti o esperti di orientamento
2.3 Il ruolo della famiglia nel processo di orientamento
La famiglia rappresenta un attore fondamentale nel processo di orientamento. La scuola dovrebbe prevedere specifiche azioni di coinvolgimento dei genitori:
- Incontri informativi sulle opportunità formative del territorio
- Momenti di riflessione condivisa sulle modalità più adeguate per sostenere le scelte dei figli
- Supporto alla gestione delle dinamiche familiari legate alle aspettative genitoriali
- Costruzione di alleanze educative che valorizzino il ruolo complementare di scuola e famiglia
3. Integrazione tra lettura e orientamento: proposte operative
3.1 La narrazione come strumento di orientamento
Le potenzialità orientative della narrazione sono state ampiamente riconosciute dalla ricerca psicopedagogica (Bruner, 2002; Demetrio, 1996). Il racconto, sia fruito che prodotto, permette di:
- Esplorare molteplici possibilità esistenziali attraverso l’identificazione con i personaggi
- Costruire una narrazione coerente della propria identità in evoluzione
- Proiettarsi in scenari futuri, attivando processi di anticipazione e progettualità
- Confrontarsi con modelli diversificati di affrontare situazioni problematiche
3.2 Percorsi didattici integrati
La sinergia tra educazione alla lettura e attività di orientamento può concretizzarsi in progetti didattici specifici:
Progetto “Biografie e professioni”
- Lettura di biografie e autobiografie di figure significative in diversi ambiti professionali
- Analisi dei percorsi di vita, con attenzione agli elementi di scelta, agli ostacoli incontrati e alle strategie di superamento
- Produzione di interviste immaginarie o riscritture creative a partire dai testi letti
Percorso “Leggere il futuro”
- Selezione di romanzi di anticipazione o fantascientifici che presentino scenari professionali innovativi
- Discussione sulle trasformazioni del mondo del lavoro e sulle competenze richieste nel futuro
- Elaborazione di scenari personali proiettati nel futuro
Laboratorio “Storie di scelta”
- Analisi di romanzi di formazione centrati su momenti decisionali
- Riscrittura di finali alternativi, esplorando le conseguenze di scelte diverse
- Creazione di racconti autobiografici centrati su momenti di scelta personale
3.3 Strumenti di documentazione e valutazione
Il percorso integrato di lettura e orientamento dovrebbe prevedere specifici strumenti di documentazione che consentano di valorizzare il processo di crescita dello studente:
- Portfolio delle letture: raccolta ragionata delle esperienze di lettura, con riflessioni personali sul significato di ciascuna opera per il proprio percorso
- Diario di orientamento: documentazione progressiva delle attività orientative, con annotazioni su scoperte, dubbi, progressi nella conoscenza di sé e del contesto
- Mappa delle competenze: strumento di auto-valutazione che evidenzi l’evoluzione delle competenze trasversali acquisite attraverso le diverse esperienze
4. Il ruolo dell’insegnante come mediatore e facilitatore
4.1 Competenze professionali necessarie
L’efficacia di un percorso integrato di lettura e orientamento richiede che l’insegnante sviluppi specifiche competenze:
- Conoscenza approfondita della letteratura per ragazzi, sia classica che contemporanea
- Capacità di mediazione dei testi, facilitando l’incontro tra opere e lettori
- Competenze di ascolto attivo e coaching orientativo
- Abilità di progettazione di percorsi personalizzati che tengano conto delle specificità individuali
- Competenze di lavoro in rete con altri professionisti (psicologi, orientatori, esperti del mondo del lavoro)
4.2 La formazione dei docenti
Per sostenere lo sviluppo di tali competenze, risultano fondamentali percorsi formativi specifici:
- Aggiornamento continuo sulla produzione editoriale per ragazzi
- Formazione sulle metodologie attive di promozione della lettura
- Acquisizione di strumenti di supporto all’orientamento formativo
- Sviluppo di competenze di progettazione didattica interdisciplinare
Conclusioni
La lettura e l’orientamento rappresentano ambiti formativi complementari che, se adeguatamente integrati, possono offrire agli studenti della scuola media opportunità significative di crescita personale e sociale. Attraverso pratiche didattiche innovative che valorizzino le potenzialità orientative della narrazione e le dimensioni riflessive della lettura, è possibile accompagnare i preadolescenti in un percorso di progressiva conquista di autonomia e consapevolezza.
L’ampliamento degli orizzonti culturali ed esistenziali che deriva da tali esperienze costituisce un patrimonio fondamentale non solo per affrontare la scelta della scuola superiore, ma più in generale per sviluppare quelle competenze di vita che consentiranno loro di affrontare con maggiore consapevolezza le sfide della contemporaneità.
Bibliografia essenziale
Bruner, J. (1986). La mente a più dimensioni. Roma-Bari: Laterza.
Bruner, J. (2002). La fabbrica delle storie. Roma-Bari: Laterza.
Chambers, A. (2011). Il lettore infinito. Modena: Equilibri.
Demetrio, D. (1996). Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé. Milano: Raffaello Cortina.
Erikson, E. H. (1968). Gioventù e crisi d’identità. Roma: Armando.
Mantovani, S. (a cura di) (1998). La ricerca sul campo in educazione. I metodi qualitativi. Milano: Bruno Mondadori.
Pombeni, M. L. (1996). Orientamento scolastico e professionale. Bologna: Il Mulino.
Rossi, P. G. (2011). Didattica enattiva. Complessità, teorie dell’azione, professionalità docente. Milano: FrancoAngeli.
Trisciuzzi, L., & Zappaterra, T. (2011). La dislessia. Una didattica speciale per le difficoltà nella lettura. Milano: Guerini Scientifica.
Audio Lezioni sulla Pedagogia e organizzazione della scuola del prof. Gaudio
Ascolta “Pedagogia e organizzazione della scuola” su Spreaker.




