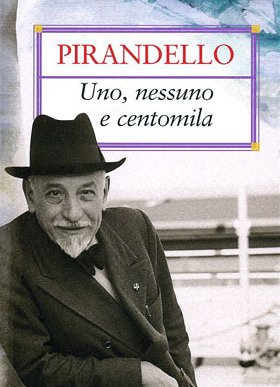
Uno nessuno e centomila di Luigi Pirandello agli estremi del relativismo
28 Dicembre 2019
Canto diciassettesimo del Paradiso
28 Dicembre 2019I romanzi di Luigi Pirandello rappresentano una tappa fondamentale della letteratura italiana del Novecento e riflettono il pensiero filosofico e psicologico dell’autore, incentrato sulla crisi dell’identità, la relatività della verità e la frammentazione dell’io.
Pirandello esplora con acume le contraddizioni della condizione umana, rivelando l’inevitabile conflitto tra la maschera sociale che ogni individuo è costretto a indossare e la realtà soggettiva che ciascuno vive interiormente. Nei suoi romanzi, Pirandello sviluppa una visione del mondo in cui la verità non è univoca e stabile, ma mutevole, e l’identità individuale è frammentata in molteplici versioni di sé.
Caratteristiche principali dei romanzi pirandelliani
- La crisi dell’identità: Nei romanzi pirandelliani, i protagonisti vivono una crisi profonda legata alla loro identità. Il senso di sé è sempre in bilico tra ciò che gli altri vedono e ciò che loro stessi percepiscono. Questo tema emerge in modo evidente ne “Il fu Mattia Pascal” e in “Uno, nessuno e centomila”, dove i protagonisti lottano con l’idea che la loro identità sia molteplice e frammentata.
- La maschera e l’apparenza: Pirandello riflette sulla dicotomia tra maschera e volto, ovvero tra ciò che una persona è interiormente e ciò che appare agli altri. Gli individui si trovano costretti a vivere sotto le maschere sociali che impongono un’identità fissa, mentre la loro vera essenza è fluida e in continuo cambiamento.
- La relatività della verità: In tutti i suoi romanzi, Pirandello sfida l’idea di una verità assoluta, mostrando come la realtà sia un costrutto soggettivo. Ogni individuo vive in una propria versione della realtà, incapace di comprendere appieno quella degli altri. Questo tema è particolarmente evidente in “Uno, nessuno e centomila”, dove la percezione frammentata di sé porta il protagonista a dubitare della possibilità di una verità unica.
- La follia come lucidità: Nei romanzi di Pirandello, spesso i personaggi che appaiono folli agli occhi della società sono quelli che, paradossalmente, raggiungono una maggiore consapevolezza. La loro “follia” è, in realtà, un rifiuto delle convenzioni sociali e una ribellione contro la fissità delle identità imposte.
“Uno, nessuno e centomila”: il romanzo dell’identità frammentata
“Uno, nessuno e centomila” (1926) è l’ultimo romanzo di Luigi Pirandello e rappresenta la sintesi più completa delle sue riflessioni sull’identità e sulla natura della realtà. Il protagonista del romanzo, Vitangelo Moscarda, vive una crisi di identità quando un commento casuale della moglie gli fa notare che il suo naso pende leggermente. Questo piccolo evento scatena in lui una riflessione devastante: si rende conto che l’immagine che lui ha di se stesso non coincide con quella che gli altri hanno di lui.
Trama
Vitangelo, ossessionato dall’idea che le persone lo percepiscano in modo diverso da come lui crede di essere, comincia a riflettere su quanto la sua identità sia frammentata: per ogni persona che lo conosce, egli è “uno”, ma in realtà, visto da ognuno in modo diverso, è anche “centomila”. Di conseguenza, per Vitangelo non è nessuno, poiché non può controllare l’immagine che gli altri hanno di lui. Questo lo porta a una crisi esistenziale sempre più profonda, fino al desiderio di annullare qualsiasi aspetto della sua vita che possa vincolarlo a un’identità definita.
Moscarda intraprende una serie di azioni apparentemente bizzarre per liberarsi delle sue identità sociali: abbandona il suo patrimonio, scioglie i rapporti con la moglie e gli amici, e arriva a un progressivo isolamento dalla società. L’idea centrale del romanzo è che l’identità è solo una costruzione imposta dagli altri, una maschera che cambia a seconda del contesto sociale e delle persone con cui ci si confronta. Vitangelo cerca di liberarsi da tutte queste maschere, ma il risultato è che, una volta svincolato dalle identità che gli altri gli attribuiscono, non rimane nulla di lui.
Il finale di “Uno, nessuno e centomila”
Il romanzo si conclude con la sconfitta di Vitangelo Moscarda: l’unico modo per liberarsi dalle maschere imposte dalla società è annullarsi completamente. Vitangelo finisce per vivere in uno stato di isolamento e annullamento totale della propria persona. Si trasferisce in un ospizio e rinuncia a qualsiasi legame con il passato o con il mondo esterno. Nel finale del romanzo, Vitangelo accetta la propria condizione di “nessuno”, raggiungendo una sorta di serenità nella perdita totale della sua identità.
Le ultime parole del romanzo riassumono questo sentimento di nullificazione:
“Vivo, dunque, fuori di me, ignaro di me stesso, alla mercé di ciò che mi accade, non più in me, ma fuori.”
Questa riflessione finale conferma la visione di Pirandello sull’identità: non esiste un sé autentico, ma solo una continua fluttuazione di maschere e percezioni mutevoli. L’annullamento di Vitangelo Moscarda è la conclusione logica della sua ricerca: la liberazione dalla tirannia delle identità imposte si traduce in una sorta di esistenza liquida, priva di certezze e di punti di riferimento.
Conclusione
I romanzi pirandelliani, e “Uno, nessuno e centomila” in particolare, esplorano la fragilità dell’identità e la difficoltà dell’uomo moderno di conciliare l’immagine di sé con quella che gli altri gli attribuiscono. Vitangelo Moscarda è un personaggio che rappresenta la crisi dell’individuo nel contesto della modernità, dove l’io è frammentato e impossibile da afferrare nella sua totalità.
La grandezza di Pirandello sta nella sua capacità di trattare temi esistenziali profondi con una narrativa che mescola il tragico e il comico, in cui la follia diventa uno strumento di consapevolezza e l’identità stessa si rivela un gioco di specchi, dove “uno”, “nessuno” e “centomila” sono facce della stessa medaglia.




