
I puffini dell’ Adriatico di Giovanni Pascoli
28 Dicembre 2019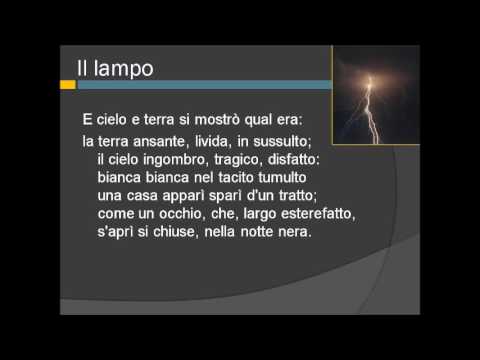
Temporale e Lampo di Giovanni Pascoli
28 Dicembre 2019Il metodo sperimentale galileiano segna l’inizio della scienza moderna.
Galileo Galilei (1564-1642), l’insigne fisico, matematico e filosofo italiano, rivoluzionò il modo in cui l’uomo si rapportava alla natura e al mondo fisico. Il suo metodo, basato sull’osservazione e sull’esperimento, fu una rottura rispetto alla tradizione aristotelica e scolastica, che prediligeva la pura speculazione filosofica.
Contesto storico
Prima di Galileo, la scienza si basava principalmente su due pilastri:
- Il principio di autorità: Aristotele e Tolomeo erano le fonti incontestabili di sapere. La verità veniva stabilita non attraverso l’osservazione diretta, ma accettando l’autorità dei classici.
- La filosofia scolastica: Nel Medioevo e fino al Rinascimento, la scienza era legata alla teologia e a un sistema di pensiero deduttivo, dove le conclusioni venivano tratte partendo da premesse generali.
Galileo ribaltò questi paradigmi introducendo una nuova forma di conoscenza basata sull’osservazione empirica, l’esperimento e l’uso della matematica per descrivere i fenomeni naturali.
Il metodo galileiano: struttura e passaggi fondamentali
Il metodo galileiano può essere riassunto nei seguenti passaggi chiave:
- Osservazione: Il primo passo è l’osservazione di un fenomeno naturale. Galileo insisteva sull’importanza di guardare la realtà con occhi nuovi, liberi da pregiudizi e dal principio di autorità. Un esempio celebre è l’osservazione del moto dei corpi in caduta libera.
- Ipotesi: Dopo l’osservazione, si formulava un’ipotesi o una congettura. Questa doveva essere una spiegazione provvisoria del fenomeno osservato. Galileo, influenzato dal pensiero di Copernico, formulò l’ipotesi eliocentrica (che poneva il Sole al centro dell’universo), in contrasto con la visione tolemaica.
- Sperimentazione: La grande innovazione di Galileo fu l’introduzione dell’esperimento controllato per verificare l’ipotesi. Galileo testava direttamente le sue idee, come nel caso del famoso esperimento del piano inclinato, dove studiò il moto accelerato dei corpi. Qui si vede la differenza con il metodo puramente deduttivo di Aristotele, che non includeva la verifica sperimentale.
- Matematizzazione: Un altro elemento essenziale del metodo galileiano è l’applicazione della matematica alla descrizione dei fenomeni naturali. Galileo affermava che “il libro della natura è scritto in caratteri matematici”. Per esempio, nei suoi studi sul moto, introdusse la relazione matematica tra tempo e velocità nei corpi in caduta libera (v = gt), anticipando la formulazione delle leggi di Newton.
- Conferma o confutazione dell’ipotesi: A questo punto, si confrontano i risultati dell’esperimento con l’ipotesi iniziale. Se i dati sperimentali confermano l’ipotesi, questa può essere accettata provvisoriamente come valida, ma sempre aperta a future revisioni o confutazioni.
- Ripetibilità: Un elemento cruciale del metodo sperimentale è la ripetibilità dell’esperimento. I risultati devono poter essere riprodotti da altri scienziati, il che garantisce l’oggettività e l’universalità delle scoperte.
Galileo e la rottura con Aristotele
Uno degli aspetti più rivoluzionari del metodo galileiano fu la sua opposizione alle teorie fisiche aristoteliche. Aristotele aveva postulato che i corpi più pesanti cadessero più velocemente di quelli leggeri. Galileo, attraverso i suoi esperimenti (come il celebre esperimento — probabilmente mai realmente eseguito — della caduta dei corpi dalla Torre di Pisa), dimostrò che tutti i corpi, in assenza di resistenza dell’aria, cadono con la stessa accelerazione.
Questa scoperta aprì la strada alla legge di inerzia, una delle basi della futura meccanica classica, elaborata successivamente da Newton.
Esempio di applicazione: il moto parabolico
Un altro esempio del metodo sperimentale galileiano fu lo studio del moto parabolico dei proiettili. Aristotele aveva separato il moto in due categorie: moto rettilineo e moto curvilineo, senza alcuna interazione tra di loro. Galileo, invece, dimostrò che il moto di un proiettile può essere scomposto in due movimenti indipendenti: uno orizzontale e uno verticale, che insieme producono una traiettoria parabolica.
L’importanza della matematica
Un altro aspetto fondamentale del metodo di Galileo fu l’uso sistematico della matematica per descrivere i fenomeni naturali. Galileo insisteva che i fenomeni fisici non potevano essere descritti in modo adeguato solo con parole o concetti qualitativi, ma dovevano essere espressi con precisione tramite equazioni matematiche.
Fortuna e influenza del metodo galileiano
Il metodo sperimentale di Galileo ebbe una fortuna immensa e trasformò radicalmente il modo di fare scienza. La sua influenza si estese a scienziati come Isaac Newton, che sviluppò ulteriormente le intuizioni galileiane sulla meccanica classica, formulando le leggi del moto e la legge della gravitazione universale. Newton, infatti, affermò di aver “visto più lontano perché era salito sulle spalle dei giganti”, con chiaro riferimento a Galileo.
Anche la Rivoluzione scientifica del XVII secolo è in larga parte figlia del metodo galileiano. Scienziati come Keplero, Cartesio e Huygens applicarono i principi della sperimentazione e della matematica alla ricerca scientifica. Successivamente, il metodo galileiano divenne il modello standard per il progresso della scienza, ispirando persino il metodo scientifico moderno basato su osservazione, ipotesi, esperimento e verifica.
Conclusione
Il metodo sperimentale galileiano rappresenta una pietra miliare nella storia della scienza. Con la sua enfasi sull’osservazione empirica, la verifica sperimentale e la matematizzazione dei fenomeni naturali, Galileo ruppe con la tradizione filosofica speculativa e fondò una nuova era del sapere, ponendo le basi per la scienza moderna.




