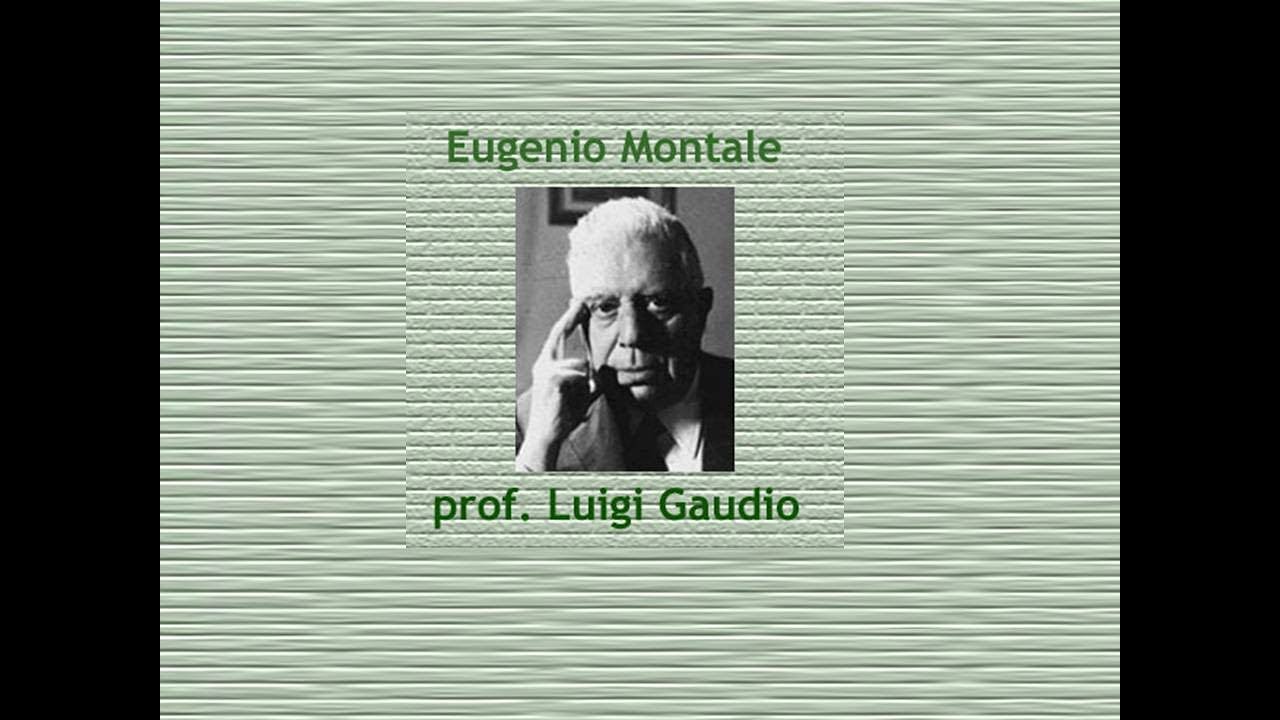Analisi del brano “Bombardamento su Roma” tratto da La storia di Elsa Morante , con traccia di un compito per una classe quinta superiore e svolgimento
Traccia Tipologia A – Elsa Morante, “Bombardamento su Roma” tratto da La storia
Esempi da Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168).
La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall’esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo “scandalo della guerra”.
Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”[1]. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti.
“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo[2] […].
Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo.
Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume[3]. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare:
“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo.
I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto[4] a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile.
Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta[5] che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte[6], fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò[7], intatto, il casamento[8] con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare:
“Bii! Biii! Biiii!” [9]
Il loro caseggiato era distrutto […]
Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare:
“Bii! Biii! Biiii!”
NOTE:
[1] Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino.
[2] in collo: in braccio.
[3] incolume: non ferito.
[4] accosto: accanto.
[5] pulverulenta: piena di polvere.
[6] divelte: strappate via.
[7] ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere.
[8] il casamento: il palazzo, il caseggiato.
[9] Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.
Comprensione e analisi
- L’episodio rappresenta l’incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi.
- «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione sonora? Quale effetto produce?
- Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo innocente del bambino?
- Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato simbolico.
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.
Interpretazione
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
Svolgimento della Analisi del brano “Bombardamento su Roma” tratto da La storia di Elsa Morante
Elsa Morante, La Storia , 1974
1. Sintesi dell’episodio e descrizione dell’ambiente e delle reazioni dei personaggi
L’episodio racconta l’esperienza drammatica di Ida e del figlio Useppe durante un bombardamento aereo su Roma avvenuto il 19 luglio 1943. La coppia sta tornando a casa dopo aver fatto la spesa quando improvvisamente inizia l’attacco nemico. Il rumore assordante degli aeretti (“lioplani”) annuncia l’imminente distruzione, che si abbatte su di loro con una violenza devastante. Ida, terrorizzata, cerca di proteggere Useppe e lo stringe a sé, mentre intorno a loro si scatena il caos.
Morante rappresenta con estrema intensità il contrasto tra la quotidianità della vita (la spesa, i colori vivaci dei peperoni caduti dalla sporta) e l’orrore improvviso e indiscriminato della guerra. L’ambiente è descritto come sconvolto, polveroso e fumante, con edifici distrutti, mobili inutilizzabili e strade ridotte a cumuli di macerie. Le persone appaiono smarrite, urlanti o ammutolite, alcune cercano disperatamente qualcosa da salvare in mezzo alle rovine.
Le reazioni dei due protagonisti sono opposte: Ida vive l’evento con angoscia e terrore, preoccupata per la sorte del figlio; Useppe, invece, non sembra rendersi conto della gravità del momento e osserva tutto con uno sguardo quasi curioso e innocente. Alla fine, il loro caseggiato è distrutto e Useppe chiama ripetutamente “Bii!”, cercando il cane Belsito, probabilmente morto sotto le macerie.
2. Analisi della descrizione sonora: «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»
Questa immagine sensoriale introduce l’incursione aerea con una metafora originale e poetica: il rumore degli aerei viene paragonato a un “clamore d’orchestra”, evocando un suono potente, ritmico, continuo eppure armonico, nonostante la sua natura minacciosa. L’uso di termini come “metallico” e “ronzante” richiama l’aspetto meccanico e freddo della guerra, che si abbatta senza pietà sulla realtà quotidiana.
Questo tipo di descrizione produce un effetto di sospensione emotiva : il lettore percepisce l’avvicinarsi del pericolo in modo progressivo, ma al tempo stesso ne coglie la stranezza, come se fosse qualcosa di irreale. Inoltre, il tono ironico e surreale con cui vengono descritti i segnali della guerra riflette il punto di vista infantile e in parte estraniato del piccolo Useppe.
3. Lo sguardo innocente del bambino
Useppe, pur essendo coinvolto in un evento tragico, mantiene un atteggiamento di stupore e serenità. Alcuni particolari che evidenziano il suo sguardo infantile e incomprensivo sono:
- Il soprannome “lioplani” : Useppe chiama gli aerei con un termine inventato, che sembra quasi giocoso.
- “Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo : il bambino, anche di fronte ai rumori più forti, esprime fiducia nelle parole della madre e sembra non percepire realmente il pericolo.
- La pallina stretta nel pugno : nonostante il caos, Useppe non lascia mai il suo giocattolo, simbolo di normalità e innocenza.
- I piedini nudi tranquilli : mentre Ida trema e si agita, Useppe rimane calmo, incuriosito dagli eventi ma non spaventato.
- Lo sguardo fisso negli occhi della madre : i due si fissano in silenzio, in un momento di comunione affettiva che sembra isolare il bambino dall’orrore circostante.
Tutto questo rivela come Morante utilizzi lo sguardo infantile per contrastare la follia della guerra , rendendola ancora più crudele e assurda agli occhi del lettore.
4. Oggetti simbolici e significati allegorici
Nel brano emergono alcuni oggetti apparentemente banali che acquistano valore simbolico e memoriale:
- Le sporte con la spesa : rappresentano la vita normale e quotidiana, interrotta violentemente dalla guerra. I colori dei peperoni – verde, rosso e arancione – risaltano nella polvere e diventano quasi una nota di bellezza in mezzo alla distruzione.
- La pallina di Useppe : simboleggia la semplicità e l’innocenza del bambino, che non abbandona mai il proprio mondo, nemmeno di fronte al pericolo.
- La sporta vuota usata come elmetto : gesto materno che rivela amorevolezza e impotenza. La sporta, oggetto domestico, diventa improvvisamente strumento di protezione, ribaltando i ruoli tradizionali.
- Il cane Belsito : la chiamata ripetuta di Useppe (“Bii! Biii! Biiii!”) è l’espressione di un dolore sincero e disarmato, ma anche di un legame affettivo puro, destinato a scontrarsi con la crudeltà della realtà.
Questi oggetti assumono un valore viscerale e memorabile: sono frammenti di umanità in mezzo all’orrore, istantanee che restano impresse nell’animo del lettore.
Interpretazione complessiva e approfondimento critico
Il romanzo La Storia di Elsa Morante mette in scena il rapporto tra individuo e grandi eventi storici, un tema caro alla narrativa italiana del Novecento. Rispetto a opere come I promessi sposi di Manzoni o Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, dove la Storia è raccontata attraverso figure centrali e decisive, qui essa appare cieca e indifferente , e colpisce persone comuni, insignificanti, che non hanno voce né potere.
La scelta dello sguardo di un bambino come Useppe permette a Morante di mostrare la guerra con una prospettiva non ideologica, ma emotiva e immediata . L’ingenuità e l’inconsapevolezza del piccolo accentuano il senso di tragedia, poiché il lettore, vedendo l’orrore attraverso gli occhi innocenti di un bambino, ne percepisce tutta l’assurdità e la violenza gratuita.
Un confronto possibile può essere fatto con:
- Renata, in Mio fratello è figlio unico di Antonio Tabucchi , che racconta la guerra dal punto di vista di una bambina.
- Bruno in La vita è bella di Roberto Benigni , che interpreta la Shoah come un gioco, mantenendo un candore che accentua il dolore dell’adulto spettatore.
- Hans Castorp in La montagna incantata di Thomas Mann , che assiste alla guerra con distacco e stupore, quasi a voler capire il senso di tanta distruzione.
In tutti questi casi, l’utilizzo dello sguardo “altri” — sia esso infantile, ingenuo o idealista — serve a interrogare la razionalità della guerra , facendo emergere la sua irragionevolezza e la sua totale insensatezza.
Anche il cinema ha adottato questa tecnica: basti pensare a film come Il giovane Holden o La strada di Fellini, dove la purezza e l’ingenuità dei protagonisti contrastano con la corruzione e la violenza del mondo adulto.
Conclusione
Elsa Morante, in questo brano tratto da La Storia , utilizza il punto di vista di Useppe per raccontare una guerra che non guarda in faccia nessuno, colpendo indistintamente i fragili e gli innocenti. Attraverso l’uso di oggetti simbolici, come la pallina del bambino o i colori dei peperoni, l’autrice costruisce una narrazione densa di emozioni e di significati profondi.
La Storia, nella sua dimensione epica e tragica, si scontra con la microstoria di una donna e di un bambino che tentano di sopravvivere in un contesto ostile. Il contrasto tra il linguaggio infantile e l’enormità degli eventi crea una tensione emotiva fortissima, che fa di Useppe una voce universale, simbolo di tutti quegli innocenti che la guerra ha schiacciato senza pietà.
Audio Lezioni sulla Letteratura del novecento del prof. Gaudio
Ascolta “Letteratura del novecento” su Spreaker.