
Interconnessioni nella comunità scientifica per il professor Carlo Rubbia
1 Giugno 2025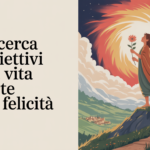
La ricerca di obiettivi nella vita è l’arte della felicità
2 Giugno 2025Traccia svolta di un tema argomentativo su La prima guerra mondiale o “Grande guerra”

TRACCIA
Esempio di traccia di prova scritta del Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Paolo Rumiz[1], L’eredità del 4 novembre. Cosa resta all’Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 Novembre 2018
Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918.
Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. […]
Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell’esercito entra nella città “cara al cuore” in preda all’anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. […] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell’Unità, dedicata alle diverse genti dell’impero multilingue, diventa piazza dell’Unità d’Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L’idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente “plurale”, con tutte le conseguenze che si vedranno.
Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent’anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l’equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? […]
Per decenni, la “diversità” triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L’Italia aveva incamerato terre che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli “alloglotti”[2] l’appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l’Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.
Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro identità. […] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile un’italianità che non fosse al mille per mille. […]
Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l’oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 […].
Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino all’altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa “sbagliata”, quelli che hanno perso la guerra.
Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di medaglia d’oro sul fronte orientale. Quando l’Austria sconfitta consegnò all’Italia la lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all’oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe.
Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche mese fa in Trentino, per l’adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati austroungarici. L’appartenenza all’Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a “rieducarsi” nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall’Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti.
Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell’amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell’indifferenza, soprattutto dei più giovani.
Le fanfare non bastano più. […] La guerra non è un evento sepolto per sempre.
Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e l’Europa torna a vacillare. […].
Paolo Rumiz[1], L’eredità del 4 novembre. Cosa resta all’Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 Novembre 2018
Comprensione e analisi
- Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma?
- In che cosa consisteva la «”diversità” triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel dopoguerra?
- Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima Guerra mondiale?
- Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Mondiale oggi, un secolo dopo la sua conclusione?
- Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione dell’articolo?
Produzione
Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell’amnesia»?
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
[1] P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della Venezia Giulia.
[2] “alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione.

SVOLGIMENTO
L’eredità del 4 novembre
Analisi dell’articolo di Paolo Rumiz e riflessioni sulla memoria della Grande Guerra
COMPRENSIONE E ANALISI
1. Il significato del cambiamento toponomastico di Trieste
Il mutamento del nome della principale piazza di Trieste da “Piazza dell’Unità” (dedicata alle diverse genti dell’impero multilingue) a “Piazza dell’Unità d’Italia” rappresenta simbolicamente la trasformazione di una città multietnica in simbolo del nazionalismo italiano. Questo cambiamento sintetizza il passaggio da un modello imperiale austro-ungarico, che riconosceva la pluralità etnica, a uno stato-nazione italiano che imponeva l’omogeneità culturale.
Rumiz conferma questa interpretazione attraverso diversi riferimenti storici: l’italianizzazione forzata dei cognomi di “centinaia di migliaia di famiglie”, il divieto delle lingue tedesca e slovena durante il fascismo, e l’imposizione dell’appartenenza nazionale ai popoli “alloglotti” per giustificare il possesso di territori etnicamente non italiani come il Sudtirolo e il Tarvisiano.
2. La diversità triestina e la sua gestione post-bellica
La “diversità triestina” consisteva nella presenza di numerose comunità etniche: Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, Serbi, che convivevano in un mosaico multiculturale tipico dell’impero austro-ungarico. Questa diversità venne affrontata nel dopoguerra attraverso politiche di assimilazione forzata e negazione dell’alterità.
Roma riconobbe questa diversità “solo a denti stretti”, poiché l’Italia aveva “incamerato terre che in certi casi italiane non erano affatto”. La strategia adottata fu quella dell’omologazione: imposizione della lingua italiana, cambiamento forzato dei cognomi, italianizzazione dei toponimi e, durante il fascismo, persecuzione delle minoranze linguistiche.
3. Le cause e conseguenze delle “memorie divise”
Le “memorie divise” nascono dall’intreccio complesso di eventi traumatici che hanno caratterizzato Trieste nel Novecento: oppressione degli Sloveni, Leggi Razziali del 1938, guerra alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, e il governo militare alleato dal 1945 al 1954.
Le conseguenze di queste memorie frammentate sono evidenti ancora oggi: “in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro identità”. La rimozione sistematica di alcune verità storiche ha creato un vuoto identitario e ha impedito una riconciliazione autentica con il passato.
4. L’importanza dell’interrogarsi oggi sulla Prima Guerra Mondiale
Secondo Rumiz, è fondamentale riflettere sulla Grande Guerra oggi perché “la guerra non è un evento sepolto per sempre”. In un momento in cui “scricchiola di nuovo l’equilibrio continentale” e riemergono “reticolati, muri, xenofobia e discordia”, la memoria storica diventa uno strumento di prevenzione.
L’autore sottolinea il rischio dello “sprofondamento nell’amnesia” in un’epoca dove “la memoria si riduce a un tweet” e “la geopolitica a una playstation”, specialmente tra i giovani che potrebbero rimanere indifferenti alle lezioni del passato.
5. Il significato dell’ammonimento “Le fanfare non bastano più”
Questa espressione critica la ritualità vuota delle celebrazioni ufficiali che rischiano di passare “nel torpore, se non nell’indifferenza”. Rumiz sostiene che le commemorazioni formali (alzabandiera, sfilate di Bersaglieri) sono insufficienti se non accompagnate da una riflessione critica autentica sulla storia.
L’ammonimento invita a superare la retorica celebrativa per affrontare le “verità scomode” e dare alla guerra “un significato europeo capace di affratellarci” piuttosto che di dividerci.
PRODUZIONE
Il valore della Grande Guerra nella storia italiana ed europea
La Prima Guerra Mondiale rappresenta uno spartiacque fondamentale nella storia europea, segnando la fine degli imperi multinazionali e la nascita del sistema degli stati-nazione. Per l’Italia, il conflitto ha completato formalmente l’unificazione territoriale, ma ha anche aperto contraddizioni profonde che persistono ancora oggi.
Il valore che ritengo debba essere riconosciuto a questo conflitto è duplice: da un lato, esso ha rappresentato una tragedia umana di proporzioni inaudite che ha insegnato all’Europa il costo terribile del nazionalismo esasperato; dall’altro, ha posto le basi per la costruzione di una coscienza sovranazionale che avrebbe portato, dopo la Seconda Guerra Mondiale, al progetto di integrazione europea.
La Grande Guerra non può essere celebrata come una semplice vittoria nazionale, ma deve essere compresa come un monito contro i pericoli del nazionalismo esclusivo. L’esperienza di Trieste, magistralmente descritta da Rumiz, dimostra come l’imposizione di un’identità nazionale omogenea su territori multietnici abbia generato traumi profondi e memorie divise che perdurano per generazioni.
Le conseguenze della rimozione storica
La rimozione delle ferite non rimarginate, come quelle evidenziate nell’articolo sulla Venezia Giulia, produce conseguenze devastanti per la costruzione di un’identità nazionale matura e per la coesione sociale. Quando una nazione rifiuta di confrontarsi con gli aspetti più oscuri del proprio passato, crea zone d’ombra che impediscono una riconciliazione autentica.
Il caso dei soldati austriaci di origine italiana, la cui memoria è stata cancellata per decenni, rappresenta un esempio paradigmatico di come la rimozione storica produca “morti di seconda classe” e impedisca l’elaborazione del lutto collettivo. Questa amnesia selettiva non solo è ingiusta verso le vittime dimenticate, ma priva la società della possibilità di comprendere la complessità della storia e di imparare dalle proprie contraddizioni.
Le conseguenze si manifestano in diverse forme: identità fragili e conflittuali nelle zone di confine, difficoltà nei rapporti con i paesi vicini, persistenza di stereotipi e pregiudizi, e soprattutto l’incapacità di sviluppare anticorpi culturali contro il ritorno di ideologie aggressive e xenofobe.
Il rischio dell’amnesia contemporanea
Condivido pienamente il timore di Paolo Rumiz riguardo al rischio di uno “sprofondamento nell’amnesia” nella società contemporanea. Viviamo in un’epoca caratterizzata dalla velocità dell’informazione e dalla frammentazione della memoria, dove il passato rischia di essere ridotto a slogan superficiali o, peggio ancora, di essere completamente dimenticato.
Questo fenomeno è particolarmente preoccupante tra le giovani generazioni, che spesso percepiscono la storia come qualcosa di remoto e irrilevante per la loro esperienza quotidiana. La digitalizzazione, pur offrendo nuove opportunità di accesso alle informazioni, ha anche contribuito alla perdita di profondità nella comprensione storica, sostituendo la riflessione critica con la fruizione rapida e superficiale.
L’amnesia storica diventa particolarmente pericolosa quando coincide con momenti di crisi economica e sociale, che favoriscono il ritorno di retoriche populiste e nazionaliste. Come osserva Rumiz, “nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura”, riemergono “la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia”.
Memoria critica come antidoto
La soluzione non può essere trovata nel ritorno a una memoria celebrativa e acritica, ma nella costruzione di una memoria critica e inclusiva. Questo significa riconoscere senza paura le “verità scomode”, come ha fatto il Presidente Mattarella portando fiori al monumento dei soldati austroungarici.
Una memoria critica deve essere capace di:
- Riconoscere la sofferenza di tutte le vittime, indipendentemente dalla loro appartenenza nazionale
- Analizzare le cause profonde dei conflitti per prevenirne il ripetersi
- Valorizzare la diversità culturale come ricchezza piuttosto che come minaccia
- Promuovere una visione europea e sovranazionale della storia
Verso una memoria europea condivisa
L’eredità più preziosa che possiamo trarre dalla riflessione sulla Grande Guerra è la comprensione che la pace e la prosperità europee dipendono dalla nostra capacità di superare i nazionalismi esclusivi per costruire una memoria condivisa. Questo non significa cancellare le specificità nazionali, ma inscriverle in una narrazione più ampia che riconosca l’interdipendenza dei destini europei.
Il progetto europeo nato dalle ceneri delle due guerre mondiali rappresenta la più grande realizzazione politica di questa consapevolezza. Tuttavia, questo progetto è fragile e richiede un costante rinnovamento del consenso democratico, che può essere garantito solo da una cittadinanza consapevole della propria storia.
In conclusione, l’eredità del 4 novembre non può essere ridotta a una celebrazione nazionale, ma deve diventare occasione per riflettere sui pericoli del nazionalismo e sulla necessità di costruire una memoria europea inclusiva. Solo così potremo onorare veramente il sacrificio di tutti coloro che hanno pagato con la vita le follie del Novecento e contribuire a costruire un futuro di pace per le prossime generazioni.









