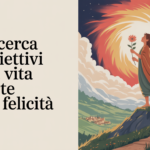
La ricerca di obiettivi nella vita è l’arte della felicità
2 Giugno 2025
La fragilità
2 Giugno 2025Traccia svolta di un tema di attualità sul Rapporto tra viaggio e racconto del viaggio

TRACCIA
Esempio di traccia di prova scritta del Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […]
Tim Parks, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del
Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta.
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità.
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

SVOLGIMENTO
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’
Viaggi immobili e avventure di carta
Riflessioni sul rapporto tra racconto e viaggio nell’era digitale
L’analogia tra pagine e binari
Tim Parks coglie una corrispondenza profonda tra l’esperienza della lettura e quella del viaggio, identificando in entrambe la capacità di trasportarci oltre i confini della quotidianità. Questa analogia, che affonda le radici nella storia stessa della letteratura – dal viaggio di Ulisse alle peregrinazioni di Don Chisciotte – mantiene una straordinaria attualità anche nell’era contemporanea, pur assumendo forme e significati nuovi.
L’idea che libri e mezzi di trasporto condividano una “profonda affinità” è particolarmente suggestiva: entrambi sono strumenti di movimento, fisico nel caso dei trasporti, mentale ed emotivo nel caso della lettura. Come un treno ci porta da una stazione all’altra attraversando paesaggi diversi, così un libro ci conduce da una pagina all’altra attraversando stati d’animo, riflessioni, mondi immaginari. La similitudine acquisisce ancora più forza se pensiamo che spesso questi due tipi di viaggio si intrecciano: quante volte abbiamo letto in macchina, in aereo, su un autobus, trasformando il tempo di spostamento in tempo di scoperta interiore?
L’avventura senza rischio: un privilegio o un limite?
La riflessione di Parks sulla “avventura circoscritta” che offrono sia il viaggio che la lettura tocca un punto cruciale della condizione contemporanea. Entrambe le esperienze ci permettono di “sorvolare il deserto” senza “farne esperienza diretta”, di vivere emozioni intense rimanendo al sicuro. Questa caratteristica può essere vista come un privilegio straordinario: possiamo esplorare le profondità dell’animo umano attraverso i personaggi di Dostoevskij senza dover sopportare il peso reale della colpa e della redenzione; possiamo visitare Paesi lontani senza affrontare i disagi del jet-lag o i rischi sanitari.
Tuttavia, questa “sicurezza” dell’esperienza mediata solleva anche interrogativi importanti. Non rischiamo forse di sostituire l’esperienza autentica con quella filtrata? La generazione dei social media, cresciuta con Instagram e TikTok, conosce bene questo dilemma: spesso si è più impegnati a documentare un’esperienza che a viverla pienamente. Analogamente, la lettura compulsiva può diventare una forma di fuga dalla realtà piuttosto che uno strumento per comprenderla meglio.
La mia esperienza personale mi ha insegnato che esiste una differenza qualitativa tra il conoscere un luogo attraverso le descrizioni letterarie e il camminare realmente per le sue strade. Quando ho visitato Praga dopo aver letto Kundera, ho scoperto che la città reale aveva sfumature, odori, rumori che nessuna descrizione avrebbe potuto trasmettermi. Allo stesso tempo, però, la lettura aveva preparato il mio sguardo, rendendomi più sensibile a certi dettagli e atmosfere.
L’incontro con l’altro: specchio dell’identità
Una delle intuizioni più penetranti di Parks riguarda la capacità del viaggio di farci incontrare “stranieri di ogni classe e clima”, acquisendo così “una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io”. Questa osservazione risuona profondamente con l’esperienza contemporanea della globalizzazione e della multiculturalità.
Nel mondo iperconnesso di oggi, l’incontro con l’alterità non avviene più solo durante viaggi fisici, ma quotidianamente attraverso internet, social media, videoconferenze. Tuttavia, questi incontri virtuali hanno spesso una qualità diversa da quelli fisici: sono più controllabili, filtrabili, interrompibili. Possiamo “unfollowware” qualcuno che ci disturba, chiudere una conversazione che ci mette a disagio. Nel viaggio fisico, invece, siamo costretti a confrontarci con situazioni impreviste e persone che potrebbero non scegliere di incontrare.
La domanda che Anna Karenina si pone guardando i passeggeri del treno – “Cosa sono io?” – è la stessa che ci poniamo nell’era dei social media, ma con una consapevolezza diversa. Sappiamo che la nostra identità online è frammentata, multipla, costruita. Quanto siamo diversi su LinkedIn rispetto a Instagram? Quanto l’io che presentiamo su Facebook corrisponde a quello che siamo nella vita quotidiana?
La letteratura come palestra emotiva
L’idea di Parks che “l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore” trova particolare risonanza nella funzione educativa ed emotiva che la letteratura può svolgere. I libri fungono da “palestra emotiva”, permettendoci di sperimentare situazioni estreme, dilemmi morali complessi, relazioni intense in un ambiente controllato.
Questa funzione è particolarmente importante per i giovani, che spesso si trovano ad affrontare scelte difficili senza avere ancora sviluppato una piena maturità emotiva. Leggere di come Elizabeth Bennet affronta i pregiudizi sociali in “Orgoglio e Pregiudizio” può offrire strumenti per gestire situazioni di discriminazione nella vita reale. Seguire il percorso di crescita di Harry Potter può aiutare a elaborare temi come l’amicizia, la perdita, la responsabilità.
Tuttavia, bisogna anche riconoscere i limiti di questa “palestra emotiva”. L’esperienza letteraria, per quanto intensa, rimane comunque indiretta. Non possiamo sostituire completamente l’esperienza diretta con quella mediata dalla lettura, così come non possiamo imparare a nuotare solo leggendo manuali di nuoto.
Il viaggio nell’era digitale: nuove forme, nuovi significati
La riflessione di Parks, scritta nel 2019, acquista nuove dimensioni alla luce degli sviluppi tecnologici più recenti. La pandemia di COVID-19 ha accelerato la digitalizzazione di molte esperienze, comprese quelle di viaggio. Tour virtuali di musei, viaggi in realtà virtuale, incontri online con culture diverse: queste nuove forme di esplorazione si collocano in una zona intermedia tra l’esperienza diretta e quella completamente mediata.
Allo stesso tempo, l’emergere dell’intelligenza artificiale ha iniziato a trasformare anche l’esperienza della lettura. Chat bot che possono discutere di libri, algoritmi che suggeriscono letture personalizzate, persino AI che scrivono racconti: questi sviluppi sollevano domande nuove sul rapporto tra autenticità dell’esperienza e mediazione tecnologica.
La mia generazione è cresciuta con queste tecnologie, e spesso non percepiamo una netta distinzione tra esperienza “reale” e “virtuale”. Per noi, un’amicizia nata online può essere altrettanto significativa di una nata offline. Una discussione su un libro in un forum può essere altrettanto arricchente di un incontro in un club di lettura fisico.
Quando il viaggio trasforma davvero
Nonostante apprezzi l’analogia di Parks, credo che esistano anche differenze fondamentali tra viaggio e lettura che non dovremmo sottovalutare. Il viaggio fisico comporta sempre un elemento di rischio e di imprevisto che la lettura, per quanto coinvolgente, difficilmente può replicare. Perdere un treno, non parlare la lingua locale, trovarsi in situazioni di disagio: questi elementi di “crisi controllata” sono spesso quelli che generano la crescita più significativa.
Ricordo un viaggio in interrail fatto con amici dopo la maturità: ci siamo trovati bloccati in una stazione di una piccola città dell’Europa dell’Est senza parlare la lingua locale e con pochissimi soldi. Quella situazione di difficoltà ci ha costretti a superare la timidezza, a chiedere aiuto, a inventare soluzioni creative. È stata un’esperienza formativa che nessun libro avrebbe potuto darmi, proprio perché comportava un rischio reale e richiedeva azioni concrete.
Il ruolo della lentezza
Un altro aspetto che distingue l’esperienza della lettura da quella del viaggio moderno è il ritmo. La lettura impone una sua temporalità: non possiamo accelerare troppo senza perdere comprensione, non possiamo saltare troppi passaggi senza perdere il filo. È un’esperienza intrinsecamente lenta in un mondo che va sempre più veloce.
Il viaggio contemporaneo, invece, è spesso caratterizzato dalla velocità: voli low-cost che ci permettono di fare weekend in capitali europee, viaggi organizzati che ci fanno vedere dieci città in una settimana. Questa velocità ha i suoi vantaggi – maggiore accessibilità, più opportunità di confronto – ma rischia anche di produrre esperienze superficiali, più simili a un consumo che a una vera scoperta.
Forse la vera saggezza sta nel riuscire a combinare la lentezza contemplativa della lettura con l’immediatezza sensoriale del viaggio, creando spazi di riflessione anche durante gli spostamenti fisici.
Verso una sintesi creativa
La riflessione di Parks, pur nella sua acutezza, sembra talvolta sottovalutare la complementarietà tra esperienza diretta e mediata. Non si tratta di scegliere tra viaggi reali e viaggi immaginari, ma di trovare modi per farli interagire creativamente.
La letteratura di viaggio contemporanea offre esempi interessanti di questa sintesi: autori come Tiziano Terzani o Claudio Magris combinano l’esperienza diretta del viaggio con la riflessione letteraria, creando opere che sono al tempo stesso reportage e letteratura, documentazione e invenzione.
Analogamente, molti giovani oggi documentano i propri viaggi attraverso blog, vlog, social media, trasformando l’esperienza vissuta in racconto condiviso. Questa pratica può essere vista come una forma moderna di quella “affinità tra libri e mezzi di trasporto” di cui parla Parks: il viaggio diventa immediatamente racconto, e il racconto influenza i viaggi futuri.
Conclusione: l’arte del viaggiare e del leggere
In conclusione, la riflessione di Tim Parks coglie un aspetto essenziale dell’esperienza umana: il bisogno di superare i confini del quotidiano, di esplorare mondi nuovi, di incontrare l’altro da sé. Sia la lettura che il viaggio rispondono a questo bisogno fondamentale, offrendo ciascuno modalità specifiche di arricchimento personale.
Tuttavia, credo che la vera ricchezza stia nella capacità di integrare queste diverse forme di esperienza, senza gerarchizzarle o sostituire le une con le altre. Un viaggio preparato attraverso letture sarà più consapevole; una lettura arricchita da esperienze di viaggio sarà più concreta. L’importante è mantenere quella curiosità e quella apertura all’ignoto che caratterizzano sia il buon viaggiatore che il buon lettore.
Nel mondo contemporaneo, dove le tecnologie digitali stanno creando nuove forme ibride di esperienza, questa integrazione diventa ancora più importante. Non dobbiamo temere che la realtà virtuale sostituisca il viaggio fisico o che gli audiolibri eliminino la lettura tradizionale. Dobbiamo invece imparare a utilizzare tutti questi strumenti per ampliare le nostre possibilità di conoscenza e di crescita personale.
L’arte del viaggiare e l’arte del leggere, in fondo, sono entrambe declinazioni dell’arte più ampia del vivere con consapevolezza, apertura e curiosità verso il mondo e verso noi stessi.





