
La discriminazione degli Ebrei, da “La sola colpa di essere nati” di L…
9 Giugno 2025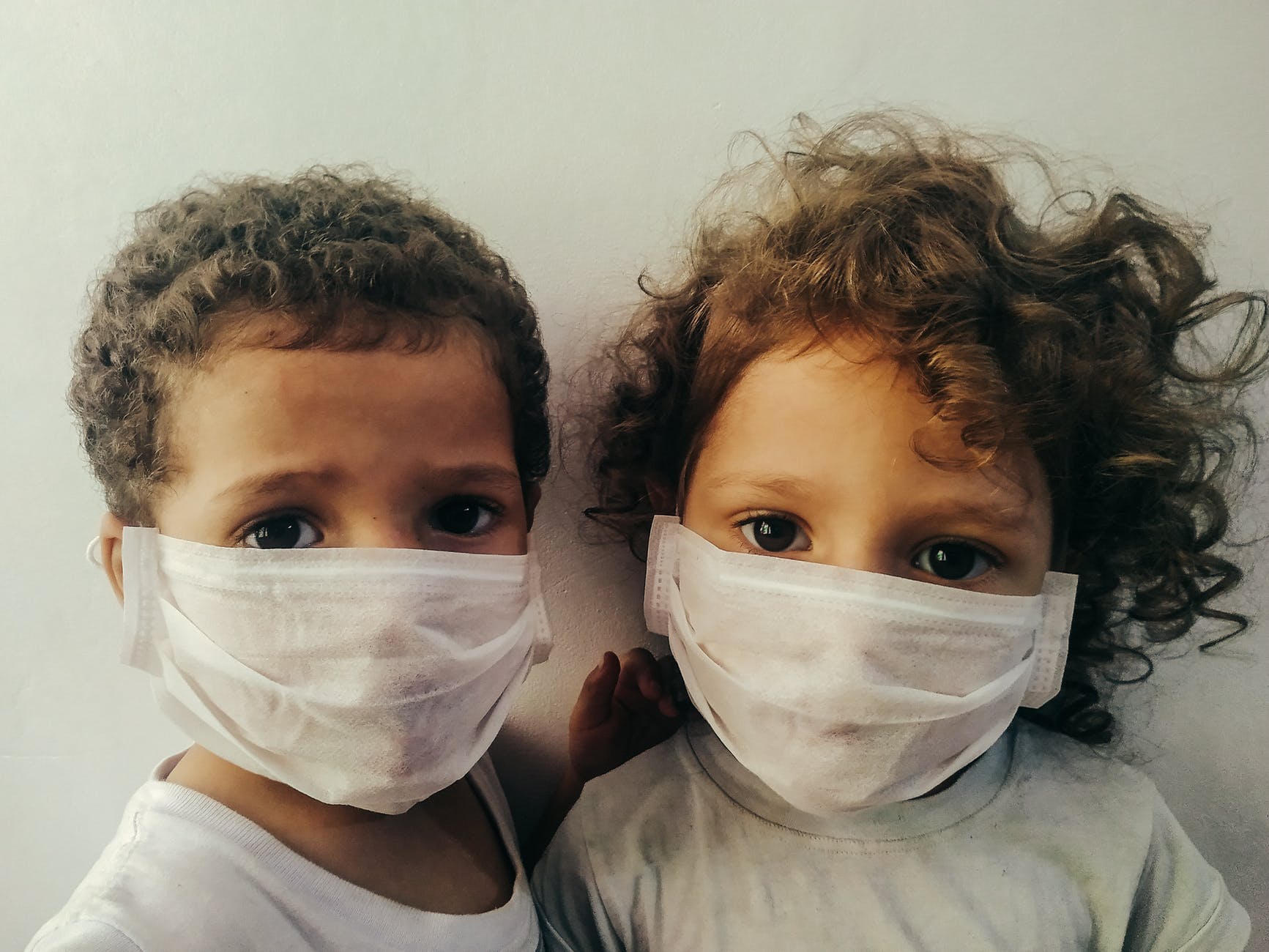
Pandemia emergenza globale
9 Giugno 2025Traccia e svolgimento di un Tema argomentativo sul riscaldamento globale

TRACCIA
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRIMA PROVA SCRITTA – PROVA DI ITALIANO – Sessione Ordinaria 2022
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
PROPOSTA B3
Dal discorso pronunciato da Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021, il giorno 8 ottobre 2021 alla Camera dei Deputati in occasione del Pre-COP26 Parliamentary Meeting, la riunione dei parlamenti nazionali in vista della COP26, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Glasgow (1-12 novembre 2021).
Il testo completo del discorso è reperibile su https://www.valigiablu.it/nobel-parisi-discorso-clima/
Testo:
«L’umanità deve fare delle scelte essenziali, deve contrastare con forza il cambiamento climatico. Sono decenni che la scienza ci ha avvertiti che i comportamenti umani stanno mettendo le basi per un aumento vertiginoso della temperatura del nostro pianeta. Sfortunatamente, le azioni intraprese dai governi non sono state all’altezza di questa sfida e i risultati finora sono stati assolutamente modesti. Negli ultimi anni gli effetti del cambiamento climatico sono sotto gli occhi di tutti: le inondazioni, gli uragani, le ondate di calore e gli incendi devastanti, di cui siamo stati spettatori attoniti, sono un timidissimo assaggio di quello che avverrà nel futuro su una scala enormemente più grande. Adesso, comincia a esserci una reazione forse più risoluta ma abbiamo bisogno di misure decisamente più incisive.
Dall’esperienza del COVID sappiamo che non è facile prendere misure efficaci in tempo. Spesso le misure di contenimento della pandemia sono state prese in ritardo, solo in un momento in cui non erano più rimandabili. Sappiamo tutti che «il medico pietoso fece la piaga purulenta». Voi avete il dovere di non essere medici pietosi. Il vostro compito storico è di aiutare l’umanità a passare per una strada piena di pericoli. È come guidare di notte. Le scienze sono i fari, ma poi la responsabilità di non andare fuori strada è del guidatore, che deve anche tenere conto che i fari hanno una portata limitata. Anche gli scienziati non sanno tutto, è un lavoro faticoso durante il quale le conoscenze si accumulano una dopo l’altra e le sacche di incertezza vengono pian piano eliminate. La scienza fa delle previsioni oneste sulle quali si forma pian piano gradualmente un consenso scientifico.
Quando l’IPCC¹ prevede che in uno scenario intermedio di riduzione delle emissioni di gas serra la temperatura potrebbe salire tra i 2 e i 3,5 gradi, questo intervallo è quello che possiamo stimare al meglio delle conoscenze attuali. Tuttavia deve essere chiaro a tutti che la correttezza dei modelli del clima è stata verificata confrontando le previsioni di questi modelli con il passato. Se la temperatura aumenta più di 2 gradi entriamo in una terra incognita in cui ci possono essere anche altri fenomeni che non abbiamo previsto, che possono peggiorare enormemente la situazione. Per esempio, incendi di foreste colossali come l’Amazzonia emetterebbero quantità catastrofiche di gas serra. Ma quando potrebbe accadere? L’aumento della temperatura non è controllato solo dalle emissioni dirette, ma è mitigato dai tantissimi meccanismi che potrebbero cessare di funzionare con l’aumento della temperatura. Mentre il limite inferiore dei 2 gradi è qualcosa sul quale possiamo essere abbastanza sicuri, è molto più difficile capire quale sia lo scenario più pessimistico. Potrebbe essere anche molto peggiore di quello che noi ci immaginiamo.
Abbiamo di fronte un enorme problema che ha bisogno di interventi decisi – non solo per bloccare le emissioni di gas serra – ma anche di investimenti scientifici. Dobbiamo essere in grado di sviluppare nuove tecnologie per conservare l’energia, trasformandola anche in carburanti, tecnologie non inquinanti che si basano su risorse rinnovabili. Non solo dobbiamo salvarci dall’effetto serra, ma dobbiamo evitare di cadere nella trappola terribile dell’esaurimento delle risorse naturali. Il risparmio energetico è anche un capitolo da affrontare con decisione. Per esempio, finché la temperatura interna delle nostre case rimarrà quasi costante tra estate e inverno, sarà difficile fermare le emissioni.
Bloccare il cambiamento climatico con successo richiede uno sforzo mostruoso da parte di tutti. È un’operazione con un costo colossale non solo finanziario, ma anche sociale, con cambiamenti che incideranno sulle nostre esistenze. La politica deve far sì che questi costi siano accettati da tutti. Chi ha più usato le risorse deve contribuire di più, in maniera da incidere il meno possibile sul grosso della popolazione. I costi devono essere distribuiti in maniera equa e solidale tra tutti i paesi.»
Dal discorso pronunciato da Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021, il giorno 8 ottobre 2021 alla Camera dei Deputati
in occasione del Pre-COP26 Parliamentary Meeting, la riunione dei parlamenti nazionali in vista della COP26,
la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Glasgow (1-12 novembre 2021).
Note:
¹ IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change – Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico.
Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande proposte.
- Riassumi il brano proposto nei suoi snodi tematici essenziali.
- Spiega il significato della similitudine presente nel testo: che cosa rappresentano i fari e cosa il guidatore? E l’automobile?
- Quali interventi fondamentali, a giudizio di Parisi, è necessario intraprendere per fornire possibili soluzioni ai problemi descritti nel discorso?
- Nel suo discorso Parisi affronta anche il tema dei limiti delle previsioni scientifiche: quali sono questi limiti?
Produzione
Il premio Nobel Parisi delinea possibili drammatici scenari legati ai temi del cambiamento climatico e dell’esaurimento delle risorse energetiche prospettando la necessità di urgenti interventi politici; condividi le considerazioni contenute nel brano? Esprimi le tue opinioni al riguardo, sulla base di quanto appreso nel tuo percorso di studi e delle tue conoscenze personali, elaborando un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.

SVOLGIMENTO
Analisi del Discorso di Giorgio Parisi sul Cambiamento Climatico
Il discorso di Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica 2021, tenuto alla Camera dei Deputati in vista della COP26, rappresenta un accorato e lucido appello all’azione di fronte alla crisi climatica. Con l’autorità della scienza, Parisi sottolinea l’urgenza di scelte fondamentali, la gravità degli scenari futuri e la necessità di un impegno congiunto e solidale, in un momento cruciale per il destino dell’umanità.
Comprensione e Analisi
1. Riassumi il brano proposto nei suoi snodi tematici essenziali.
Il brano di Giorgio Parisi si concentra sulla gravità e urgenza della crisi climatica, avvertendo che i comportamenti umani hanno posto le basi per un aumento vertiginoso della temperatura globale. Parisi evidenzia come le azioni intraprese finora dai governi siano state insufficienti, e come gli eventi climatici estremi (inondazioni, uragani, incendi) siano solo un “timidissimo assaggio” di scenari futi ben peggiori. Fa un parallelo con l’esperienza della pandemia di COVID-19, sottolineando la difficoltà di prendere misure efficaci in tempo e la necessità di agire con decisione politica, guidata dalla scienza. Afferma che la scienza fornisce previsioni “oneste” e un consenso graduale, ma esistono limiti nell’accurata stima degli scenari peggioristici, specialmente se la temperatura supera i 2 gradi Celsius, entrando in una “terra incognita” con fenomeni non previsti (es. incendi colossali). Per affrontare il problema, Parisi indica la necessità di interventi decisi: bloccare le emissioni di gas serra, investire nella ricerca scientifica per nuove tecnologie energetiche pulite e rinnovabili, e promuovere il risparmio energetico. Conclude ribadendo che bloccare il cambiamento climatico richiede uno “sforzo mostruoso” con costi “colossali”, che devono essere distribuiti in maniera equa e solidale tra paesi, con chi ha più usato le risorse che deve contribuire maggiormente.
2. Spiega il significato della similitudine presente nel testo: che cosa rappresentano i fari e cosa il guidatore? E l’automobile?
La similitudine “È come guidare di notte. Le scienze sono i fari, ma poi la responsabilità di non andare fuori strada è del guidatore, che deve anche tenere conto che i fari hanno una portata limitata” (righe 12-14) ha un significato profondo e plurimo:
- I fari rappresentano le scienze: Simboleggiano la conoscenza scientifica, le informazioni, i dati, le previsioni e le scoperte che illuminano il cammino. Essi forniscono la direzione, mettono in guardia dai pericoli e indicano le possibili vie da percorrere. Tuttavia, come sottolineato, anche “i fari hanno una portata limitata”, a indicare che la scienza non sa tutto, che è un “lavoro faticoso” in cui le conoscenze si accumulano gradualmente e le incertezze vengono eliminate pian piano.
- Il guidatore rappresenta la politica (e i governi/decisori): Simboleggia chi ha la responsabilità di prendere decisioni e agire. Il guidatore è colui che, pur avendo a disposizione l’illuminazione dei fari (la scienza), deve compiere le scelte concrete, sterzare, accelerare o frenare. È su di lui che ricade il “dovere di non essere medici pietosi”, ovvero di non esitare ad affrontare la realtà e a prendere misure impopolari ma necessarie.
- L’automobile (implicita) rappresenta l’umanità (o il suo cammino/futuro): Pur non essendo esplicitamente nominata, l’auto è il mezzo che i fari illuminano e che il guidatore manovra. Simboleggia il percorso dell’umanità nel suo insieme, il suo futuro, che è “una strada piena di pericoli” (r. 12). La sua direzione e la sua sicurezza dipendono dalla corretta interazione tra la luce della scienza e la guida responsabile della politica.
In sintesi, la similitudine evidenzia la fondamentale collaborazione tra scienza e politica: la scienza fornisce la conoscenza e gli avvertimenti, ma spetta alla politica la responsabilità di tradurre quella conoscenza in azioni concrete, affrontando anche i limiti intrinseci del sapere scientifico.
3. Quali interventi fondamentali, a giudizio di Parisi, è necessario intraprendere per fornire possibili soluzioni ai problemi descritti nel discorso?
A giudizio di Parisi, per fornire possibili soluzioni ai problemi del cambiamento climatico e dell’esaurimento delle risorse, è necessario intraprendere interventi decisi su più fronti:
- Bloccare le emissioni di gas serra: Questo è l’obiettivo primario e più diretto per contrastare l’aumento della temperatura globale. Richiede misure drastiche di riduzione delle fonti inquinanti.
- Investimenti scientifici: È fondamentale finanziare la ricerca per sviluppare nuove tecnologie.
- Tecnologie per conservare l’energia, anche trasformandola in carburanti (es. idrogeno verde, e-fuels).
- Tecnologie non inquinanti basate su risorse rinnovabili (solare, eolico, geotermico, ecc.).
- Risparmio energetico: Un capitolo da affrontare con decisione, implicando cambiamenti nei comportamenti quotidiani (es. mantenimento della temperatura interna delle case quasi costante tra estate e inverno). Questo significa anche un costo sociale, che la politica deve rendere accettabile.
- Distribuzione equa e solidale dei costi: Lo “sforzo mostruoso” e il “costo colossale” della transizione ecologica devono essere distribuiti in maniera giusta. Chi “ha più usato le risorse” (paesi più sviluppati, storicamente maggiori inquinatori) deve “contribuire di più”, in modo da incidere il meno possibile sulla “grosso della popolazione” e sui paesi meno sviluppati.
4. Nel suo discorso Parisi affronta anche il tema dei limiti delle previsioni scientifiche: quali sono questi limiti?
Nel suo discorso, Giorgio Parisi affronta con onestà i limiti delle previsioni scientifiche, sottolineando che la scienza, pur essendo un faro, non sa tutto. I principali limiti evidenziati sono:
- Incertezze residuali e gradualità dell’accumulo di conoscenza: La scienza è un “lavoro faticoso” in cui le conoscenze si accumulano “una dopo l’altra” e le “sacche di incertezza vengono pian piano eliminate” (righe 14-16). Questo implica che ci sono sempre margini di incertezza, specialmente quando si tratta di sistemi complessi come il clima.
- Previsioni basate su scenari intermedi e validità storica dei modelli: Quando l’IPCC prevede un intervallo di aumento della temperatura (es. tra 2 e 3,5 gradi), questo è stimato “al meglio delle conoscenze attuali” (r. 19-20). La correttezza dei modelli climatici è verificata confrontando le previsioni con il passato. Tuttavia, questo crea un limite.
- Ingresso in una “terra incognita” oltre determinate soglie: Il limite più critico è che “se la temperatura aumenta più di 2 gradi entriamo in una terra incognita” (r. 22-23). In questo scenario, “ci possono essere anche altri fenomeni che non abbiamo previsto”, i cosiddetti “punti di non ritorno” o “feedback loops” (come gli incendi di foreste colossali che emetterebbero quantità catastrofiche di gas serra). Questi fenomeni possono “peggiorare enormemente la situazione” (r. 24-25) e sono difficili da quantificare.
- Difficoltà nello stimare lo scenario più pessimistico: Mentre il limite inferiore di un certo aumento di temperatura può essere “abbastanza sicuro”, è “molto più difficile capire quale sia lo scenario più pessimistico” (r. 27-28). La complessità dei meccanismi che mitigano l’aumento della temperatura, e che potrebbero cessare di funzionare, rende il futuro più nero di quanto si possa immaginare.
In sintesi, la scienza è onesta sui suoi limiti: può fare previsioni affidabili entro certi parametri e sulla base dei dati passati, ma avverte che oltre una certa soglia di cambiamento, entriamo in un territorio sconosciuto dove le conseguenze potrebbero essere molto più gravi e imprevedibili di quanto i modelli attuali possano stimare.
Produzione
Il Futuro in Gioco: La Necessità di Agire di Fronte alla Crisi Climatica
Il discorso di Giorgio Parisi alla Camera dei Deputati, in quanto scienziato di fama mondiale, risuona come un appello categorico e non più procrastinabile. Il drammatico scenario delineato dal Premio Nobel per la Fisica, con il cambiamento climatico e l’esaurimento delle risorse energetiche come minacce concrete per il futuro dell’umanità, non è solo una previsione scientifica, ma un imperativo etico e politico. Condivido in maniera totale le sue considerazioni: viviamo in un momento cruciale in cui l’inerzia e la miopia politica rischiano di condannare le generazioni future a un’esistenza precaria su un pianeta sempre meno abitabile. La necessità di interventi urgenti e decisi non è più una questione di opinione, ma di sopravvivenza.
La prima e più evidente conferma delle tesi di Parisi arriva dalla realtà che quotidianamente ci circonda. Gli “uragani, le ondate di calore e gli incendi devastanti” non sono più eventi eccezionali, ma una triste consuetudine. L’estate 2023, per citare un’esperienza recente, ha visto l’Europa e il Mediterraneo colpiti da ondate di calore record e incendi che hanno devastato foreste e abitazioni, mentre altre regioni del mondo subivano inondazioni e siccità estreme. Questi fenomeni, che Parisi definisce “un timidissimo assaggio”, rendono tangibile l’urgenza. La mia esperienza, attraverso la visione dei telegiornali e la lettura di articoli scientifici divulgativi, rafforza la consapevolezza che le previsioni degli scienziati, pur con i loro margini di incertezza, sono purtroppo in linea con ciò che osserviamo.
Parisi sottolinea con forza la responsabilità della politica, paragonandola al “guidatore” che deve ascoltare i “fari” della scienza. L’esperienza della pandemia di COVID-19, pur nella sua diversa natura, ha dimostrato quanto sia difficile per i governi prendere decisioni impopolari in tempo utile, preferendo spesso “essere medici pietosi” con conseguenze disastrose. Il cambiamento climatico presenta una sfida ancora più grande, perché i suoi effetti sono spesso più lenti e meno immediatamente percepibili dal grande pubblico, rendendo difficile mobilitare il consenso politico per misure che richiedono sacrifici. Tuttavia, come sottolineato, la politica ha un “compito storico”: deve tradurre la conoscenza scientifica in azioni concrete, superando le resistenze e le logiche di breve termine.
Gli interventi fondamentali indicati da Parisi – bloccare le emissioni, investire in nuove tecnologie e promuovere il risparmio energetico – sono la strada maestra. Da un lato, è imprescindibile una decarbonizzazione rapida e profonda dell’economia, riducendo drasticamente l’uso di combustibili fossili in favore delle energie rinnovabili. Ciò richiede politiche industriali ambiziose, investimenti massicci e un cambiamento nei modelli di produzione e consumo. Dall’altro, la ricerca scientifica è cruciale per sviluppare soluzioni innovative per la conservazione dell’energia, la produzione di carburanti puliti e la cattura della CO2. Non si tratta solo di “non inquinare”, ma di ripensare l’intero sistema energetico. Il risparmio energetico, infine, richiede un cambiamento culturale profondo, che incide sulle abitudini quotidiane: è la parte “sociale” del “costo colossale” di cui parla Parisi, e deve essere accettata e condivisa dalla popolazione attraverso campagne di sensibilizzazione e incentivi.
La questione dei limiti delle previsioni scientifiche sollevata da Parisi è particolarmente significativa. Riconoscere che “se la temperatura aumenta più di 2 gradi entriamo in una terra incognita” e che lo scenario più pessimistico “potrebbe essere anche molto peggiore di quello che noi ci immaginiamo”, non è un’ammissione di impotenza, ma un ulteriore monito all’urgenza. Significa che non possiamo permetterci di giocare d’azzardo con il futuro del pianeta, sperando che gli scenari più catastrofici non si avverino. L’incertezza, in questo caso, è un fattore di rischio che impone una maggiore cautela e una maggiore determinazione nell’azione.
Infine, la questione della distribuzione equa e solidale dei costi è un aspetto cruciale. È innegabile che i paesi industrializzati, che hanno storicamente contribuito maggiormente all’accumulo di gas serra, abbiano una responsabilità maggiore. La transizione ecologica non può e non deve aggravare le disuguaglianze esistenti, né penalizzare i paesi meno sviluppati. È necessaria una solidarietà internazionale che garantisca un accesso equo alle tecnologie pulite e un sostegno finanziario per la loro implementazione a livello globale.
In conclusione, il discorso di Giorgio Parisi è un grido d’allarme che la politica non può più ignorare. Le sue considerazioni sulla necessità di agire con decisione, investire nella scienza, promuovere il risparmio energetico e garantire una transizione equa, sono la base su cui costruire un futuro sostenibile. La sfida del cambiamento climatico è “mostruosa”, ma la scienza ha indicato la strada. Ora spetta al “guidatore” prendere in mano il volante con coraggio e responsabilità, prima che sia troppo tardi per l’umanità intera.

Audio Lezioni, ascolta il podcast di Storia moderna e contemporanea del prof. Gaudio
Ascolta “Storia moderna e contemporanea” su Spreaker.




