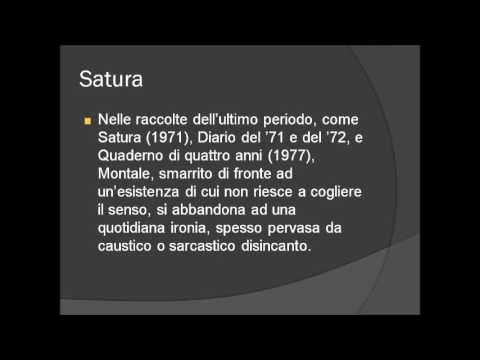Rischi dell’iperconnessione alla rete globale
9 Giugno 2025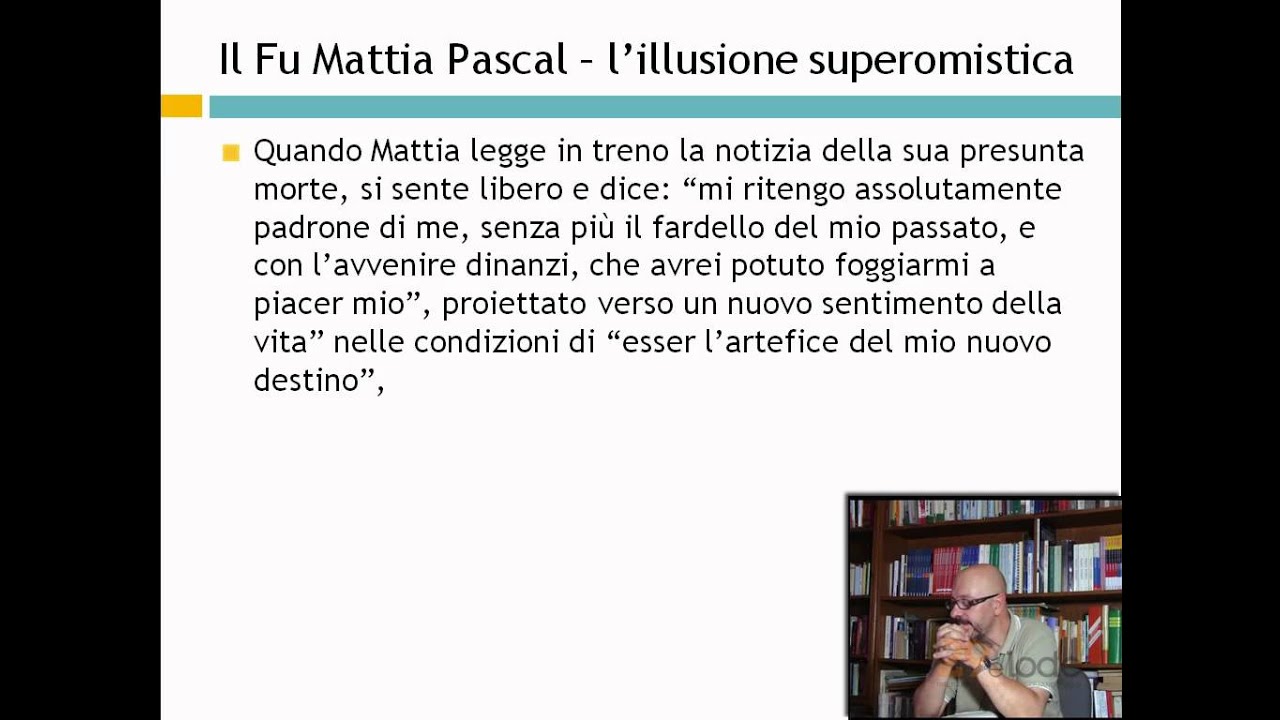
L’illusione di libertà dal romanzo “il Fu Mattia Pascal” di Lui…
9 Giugno 2025Traccia e svolgimento della Analisi del testo di “Le parole,” (da Satura) di Eugenio Montale
La poesia “Le parole” di Eugenio Montale è un testo molto significativo che affronta il tema della parola poetica attraverso una suggestiva personificazione, mostrando come le parole “preferiscano” contesti umili, piuttosto che nobili.
Traccia Tipologia A – Eugenio Montale, Le parole
ESAME DI STATO 2022 – SESSIONE SUPPLETIVA
PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
PROPOSTA A1
Autore: Eugenio Montale
Titolo: Le parole
Opera: Satura, Arnoldo Mondadori, Milano 1971, pp. 106-107
TESTO
Le parole
se si ridestano
rifiutano la sede
più propizia, la carta di Fabriano¹,
l’inchiostro di china,
la cartella di cuoio o di velluto
che le tenga in segreto;
le parole
quando si svegliano
si adagiano sul retro delle fatture,
sui margini dei bollettini del lotto,
sulle partecipazioni matrimoniali o di lutto;
le parole
non chiedono di meglio
che l’imbroglio dei tasti nell’Olivetti portatile²,
che il buio dei taschini del panciotto,
che il fondo del cestino, ridottevi in pallottole;
le parole
non sono affatto felici
di esser buttate fuori come zambracche³
e accolte con furore di plausi e disonore;
le parole
preferiscono il sonno nella bottiglia
al ludibrio⁴ di essere lette,
vendute, imbalsamate, ibernate;
le parole
sono di tutti e invano si celano
nei dizionari perché c’è sempre il marrano⁵
che dissotterra i tartufi più puzzolenti e più rari;
le parole
dopo un’eterna attesa
rinunziano alla speranza
di essere pronunziate una volta per tutte
e poi morire con chi le ha possedute.
Satura, Arnoldo Mondadori, Milano 1971, pp. 106-107
NOTE
¹ carta di Fabriano: tipo di carta particolarmente pregiata
² Olivetti portatile: macchina da scrivere fra le più diffuse all’epoca
³ zambracche: persone che si prostituiscono
⁴ ludibrio: derisione
⁵ marrano: traditore
CONTESTO STORICO-LETTERARIO
Nella raccolta Satura, pubblicata nel 1971, Eugenio Montale (1896-1981) sviluppa un nuovo corso poetico personale in cui i mutamenti, anche di tono, sono adeguati alla necessità di una rinnovata testimonianza di grandi sommovimenti sul piano ideologico, sociale, politico. Compito del poeta è, secondo Montale, quello di rappresentare la condizione esistenziale dell’uomo, descrivendo con la parola l’essenza delle cose e racchiudendo in un solo vocabolo il sentimento di un ricordo, di un paesaggio, di una persona.
COMPRENSIONE E ANALISI
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande proposte.
- Sintetizza i principali temi della poesia come si presentano nelle strofe.
- A tuo parere, perché le parole, quasi personificate e animate di vita propria dal poeta, preferiscono luoghi e ambienti umili e dimessi ed evitano sistemazioni più nobili e illustri?
- Quali sono le scelte lessicali della poesia e in che misura risultano coerenti con la tematica complessiva del testo? Proponi qualche esempio.
- Quale significato, a tuo avviso, si potrebbe attribuire alla strofa conclusiva della poesia?
- La ‘vita’ delle parole è definita dal poeta attribuendo loro sentimenti ed azioni tipicamente umane: illustra in che modo Montale attribuisce loro tratti di forte ‘umanità’.
INTERPRETAZIONE
La raccolta Satura, da cui la poesia è tratta, appartiene all’ultima produzione di Montale, caratterizzata da uno stile colloquiale e centrata spesso su ricordi personali, temi di cronaca o riflessioni esistenziali.
Rifletti sul tema, caro al poeta, della parola e del linguaggio poetico; puoi approfondire l’argomento anche mediante confronti con altri testi di Montale o di altri autori a te noti.
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO
Aspetti da considerare per l’analisi:
- La personificazione delle parole
- Il contrasto tra luoghi nobili e umili
- Le scelte lessicali e stilistiche
- La riflessione metaletteraria sul linguaggio poetico
- Il rapporto tra poeta e parola nella poetica montaliana
Struttura della risposta:
- Comprensione del testo e dei suoi temi principali
- Analisi delle tecniche poetiche utilizzate
- Interpretazione del significato complessivo
- Contestualizzazione nell’opera di Montale
Tempo disponibile: 6 ore
Lunghezza indicativa: 4-5 pagine di protocollo
Svolgimento della Analisi della poesia “Le parole” di Eugenio Montale
Analisi di ‘Le parole’ di Eugenio Montale
La poesia “Le parole”, tratta dalla raccolta Satura (1971) di Eugenio Montale, rappresenta una profonda e ironica riflessione sulla natura e sul destino del linguaggio poetico in un’epoca di profondi mutamenti. Montale, in questa fase della sua produzione, adotta un tono più colloquiale e disincantato, ma non per questo meno incisivo, per indagare il rapporto tra il poeta, le parole e la loro ricezione nella società.
Comprensione e Analisi
1. Sintetizza i principali temi della poesia come si presentano nelle strofe.
La poesia si sviluppa attraverso una serie di strofe che personificano le parole, rivelando la loro natura e il loro destino in un mondo che le usa e le consuma.
- Strofa 1 (vv. 1-8): Le parole, una volta risvegliate, rifiutano i luoghi nobili e tradizionali della scrittura (carta di Fabriano, inchiostro di china, cartella di cuoio/velluto) che dovrebbero custodirle “in segreto”. Il tema è il rifiuto della preziosità e della sacralità tradizionale.
- Strofa 2 (vv. 9-16): Preferiscono posarsi su supporti umili e quotidiani: i retro delle fatture, i margini dei bollettini del lotto, le partecipazioni matrimoniali o di lutto. Il tema è la preferenza per la concretezza e l’anonimato del quotidiano, la loro ubiquità.
- Strofa 3 (vv. 17-23): Le parole non chiedono altro che l’ambiente disordinato e meccanico della macchina da scrivere portatile, i taschini nascosti del panciotto o il fondo del cestino, dove finiscono “ridottevi / in pallottole”. Il tema è la loro degradazione, la loro strumentalizzazione e il loro spreco.
- Strofa 4 (vv. 24-29): Le parole non sono affatto felici di essere “buttate fuori / come zambracche” (prostitute) e di ricevere “furore di plausi / e disonore”. Il tema è la loro mercificazione e la superficialità con cui vengono usate e giudicate, che le priva di autenticità e dignità.
- Strofa 5 (vv. 30-34): Preferiscono il “sonno / nella bottiglia” (simbolo di un’esistenza inerte o nascosta) al “ludibrio” di essere “lette, vendute, / imbalsamate, ibernate”. Il tema è il rifiuto della celebrità postuma e della mercificazione culturale che snatura la loro essenza.
- Strofa 6 (vv. 35-40): Le parole sono “di tutti” e si celano invano nei dizionari, perché c’è sempre chi le “dissotterra” (il “marrano”) per scopi discutibili, tirando fuori anche le più “puzzolenti e più rari”. Il tema è la loro ineliminabile disponibilità e la facilità con cui possono essere distorte o usate impropriamente.
- Strofa 7 (vv. 41-46): Dopo un’eterna attesa, le parole rinunciano alla speranza di essere “pronunziate / una volta per tutte / e poi morire / con chi le ha possedute”. Il tema è la loro immortalità e la loro vocazione a persistere oltre il singolo individuo, ma anche una malinconica rassegnazione alla loro incapacità di trovare una sede definitiva e un significato ultimo nel tempo.
2. A tuo parere, perché le parole, quasi personificate e animate di vita propria dal poeta, preferiscono luoghi e ambienti umili e dimessi ed evitano sistemazioni più nobili e illustri?
Le parole, animate di vita propria da Montale, preferiscono luoghi e ambienti umili e dimessi ed evitano sistemazioni più nobili e illustri (come la “carta di Fabriano” o la “cartella di cuoio o di velluto”) perché questo riflette la loro natura più autentica e, per il poeta, il loro destino nella società contemporanea.
Questa scelta indica:
- Rifiuto della retorica e dell’ufficialità: Le parole “rifiutano la sede più propizia” e le sistemazioni “nobili” perché queste sono associate a una concezione della poesia e del linguaggio come qualcosa di sacro, distaccato dalla realtà quotidiana. Montale, in Satura, si allontana dall’ermetismo e dalla poesia aulica, abbracciando un linguaggio più prosaico e colloquiale. Le parole preferiscono la concretezza e la disadorna realtà delle “fatture”, dei “bollettini del lotto” o delle “partecipazioni matrimoniali o di lutto”, perché è lì che la vita vera si manifesta.
- L’ubiquità e la banalizzazione del linguaggio: Le parole sono ormai ovunque, usate e abusate in ogni contesto. Non sono più confinate al mondo della letteratura “alta”, ma si trovano sui documenti più comuni e persino nel “cestino” come “pallottole” stropicciate. Questa ubiquità le rende “di tutti”, ma ne indica anche una certa banalizzazione e svalutazione.
- La loro essenza non è nella forma esteriore: Per Montale, il valore delle parole non risiede nel supporto prezioso o nella loro confezione, ma nella loro capacità di esprimere, anche in contesti umili o frammentari. La loro essenza non è nell’aura sacra o nella celebrità, ma nella loro vitalità che può emergere anche dalla “Olivetti portatile” o dal “buio dei taschini del panciotto”.
In sintesi, le parole preferiscono l’umiltà perché è lì che si riconoscono come strumenti della vita reale, svincolate dalle pretese di grandezza o di sacralità che la tradizione letteraria a volte imponeva, e che, nell’epoca contemporanea, finirebbero per imbalsamarle.
3. Quali sono le scelte lessicali della poesia e in che misura risultano coerenti con la tematica complessiva del testo? Proponi qualche esempio.
Le scelte lessicali della poesia sono caratterizzate da un tono prosastico, colloquiale, a tratti ironico e disincantato, con l’introduzione di termini quotidiani e persino triviali. Questa scelta è estremamente coerente con la tematica complessiva del testo, che riflette una critica alla mercificazione e banalizzazione del linguaggio nella società moderna, e la ricerca di un’autenticità che prescinde dall’aulicità.
Alcuni esempi:
- Riferimenti a oggetti quotidiani e burocratici: “carta di Fabriano” (per la sua preziosità), “fatture”, “bollettini del lotto”, “partecipazioni / matrimoniali o di lutto”, “Olivetti portatile”, “tastini”, “taschini / del panciotto”, “cestino”. Questo lessico è concreto, antiretorico, e mostra dove le parole finiscono realmente, nella vita comune e spesso burocratica, lontane dalla torre d’avorio.
- Termini che evocano degradazione e trivialità: “zambracche” (prostitute), “pallottole” (come stracci di carta), “puzzolenti”. L’uso di “zambracche” per descrivere le parole buttate fuori è particolarmente forte e indica una mercificazione e una perdita di dignità del linguaggio, trattato come merce di scambio o oggetto di consumo. Le parole vengono “sprecate” o “abusate”.
- Verbi che indicano azione e volontà (per le parole personificate): “si ridestano”, “rifiutano”, “si adagiano”, “non chiedono di meglio”, “non sono affatto felici”, “preferiscono”, “si celano”, “rinunziano”. Questa attribuzione di volontà e sentimenti a oggetti inanimati è coerente con la personificazione centrale del testo e sottolinea la “vita propria” delle parole, che hanno desideri e avversioni.
- Espressioni di giudizio e malinconia: “ludibrio”, “disonore”, “eterna attesa”, “rinunziano alla speranza”. Questi termini veicolano la sofferenza e la rassegnazione delle parole stesse di fronte al loro destino di essere incomprese o usate impropriamente.
Nel complesso, il lessico basso e colloquiale, insieme alle metafore e alle personificazioni, crea un effetto di disincanto e di amara constatazione sulla condizione del linguaggio nell’epoca contemporanea, rivelando la distanza tra il potenziale intrinseco delle parole e il loro effettivo uso.
4. Quale significato, a tuo avviso, si potrebbe attribuire alla strofa conclusiva della poesia?
La strofa conclusiva (“le parole / dopo un’eterna attesa / rinunziano alla speranza / di essere pronunziate / una volta per tutte / e poi morire / con chi le ha possedute”) ha un significato profondamente malinconico e amaro, ma anche rivelatorio sulla natura e sul destino del linguaggio poetico (e non solo).
- Il desiderio di definitività e la sua impossibilità: Le parole, in questa strofa, esprimono il desiderio di essere “pronunziate una volta per tutte”, ovvero di raggiungere un significato ultimo, definitivo, un’espressione perfetta che le esaurisca completamente, per poi “morire” con chi le ha possedute, suggellando un legame indissolubile con l’autore. Questo desiderio riflette l’aspirazione del poeta a una parola “vera”, capace di cogliere l’essenza delle cose e di comunicarla in modo totale.
- La rassegnazione all’immortalità e alla dispersione: Tuttavia, le parole “rinunziano alla speranza” di questa definitiva pronuncia. Questo implica la consapevolezza che il linguaggio è per sua natura polisemico, interpretato e reinterpretato incessantemente. Le parole non muoiono con il loro autore o con un unico significato; sono “di tutti” (come dice la strofa precedente) e continuano a vivere e a circolare, assumendo nuove connotazioni. Questo è un dato di fatto, ma anche una forma di condanna: la parola poetica non può trovare la sua pace, il suo riposo finale in una comprensione totale, ma è destinata a una circolazione eterna e talvolta svilente.
- La perdita di controllo dell’autore: La rinuncia alla morte con l’autore significa anche la perdita di controllo da parte del poeta sul destino della propria creazione. Una volta “buttate fuori”, le parole prendono una vita propria, subendo i “plausi” e il “disonore”, e non possono più essere richiamate o fissate nel loro significato originale.
In sintesi, la strofa conclusiva esprime il fallimento di un’aspirazione romantica o decadente alla parola assoluta, rivelando la consapevolezza che il linguaggio è un’entità autonoma, complessa e sfuggente, destinata a un’eterna circolazione che può anche disperderne o mercificarne il senso più profondo. È un epilogo amaro sulla condizione del poeta e della poesia in un mondo moderno.
5. La ‘vita’ delle parole è definita dal poeta attribuendo loro sentimenti ed azioni tipicamente umane: illustra in che modo Montale attribuisce loro tratti di forte ‘umanità’.
Montale attribuisce alle parole tratti di forte “umanità” attraverso una costante e pervasiva personificazione, che le rende vere e proprie entità senzienti, dotate di volontà, preferenze, emozioni e persino un destino.
- Volontà e autonomia: Le parole “si ridestano” (v. 2), come se avessero una loro autonomia vitale, un risveglio indipendente. “Rifiutano” (v. 3) luoghi specifici e “preferiscono” (v. 30) altri, dimostrando una propria agency. Non “chiedono di meglio” (v. 17), esprimendo desideri. Questa autonomia le svincola dal mero ruolo di strumenti passivi dell’uomo.
- Sentimenti ed emozioni: Le parole “non sono affatto felici” (v. 24) di essere trattate in un certo modo, provando quindi infelicità. Provano un “ludibrio” (v. 31), ovvero una sensazione di derisione o umiliazione. Hanno una “speranza” (v. 42) che poi “rinunziano” (v. 42), provando delusione o rassegnazione.
- Azioni e atteggiamenti umani: Si “adagiano” (v. 10) sui supporti, come persone che si riposano. Vengono “buttate fuori” (v. 25) e “accolte / con furore di plausi / e disonore” (vv. 26-28), come attori che salgono sul palco. Sono “imbalsamate, ibernate” (v. 33), subendo un processo post-mortem. Si “celano” (v. 36) nei dizionari, come se si nascondessero. Infine, aspettano (“eterna attesa”, v. 41) e “pronunziate” (v. 43) e “morire” (v. 45), come esseri viventi.
Attribuendo questi tratti umani alle parole, Montale le eleva al rango di protagoniste della sua riflessione. Non sono più semplici veicoli di significato, ma entità che riflettono la condizione dell’uomo stesso: la sua fragilità, la sua dignità violata, la sua ricerca di senso, la sua rassegnazione di fronte a un destino che sembra sfuggire al controllo. La personificazione è lo strumento con cui Montale esprime, in chiave metaforica, la sua visione del linguaggio e della poesia in un’epoca di profonda crisi dei valori e delle forme espressive.
Interpretazione
La raccolta Satura, da cui “Le parole” è tratta, segna un’importante svolta nella poetica di Eugenio Montale. Dopo le raccolte precedenti, più dense e spesso ermetiche (Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro), in Satura il poeta adotta un tono più colloquiale, prosastico, a tratti ironico e disincantato. Questo mutamento di stile e tono si adegua alla necessità di una rinnovata testimonianza di “grandi sommovimenti sul piano ideologico, sociale, politico”, ma soprattutto a una diversa percezione della condizione esistenziale dell’uomo e del ruolo della poesia stessa. “Le parole” è un testo emblematico di questa nuova fase, concentrandosi sul tema centrale della parola e del linguaggio poetico.
Il tema della parola e del linguaggio in Montale è sempre stato cruciale, ma in Satura assume una connotazione diversa. Nelle opere giovanili, la parola montaliana aspirava a cogliere l’essenza delle cose, a racchiudere in un “solo vocabolo il sentimento di un ricordo, di un paesaggio, di una persona”, spesso attraverso il “correlativo oggettivo” (ad esempio, il “limone” che restituisce un barlume di verità nel paesaggio ligure). La parola era uno strumento arduo, ricercato, capace di scardinare l’opacità del reale e di rivelare un’intuizione, un’epifania. In Satura, invece, la parola è declassata, mercificata, usata e abusata. La nobiltà della “carta di Fabriano” è sostituita dalle “fatture” e dai “bollettini del lotto”, le macchine da scrivere portatili sostituiscono la penna, e le parole stesse vengono “buttate fuori come zambracche”. Questo riflette un senso di disillusione nei confronti della capacità del linguaggio di veicolare un senso profondo o di resistere alla banalizzazione della società di massa.
Il “nuovo corso poetico” di Montale in Satura è caratterizzato da un’ironia amara e da un tono conversazionale, quasi di cronaca, che si adatta a un’epoca in cui le grandi ideologie sono crollate e la poesia non può più permettersi i toni oracolari o profetici. “Le parole” è un’autoironia, ma anche una critica profonda alla società. Le parole non sono più “felici” di essere usate e abusate, desiderano una “morte” che non arriva, una definitiva pronuncia che le fissi nel loro significato autentico, ma sono condannate a un’esistenza eterna e dispersiva.
Possiamo confrontare questa visione con quella di altri autori. Mentre, ad esempio, per Ungaretti la parola è spesso ridotta all’essenziale, purificata, quasi un’epigrafe che condensa l’esperienza e cerca l’assoluto (“M’illumino d’immenso”), in Montale le parole si “spandono”, si mescolano al quotidiano, perdono parte della loro sacralità ma acquistano una nuova, amara vitalità. La loro rassegnazione a non “morire con chi le ha possedute” è un eco della loro immortalità, ma anche della loro inevitabile “traduzione” e interpretazione da parte di “marrani” che le distorcono.
Il tema della parola svilita si ritrova anche in autori successivi. Si pensi, in un contesto più ampio, alla riflessione di Pier Paolo Pasolini sulla “mutazione antropologica” e sul genocidio culturale operato dalla società dei consumi, che appiattisce il linguaggio e ne svuota il senso. Anche lui, a suo modo, lamentava la perdita di una lingua autentica. O, nella letteratura più contemporanea, si può pensare a come la proliferazione di informazioni e la rapidità della comunicazione digitale (social media, messaggistica) abbiano generato un linguaggio sempre più frammentato, sintetico, spesso privo di sfumature, dove le parole sono “ridotte in pallottole” e perdono la loro profondità.
In conclusione, “Le parole” di Montale in Satura non è solo una riflessione sul linguaggio, ma una testimonianza acuta della condizione dell’uomo nella società moderna. Il poeta, consapevole della crisi delle grandi narrazioni, sceglie di guardare alle parole con un misto di affetto e disincanto, riconoscendo la loro vitalità insopprimibile ma anche il loro destino di essere mercificate e fraintese. È un’elegia per un linguaggio che vorrebbe essere “uno per tutti”, ma che è condannato a una circolazione incessante e a infinite interpretazioni, un’amara verità che risuona con sorprendente attualità anche oggi, nell’era dell’iperconnessione e della comunicazione di massa.