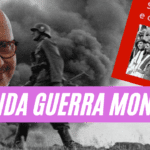
Scambio di lettere fra Churchill e Stalin nel 1941
9 Giugno 2025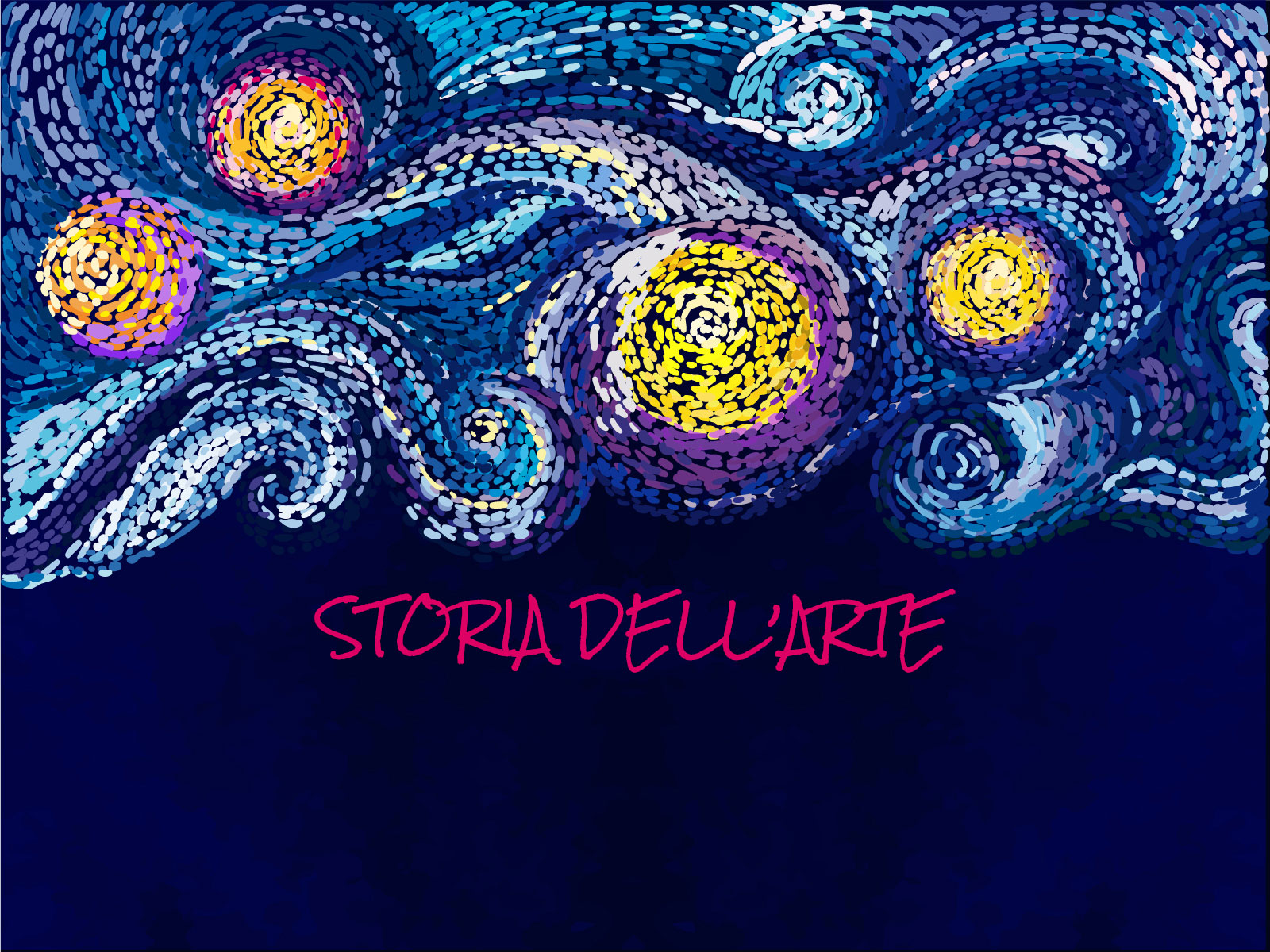
Grand tour d’Italia a piccoli passi di Philippe Daverio
9 Giugno 2025Traccia e svolgimento di un Tema argomentativo sulla visione multidisciplinare necessaria per risolvere i problemi complessi

TRACCIA
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRIMA PROVA SCRITTA – PROVA DI ITALIANO – Sessione Suppletiva 2022
TIPOLOGIA B ESAME DI STATO 2022 – PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO
PROPOSTA B2
Testo tratto da: Manlio Di Domenico, Complesso è diverso da complicato: per questo serve multidisciplinarietà, in “Il Sole 24 ore”, supplemento Nòva, 6 marzo 2022, pag. 18.
Il testo
Una pandemia è un complesso fenomeno biologico, sociale ed economico. “Complesso” è molto diverso da “complicato”: il primo si riferisce alle componenti di un sistema e alle loro interazioni, il secondo si usa per caratterizzare un problema in relazione al suo grado di difficoltà. Un problema complicato richiede molte risorse per essere approcciato, ma può essere risolto; un problema complesso non garantisce che vi sia una soluzione unica e ottimale, ma è spesso caratterizzato da molteplici soluzioni che coesistono, alcune migliori di altre e molte egualmente valide. […]
Ma perché è importante capire la distinzione tra complicato e complesso? Questa distinzione sta alla base degli approcci necessari per risolvere in maniera efficace i problemi corrispondenti. I problemi complicati possono essere risolti molto spesso utilizzando un approccio riduzionista, dove l’oggetto di analisi, per esempio uno smartphone, può essere scomposto nelle sue componenti fondamentali che, una volta comprese, permettono di intervenire, con un costo noto e la certezza di risolvere il problema. Purtroppo, per i problemi complessi questo approccio è destinato a fallire: le interazioni tra le componenti sono organizzate in modo non banale e danno luogo a effetti che non possono essere previsti a partire dalla conoscenza delle singole parti. […]
Un’osservazione simile fu fatta da Philip Anderson, Nobel per la Fisica nel 1977, in un articolo che è stato citato migliaia di volte e rappresenta una delle pietre miliari della scienza della complessità: «More is different». Anderson sottolinea come la natura sia organizzata in una gerarchia, dove ogni livello è caratterizzato da una scala specifica. […] Ogni scala ha una sua rilevanza: gli oggetti di studio (particelle, molecole, cellule, tessuti, organi, organismi, individui, società) a una scala sono regolati da leggi che non sono banalmente deducibili da quelle delle scale inferiori. Nelle parole di Anderson, la biologia non è chimica applicata, la chimica non è fisica applicata, e così via.
Questo excursus è necessario per comprendere come va disegnata una risposta chiara a un problema complesso come la pandemia di Covid 19, che interessa molteplici scale: da quella molecolare, dove le interazioni tra le proteine (molecole molto speciali necessarie al funzionamento della cellula) del virus Sars-Cov-2 e del suo ospite umano (e non), sono in grado di generare alterazioni nel tradizionale funzionamento dei nostri sistemi, dall’immunitario al respiratorio, dal circolatorio al nervoso, causando in qualche caso – la cui incidenza è ancora oggetto di studio – problemi che interessano molteplici organi, anche a distanza di tempo dall’infezione. Virologi, biologi evoluzionisti, infettivologi, immunologi, patologi: tutti mostrano competenze specifiche necessarie alla comprensione di questa fase del fenomeno.
Ma non solo: la circolazione del virus avviene per trasmissione aerea, […] e il comportamento umano, che si esprime tramite la socialità, è la principale fonte di trasmissione. A questa scala è l’epidemiologia la scienza che ci permette di capire il fenomeno, tramite modelli matematici e scenari che testano ipotesi su potenziali interventi. Ma l’attuazione o meno di questi interventi ha effetti diretti, talvolta prevedibili e talvolta imprevedibili, sull’individuo e la società: dalla salute individuale (fisica e mentale) a quella pubblica, dall’istruzione all’economia. A questa scala, esperti di salute pubblica, sociologia, economia, scienze comportamentali, pedagogia, e così via, sono tutti necessari per comprendere il fenomeno.
Il dibattito scientifico, contrariamente a quanto si suppone, poggia sul porsi domande e dubitare, in una continua interazione che procede comprovando i dati fino all’avanzamento della conoscenza. Durante una pandemia gli approcci riduzionistici non sono sufficienti, e la mancanza di comunicazione e confronto tra le discipline coinvolte alle varie scale permette di costruire solo una visione parziale, simile a quella in cui vi sono alcune tessere di un puzzle ma è ancora difficile intuirne il disegno finale. L’interdisciplinarietà non può, e non deve, più essere un pensiero illusorio, ma dovrebbe diventare il motore della risposta alla battaglia contro questa pandemia. Soprattutto, dovrebbe essere accompagnata da una comunicazione istituzionale e scientifica chiara e ben organizzata, per ridurre il rischio di infodemia e risposte comportamentali impreviste.
da: Manlio Di Domenico, Complesso è diverso da complicato: per questo serve multidisciplinarietà,
in “Il Sole 24 ore”, supplemento Nòva, 6 marzo 2022, pag. 18.
Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande proposte.
- Sintetizza l’articolo e spiega il significato dell’espressione «More is different».
- Quali sono le tesi centrali presentate nell’articolo e con quali argomenti vengono sostenute? Spiega anche le differenze esistenti tra un problema complesso e un problema complicato e perché un problema complicato può essere risolto più facilmente di un problema complesso.
- Che cosa caratterizza un “approccio riduzionista” e quali sono i suoi limiti?
- Quali caratteristiche peculiari della conoscenza scientifica sono state evidenziate dal recente fenomeno della pandemia?
Produzione
Dopo aver letto e analizzato l’articolo, esprimi le tue considerazioni sulla relazione tra la complessità e la conoscenza scientifica, confrontandoti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali. Sviluppa le tue opinioni in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.

SVOLGIMENTO
Analisi dell’articolo “Complesso è diverso da complicato” di Manlio Di Domenico
L’articolo di Manlio Di Domenico su “Il Sole 24 ore” affronta una distinzione fondamentale per la comprensione e la risoluzione dei problemi contemporanei: quella tra “complesso” e “complicato”. Prendendo spunto dalla pandemia di COVID-19, l’autore argomenta la necessità di un approccio multidisciplinare e di una comunicazione scientifica chiara, rivelando i limiti degli approcci riduzionisti.
Comprensione e Analisi
1. Sintetizza l’articolo e spiega il significato dell’espressione «More is different».
L’articolo di Manlio Di Domenico introduce la distinzione cruciale tra “complesso” e “complicato” per affrontare fenomeni come una pandemia. Un problema “complicato” è risolvibile con molte risorse e un approccio riduzionista, mentre un problema “complesso” è caratterizzato da interazioni non banali tra le sue componenti, con effetti imprevedibili e molteplici soluzioni coesistenti. L’autore sostiene che per i problemi complessi l’approccio riduzionista è insufficiente e che è necessaria una visione multidisciplinare, citando l’affermazione di Philip Anderson, “More is different”, per spiegare come ogni livello gerarchico della natura sia regolato da leggi non deducibili banalmente da quelle dei livelli inferiori. La pandemia di COVID-19 viene presentata come un esempio di problema complesso che richiede competenze da diverse scale (molecolare, virale, sociale, comportamentale) e la collaborazione tra discipline (virologia, epidemiologia, sociologia, economia, ecc.). L’articolo conclude ribadendo che, per affrontare problemi complessi, l’interdisciplinarietà e una comunicazione scientifica chiara sono motori indispensabili, essenziali per costruire una visione completa e ridurre il rischio di infodemia.
L’espressione “More is different” (r. 13) di Philip Anderson significa che quando le componenti di un sistema si aggregano per formare un livello di organizzazione superiore, le loro interazioni danno vita a fenomeni e leggi emergenti che non possono essere semplicemente dedotte o previste dalla somma delle proprietà delle singole parti prese isolatamente. In altre parole, la complessità non è solo una questione di quantità (più elementi), ma di qualità (l’emergere di nuove proprietà e comportamenti a un livello superiore). L’esempio fornito da Anderson è che “la biologia non è chimica applicata, la chimica non è fisica applicata” (r. 16-17), a indicare che ogni livello della gerarchia naturale (particelle, molecole, cellule, organismi, società) ha le proprie leggi e dinamiche specifiche, che non sono banalmente riconducibili a quelle dei livelli sottostanti.
2. Quali sono le tesi centrali presentate nell’articolo e con quali argomenti vengono sostenute? Spiega anche le differenze esistenti tra un problema complesso e un problema complicato e perché un problema complicato può essere risolto più facilmente di un problema complesso.
Le tesi centrali presentate nell’articolo sono:
- La necessità di distinguere tra problemi “complessi” e “complicati”: Questa distinzione è fondamentale per un approccio efficace alla risoluzione dei problemi.
- L’insufficienza dell’approccio riduzionista per i problemi complessi: Questo approccio è destinato a fallire di fronte a sistemi le cui interazioni generano effetti imprevedibili.
- L’indispensabilità della multidisciplinarietà e dell’interdisciplinarietà: Per affrontare i problemi complessi, è essenziale integrare conoscenze e metodologie da diverse discipline.
- L’importanza di una comunicazione scientifica e istituzionale chiara: Per evitare l’infodemia e garantire risposte comportamentali adeguate.
Queste tesi vengono sostenute attraverso i seguenti argomenti:
-
Differenza tra complicato e complesso:
- Complicato: Riguarda il grado di difficoltà di un problema. Richiede molte risorse ma può essere risolto, spesso con una soluzione unica e ottimale (es. uno smartphone scomposto nelle sue componenti).
- Complesso: Si riferisce alle componenti di un sistema e alle loro interazioni non banali, che generano effetti imprevedibili. Non garantisce una soluzione unica e ottimale, ma molteplici soluzioni coesistenti. Un problema complicato è più facilmente risolvibile perché le sue componenti e le loro interazioni sono ben note e prevedibili; è come un orologio, che può essere smontato e rimontato seguendo uno schema preciso. Un problema complesso, invece, è come un ecosistema, dove la modifica di una componente può avere effetti a cascata imprevedibili sull’intero sistema a causa delle interazioni non lineari.
-
Limiti dell’approccio riduzionista: L’approccio riduzionista, che scompone l’oggetto di analisi nelle sue parti fondamentali, funziona per i problemi complicati. Tuttavia, per i problemi complessi, fallisce perché “le interazioni tra le componenti sono organizzate in modo non banale e danno luogo a effetti che non possono essere previsti a partire dalla conoscenza delle singole parti”. La citazione di Philip Anderson (“More is different”) rafforza questo punto, spiegando che le leggi che governano un livello superiore di organizzazione non sono banalmente deducibili da quelle dei livelli inferiori.
-
Esempio della pandemia di COVID-19: La pandemia è il caso di studio che illustra la complessità, interessando molteplici scale (molecolare, cellulare, organica, individuale, sociale) e richiedendo l’intervento di virologi, biologi evoluzionisti, infettivologi, immunologi, patologi, epidemiologi, esperti di salute pubblica, sociologia, economia, scienze comportamentali, pedagogia, ecc. Questa vasta gamma di competenze è necessaria perché il virus interagisce a diversi livelli e il comportamento umano è una fonte chiave di trasmissione e ha effetti su più dimensioni della società.
-
Necessità di interdisciplinarietà e comunicazione: Il dibattito scientifico è basato sul dubbio e sul confronto. Durante una pandemia, gli approcci riduzionistici sono insufficienti, e la mancanza di comunicazione tra le discipline crea una “visione parziale”, come “alcune tessere di un puzzle” senza il disegno finale. L’interdisciplinarietà deve diventare il “motore della risposta”, accompagnata da una comunicazione istituzionale e scientifica chiara per ridurre l’infodemia e le risposte comportamentali impreviste.
3. Che cosa caratterizza un “approccio riduzionista” e quali sono i suoi limiti?
Un “approccio riduzionista” è un metodo di analisi e risoluzione dei problemi che consiste nello scomporre un oggetto di studio o un fenomeno nelle sue componenti fondamentali, più piccole e semplici, per comprenderle individualmente. Si assume che, una volta comprese le singole parti, sia possibile comprendere il sistema nel suo complesso, intervenire su di esso e prevederne il comportamento. È un approccio che cerca di isolare le variabili e di studiare le relazioni causa-effetto in contesti controllati. L’esempio fornito è quello di uno smartphone: scomponendolo, si possono capire le funzioni di ogni singola componente (chip, batteria, schermo), e intervenire su quella specifica parte per risolvere un problema.
I suoi limiti emergono quando si applica ai “problemi complessi”:
- Ignoranza delle interazioni emergenti: Il limite principale è che l’approccio riduzionista non riesce a cogliere le “interazioni non banali” tra le componenti. Queste interazioni, infatti, danno luogo a “effetti che non possono essere previsti a partire dalla conoscenza delle singole parti”. Come sottolineato da Anderson con “More is different”, le proprietà e le leggi che emergono a un livello superiore di organizzazione non sono semplicemente la somma o la deduzione lineare delle proprietà delle parti inferiori.
- Incapacità di prevedere fenomeni a scala superiore: Non è sufficiente capire la chimica per capire la biologia, né la biologia per capire il comportamento sociale. Ogni scala ha le sue leggi emergenti. Di conseguenza, studiare solo una singola componente di un sistema complesso (ad esempio, solo il virus a livello molecolare) non permette di prevedere o controllare il comportamento del sistema nel suo complesso (la pandemia a livello sociale, economico, ecc.).
- Visione parziale del problema: L’applicazione esclusiva di un approccio riduzionista a un problema complesso porta a una “visione parziale”, come avere “alcune tessere di un puzzle ma è ancora difficile intuirne il disegno finale”. Questo rende difficile formulare risposte chiare ed efficaci.
In sintesi, l’approccio riduzionista è efficace per problemi ben definiti e circoscritti, ma fallisce quando la complessità del sistema risiede proprio nelle interconnessioni e nei fenomeni emergenti che non possono essere compresi analizzando le parti isolatamente.
4. Quali caratteristiche peculiari della conoscenza scientifica sono state evidenziate dal recente fenomeno della pandemia?
Il recente fenomeno della pandemia ha evidenziato diverse caratteristiche peculiari e fondamentali della conoscenza scientifica, talvolta mettendone in luce anche le sfide e le dinamiche interne:
- Processo di continuo avanzamento e incertezza iniziale: La pandemia ha mostrato che la scienza non è un corpo di verità statico e immutabile, ma un processo dinamico di accumulo di conoscenze. Inizialmente, c’erano molte “sacche di incertezza” sul virus, sulla sua trasmissione, sulla sua letalità e sulle terapie. Le conoscenze si sono accumulate “una dopo l’altra” attraverso la ricerca incessante, e queste incertezze sono state “pian piano eliminate”.
- Il dibattito e il dubbio come fondamento: Contrariamente alla percezione comune di una scienza granitica, la pandemia ha reso palese che il “dibattito scientifico poggia sul porsi domande e dubitare”. Ci sono state ipotesi diverse, scienziati con posizioni contrastanti, e un continuo processo di confronto e comprovazione dei dati. Questa è la natura stessa della scienza: un percorso di affinamento attraverso la verifica e la critica.
- Il consenso scientifico come processo graduale: Il “consenso scientifico” non è un’affermazione ex cathedra, ma qualcosa che si forma “pian piano gradualmente” (r. 17). Questo è stato evidente nella definizione delle linee guida per la salute pubblica, che si sono evolute man mano che i dati diventavano più solidi (es. mascherine, distanziamento, vaccini).
- L’onestà sulle previsioni e i loro limiti: La scienza, come ribadito da Parisi, fa “previsioni oneste” ma è anche trasparente sui propri limiti, specialmente di fronte a fenomeni complessi. La pandemia ha mostrato che i modelli, pur validi, potevano non catturare tutti i fattori emergenti o imprevedibili (come nuove varianti o risposte comportamentali inattese). Il concetto di “terra incognita” al di là di certe soglie (es. l’aumento della temperatura) è stato reso evidente.
- La necessità dell’interdisciplinarietà: La pandemia ha chiarito che nessuna singola disciplina (virologia, epidemiologia, sociologia, psicologia) poteva risolvere il problema da sola. È stata necessaria una collaborazione senza precedenti tra scienziati di campi diversi, dimostrando che gli approcci riduzionistici sono insufficienti e che la “interdisciplinarietà non può, e non deve, più essere un pensiero illusorio, ma dovrebbe diventare il motore della risposta”.
- Il rapporto cruciale con la comunicazione: La pandemia ha evidenziato l’importanza vitale di una “comunicazione istituzionale e scientifica chiara e ben organizzata” per ridurre l’infodemia (la sovrabbondanza di informazioni, spesso false o fuorvianti) e per guidare le “risposte comportamentali impreviste” della popolazione.
In sintesi, la pandemia ha costretto la società a confrontarsi con la scienza non come un insieme di certezze assolute, ma come un processo dinamico, collaborativo e onesto sui propri limiti, che richiede trasparenza e dialogo.
Produzione
La Complessità della Conoscenza: Una Lezione dalla Pandemia
L’articolo di Manlio Di Domenico, distinguendo lucidamente tra “complicato” e “complesso”, offre una chiave di lettura indispensabile per affrontare le sfide della nostra epoca, dalla pandemia ai cambiamenti climatici, e per ripensare il rapporto tra conoscenza scientifica e realtà. La sua tesi centrale, che per i problemi complessi è necessaria una visione multidisciplinare che vada oltre l’approccio riduzionista, è un’affermazione che condivido profondamente. Le mie conoscenze e le mie esperienze personali, anche solo attraverso la fruizione di informazioni e il dibattito pubblico, confermano che l’incapacità di abbracciare la complessità è spesso la radice delle nostre difficoltà.
La distinzione tra “complicato” e “complesso” è, a mio avviso, la prima e più fondamentale lezione. Un motore d’aereo è complicato: le sue migliaia di pezzi interagiscono secondo regole precise e prevedibili; un ingegnere può smontarlo, ripararlo e rimontarlo. Ma un ecosistema, un cervello umano, o una pandemia, sono complessi. Le loro componenti (virus, cellule, individui, società, economie) interagiscono in modi non lineari, con effetti emergent che non sono la semplice somma delle parti. Se si modifica una variabile, le ripercussioni sull’intero sistema possono essere imprevedibili. Questa differenza è cruciale perché, come sottolinea Di Domenico, richiede approcci radicalmente diversi per la risoluzione dei problemi. Abbiamo una tendenza naturale a ridurre il complesso al complicato, cercando soluzioni semplici a problemi che invece richiedono una visione sistemica.
L’approccio riduzionista, che ha dominato gran parte della scienza moderna e ha portato a progressi straordinari in settori specifici, si rivela inadeguato di fronte alla complessità. Se un virologo comprende alla perfezione il meccanismo di replicazione di un virus a livello molecolare, non può, da solo, prevedere l’andamento di una pandemia a livello globale, che dipende da fattori sociali, economici, comportamentali, politici. L’affermazione di Philip Anderson, “More is different”, è qui illuminante: la biologia non è chimica applicata, e la sociologia non è biologia applicata. Ogni livello di organizzazione della realtà, dal subatomico al planetario, ha le sue proprietà emergenti e le sue leggi specifiche, che non possono essere semplicemente dedotte dal livello inferiore. Questa consapevolezza è fondamentale per evitare la “visione parziale” del puzzle di cui parla l’autore.
La pandemia di COVID-19 è stata una drammatica, ma istruttiva, dimostrazione di questa complessità. Inizialmente, la risposta è stata prevalentemente medica e virologica: si è cercato di capire il virus, di sviluppare vaccini e terapie. Ma presto è diventato evidente che la gestione della pandemia richiedeva l’intervento di epidemiologi (per i modelli di diffusione), sociologi (per comprendere i comportamenti e le reazioni della popolazione), psicologi (per la salute mentale), economisti (per l’impatto sul lavoro e le imprese), esperti di comunicazione (per contrastare l’infodemia). La pandemia ha dimostrato che un problema di salute pubblica è, in realtà, un problema sociale, economico e politico, e che una risposta efficace necessita di una “continua interazione” tra tutte queste discipline. Ho seguito, attraverso i media, i dibattiti tra scienziati di diverse estrazioni, e ho notato come la mancanza di una comunicazione integrata o di un dialogo interdisciplinare efficace potesse generare confusione e indecisione, rendendo più difficile la gestione della crisi.
Questo ci porta al punto cruciale: l’interdisciplinarietà non è più un lusso, ma una necessità impellente. Non basta la somma delle singole conoscenze; è necessaria la loro integrazione, la capacità di vedere il “disegno finale” del puzzle. Nel mio percorso di studi, ho spesso sentito parlare dell’importanza di connettere diverse materie, e l’articolo di Di Domenico rafforza questa idea: la conoscenza non deve essere frammentata in compartimenti stagni, ma deve essere vista come una rete interconnessa. Le “domande e i dubbi” che caratterizzano il dibattito scientifico devono essere condivisi e affrontati da molteplici prospettive.
Infine, il ruolo di una comunicazione scientifica e istituzionale chiara e ben organizzata è determinante. In un’epoca di sovraccarico informativo e di proliferazione di notizie false, la capacità di trasmettere informazioni complesse in modo comprensibile e affidabile è cruciale per la risposta comportamentale della popolazione. La pandemia ha messo in luce i pericoli dell’infodemia, dove la confusione e la sfiducia possono minare l’efficacia delle misure di contenimento.
In conclusione, l’articolo di Manlio Di Domenico ci offre un’analisi preziosa che va oltre la pandemia, delineando un nuovo paradigma per la conoscenza e la risoluzione dei problemi. La consapevolezza della complessità dei sistemi in cui viviamo, l’abbandono degli approcci riduzionistici a favore della multidisciplinarietà e dell’interdisciplinarietà, e la promozione di una comunicazione scientifica trasparente, sono le chiavi per affrontare le sfide del futuro. Solo abbracciando la complessità e coltivando un dialogo tra i saperi potremo costruire una conoscenza più completa e trovare soluzioni efficaci ai problemi che ci attendono.

Audio Lezioni, ascolta il podcast di Storia moderna e contemporanea del prof. Gaudio
Ascolta “Storia moderna e contemporanea” su Spreaker.




