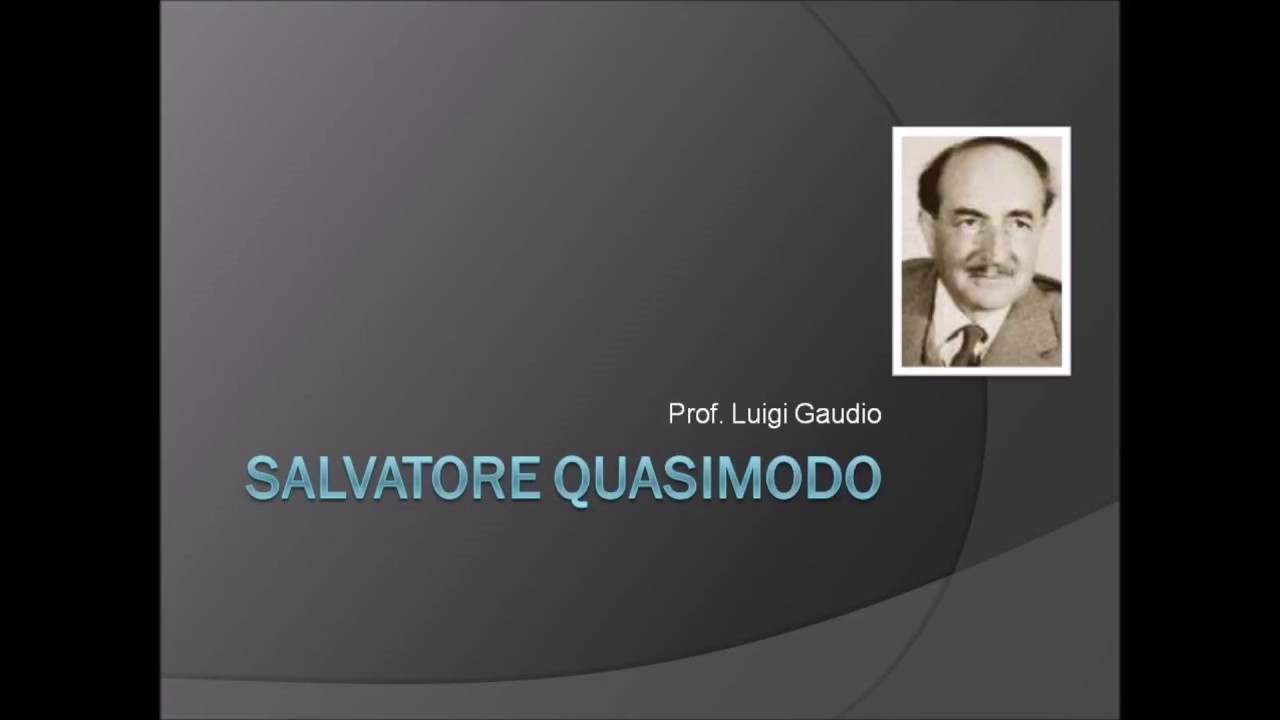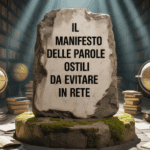
Il Manifesto delle parole ostili da evitare in rete
11 Giugno 2025
L’ipocrisia della borghesia romana da Gli Indifferenti di Alberto Moravia
11 Giugno 2025Traccia e svolgimento di una Analisi del testo della poesia “Alla nuova luna” di Salvatore Quasimodo
TRACCIA
SESSIONE ORDINARIA 2023 – PRIMA PROVA SCRITTA – Ministero dell’istruzione e del merito
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
PROVA DI ITALIANO
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
PROPOSTA A1
Salvatore Quasimodo, Alla nuova luna, in Tutte le poesie, a cura di Gilberto Finzi, Mondadori, Milano, 1995.
TESTO
In principio Dio creò il cielo e la terra,
poi nel suo giorno esatto
mise i luminari in cielo
e al settimo giorno si riposò.
Dopo miliardi di anni l’uomo,
fatto a sua immagine e somiglianza,
senza mai riposare, con la sua intelligenza laica,
senza timore, nel cielo sereno d’una notte d’ottobre,
mise altri luminari
uguali a quelli che giravano dalla creazione del mondo.
Amen.
CONTESTO
Alla nuova luna fa parte della raccolta La terra impareggiabile, pubblicata nel 1958, che testimonia l’attenzione di Quasimodo (1901 – 1968) per il mondo a lui contemporaneo e la sua riflessione sul progresso scientifico e sulla responsabilità degli scienziati in un’epoca di importanti innovazioni tecnologiche. La poesia è ispirata al lancio in orbita del primo satellite artificiale Sputnik I, avvenuto nel 1957.
COMPRENSIONE E ANALISI
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande proposte.
- Presenta il contenuto della poesia e descrivine sinteticamente la struttura metrica.
- Le due strofe individuano i due tempi del discorso poetico che presenta uno sviluppo narrativo sottolineato dalla ripresa di concetti e vocaboli chiave. Individua le parole che vengono ripetute in entrambe le parti del componimento e illustra il significato di questa ripetizione.
- L’azione dell’uomo ‘creatore’ viene caratterizzata da due notazioni che ne affermano la perseveranza e il coraggio; individualle e commentane il significato.
- Al verso 8 Quasimodo isola l’espressione ‘intelligenza laica’: quale rapporto istituisce, a tuo avviso, questa espressione tra la creazione divina e la scienza?
- A conclusione del componimento il poeta utilizza un vocabolo che conferisce al testo un andamento quasi liturgico; commenta questa scelta espressiva.
INTERPRETAZIONE
Facendo riferimento alla produzione poetica di Quasimodo e/o ad altri autori o forme d’arte a te noti, elabora una tua riflessione sulle modalità con cui la letteratura e/o altre arti affrontano i temi del progresso scientifico-tecnologico e delle responsabilità della scienza nella costruzione del futuro dell’umanità.

SVOLGIMENTO
Analisi di ‘Alla nuova luna’ di Salvatore Quasimodo
La poesia “Alla nuova luna” di Salvatore Quasimodo, appartenente alla raccolta La terra impareggiabile (1958), è un componimento emblematico della sua riflessione sul progresso scientifico e sulle implicazioni etiche della responsabilità umana in un’epoca di profonde innovazioni tecnologiche. Ispirata al lancio del primo satellite artificiale, lo Sputnik I nel 1957, la lirica si confronta con il racconto biblico della Creazione, elevando l’azione umana a una dimensione quasi divina, ma con un’inquietante ambiguità finale.
Comprensione e Analisi
1. Presenta il contenuto della poesia e descrivine sinteticamente la struttura metrica.
La poesia di Quasimodo è divisa in due strofe che mettono a confronto due atti di creazione: quello divino e quello umano. La prima strofa riprende in sintesi il racconto della Genesi: Dio crea il cielo e la terra, poi, nel suo giorno stabilito, vi colloca i luminari (astri) e infine si riposa il settimo giorno. La seconda strofa introduce l’azione dell’uomo, che, miliardi di anni dopo, fatto a immagine e somiglianza di Dio, ma senza mai riposare e con “intelligenza laica”, colloca nel cielo altri luminari, simili a quelli già esistenti, in una serena notte d’ottobre. La poesia si conclude con la parola “Amen”, che suggella questa ardita equiparazione.
La poesia è composta da due strofe di sette versi ciascuna. Non presenta uno schema di rime tradizionale, avvicinandosi al modello dei versi liberi o sciolti, che conferiscono alla narrazione un andamento quasi prosastico, ma con una cadenza solenne. I versi sono di varia lunghezza, prevalentemente endecasillabi e settenari, alternati a versi più brevi.
2. Le due strofe individuano i due tempi del discorso poetico che presenta uno sviluppo narrativo sottolineato dalla ripresa di concetti e vocaboli chiave. Individua le parole che vengono ripetute in entrambe le parti del componimento e illustra il significato di questa ripetizione.
Le parole e i concetti chiave che vengono ripetuti in entrambe le strofe, creando un parallelismo e sottolineando lo sviluppo narrativo, sono:
- “Dio” / “l’uomo, fatto a sua immagine e somiglianza”: Nella prima strofa si introduce il soggetto della creazione divina (“Dio”). Nella seconda, l’uomo è posto come soggetto della nuova creazione, ma con l’esplicita parentesi “fatto a sua immagine e somiglianza”. Questa ripresa sottolinea l’eredità divina nell’azione umana, ma anche l’autonomia e la quasi divinità raggiunta dall’uomo.
- “creò” / “mise”: Il verbo “creò” (v. 1) è associato all’azione divina, mentre il verbo “mise” (vv. 3 e 11) è utilizzato sia per Dio che per l’uomo. La ripetizione di “mise” implica una sorta di equivalenza, o almeno di parallelismo funzionale, tra l’atto divino di collocare gli astri e l’atto umano di lanciare i satelliti. L’uomo non “crea” dal nulla, ma “colloca”, imitando l’azione divina.
- “il cielo”: Presente sia nella prima strofa (v. 1 e v. 3) in riferimento alla creazione divina, sia nella seconda (v. 10) in riferimento all’azione umana. Il cielo è il teatro di entrambe le creazioni, l’ambito in cui si manifesta la potenza creatrice.
- “luminari”: È il termine chiave che definisce gli oggetti creati/collocati. Appare nella prima strofa (“mise i luminari in cielo”, v. 3) e nella seconda (“mise altri luminari uguali”, v. 11). La precisazione “uguali / a quelli che giravano / dalla creazione del mondo” (vv. 11-13) enfatizza la capacità dell’uomo di replicare, o di aggiungere, a quanto già fatto da Dio.
- “si riposò” (v. 4) / “senza mai riposare” (v. 7): Questo è un contrasto significativo. Dio si riposa dopo la creazione, mentre l’uomo agisce “senza mai riposare”, sottolineando l’incessante e instancabile progresso della scienza e della tecnologia umana.
Il significato complessivo di queste ripetizioni è quello di istituire un parallelismo e una sottile competizione/imitazione tra l’azione creatrice divina e quella umana. L’uomo, grazie alla sua intelligenza, è arrivato a eguagliare, o quasi, l’atto divino, ponendo i propri oggetti nell’universo. Allo stesso tempo, la ripetizione di termini chiave suggerisce una continuità nella storia della creazione, una sorta di seconda Genesi ad opera dell’uomo.
3. L’azione dell’uomo ‘creatore’ viene caratterizzata da due notazioni che ne affermano la perseveranza e il coraggio; individuale e commentane il significato.
L’azione dell’uomo “creatore” è caratterizzata da due notazioni che ne affermano la perseveranza e il coraggio:
-
“senza mai riposare” (v. 7): Questa espressione contrasta direttamente con il “al settimo giorno si riposò” (v. 4) di Dio. Il suo significato è quello di una perseveranza incessante e instancabile. L’uomo moderno, attraverso la scienza e la tecnologia, è spinto da una curiosità e una sete di conoscenza e progresso che non conoscono sosta. Non c’è un “settimo giorno” per la ricerca scientifica; il lavoro è continuo, un processo senza fine di scoperta e innovazione. È il simbolo dell’insaziabile attività intellettuale e tecnologica umana.
-
“senza timore” (v. 9): Questa notazione sottolinea il coraggio e l’audacia dell’uomo nel compiere un’azione che, in altre epoche, sarebbe stata considerata blasfema o presuntuosa: alterare il cielo creato da Dio. L’uomo non si ferma di fronte a confini metafisici o a timori reverenziali verso la creazione divina. La sua “intelligenza laica” gli conferisce la libertà di esplorare e intervenire nell’universo senza preconcetti o paure tradizionali. È il simbolo della fiducia dell’uomo nella propria ragione e capacità di superare limiti un tempo invalicabili.
Insieme, queste due notazioni dipingono un’immagine dell’uomo moderno come un Prometeo instancabile e coraggioso, che osa sfidare i confini del noto e del sacro per affermare la propria capacità creatrice.
4. Al verso 8 Quasimodo isola l’espressione ‘intelligenza laica’: quale rapporto istituisce, a tuo avviso, questa espressione tra la creazione divina e la scienza?
L’espressione “intelligenza laica” (v. 8) isolata da Quasimodo è un punto cruciale per comprendere il rapporto che istituisce tra la creazione divina e la scienza. A mio avviso, essa suggerisce:
- Autonomia della ragione umana dalla sfera religiosa: “Laica” si contrappone implicitamente a una visione teologica o religiosa della conoscenza e della creazione. L’intelligenza umana, nel suo procedere scientifico, non si basa su dogmi, rivelazioni o fede, ma sulla ragione, sull’osservazione, sull’esperimento. È un’intelligenza che opera in un orizzonte terreno, immanente, senza necessariamente riferirsi a un principio trascendente.
- Indipendenza della scienza dalla teologia: La scienza ha sviluppato propri metodi e proprie finalità, separandosi dalla teologia come fonte di conoscenza primaria. L’uomo, con questa “intelligenza laica”, esplora l’universo senza bisogno di giustificazioni o benedizioni divine, ma con la propria audacia intellettuale.
- Non necessariamente ateismo, ma pragmatismo operativo: “Laica” non significa necessariamente atea in senso militante, ma piuttosto pragmaticamente non-religiosa nell’agire scientifico. L’uomo non chiede permesso a Dio per lanciare satelliti; semplicemente agisce in base alle sue capacità razionali e tecnologiche. È un’intelligenza che si muove nel mondo fisico per conoscerlo e modificarlo.
- Una nuova forma di “creazione” umana: L’intelligenza laica consente all’uomo di compiere atti che, per la loro portata, richiamano la creazione divina. Questo, in Quasimodo, non è necessariamente un atto di ribellione, quanto una constatazione della potenza raggiunta dall’uomo. L’uomo replica (o aggiunge a) la creazione divina, ma lo fa con strumenti e prospettive radicalmente diversi, propri della modernità scientifica e tecnologica.
In sostanza, “intelligenza laica” istituisce un rapporto di parallelismo funzionale ma di distinzione metodologica e concettuale tra le due creazioni. L’uomo crea (o ricrea) nel cielo, come Dio, ma lo fa con una ragione e una metodologia autonome, sganciate da qualsiasi riferimento trascendente.
5. A conclusione del componimento il poeta utilizza un vocabolo che conferisce al testo un andamento quasi liturgico; commenta questa scelta espressiva.
A conclusione del componimento, il poeta utilizza il vocabolo “Amen.” (v. 14). Questa scelta espressiva conferisce al testo un andamento quasi liturgico o rituale, con un significato che si presta a diverse interpretazioni:
- Rinvio alla tradizione biblica/religiosa: “Amen” è una parola ebraica (poi adottata nel cristianesimo) che significa “così sia”, “in verità”, “è vero”. Conclude preghiere, letture bibliche o affermazioni di fede, suggellandole con un’approvazione solenne. La sua ripresa finale qui richiama esplicitamente il tono e il contesto del racconto della Genesi con cui la poesia è iniziata.
- Chiusura solenne e definitiva: L’uso di “Amen” sigilla la narrazione, conferendole un tono di completezza e definitività, come se l’atto dell’uomo di mettere “altri luminari” fosse l’ultimo capitolo di una nuova Genesi.
- Ambiguità interpretativa: L’ambiguità è il tratto distintivo di questa scelta. Potrebbe essere letto come:
- Un’approvazione ironica o sarcastica: Forse l’uomo, nel suo delirio di onnipotenza scientifica, ha raggiunto una parodia della creazione divina, e l'”Amen” suona come un commento amaro e scettico sulla sua presunta grandezza.
- Un’affermazione di meraviglia e accettazione: Nonostante le implicazioni etiche e le incognite del progresso, c’è un’accettazione della realtà di questa nuova creazione umana e del suo impatto.
- Un’invocazione/maledizione: L’eco liturgica potrebbe anche suggerire una preghiera o un monito di fronte alla potenza scatenata, quasi una richiesta di benevolenza o una consapevolezza del rischio.
- Un limite autoimposto: Pur avendo raggiunto una potenza divina, l’uomo non può fare a meno di confrontarsi con il sacro, e in questo “Amen” c’è forse il riconoscimento di un limite, di una dimensione che trascende la sua stessa intelligenza laica.
In definitiva, la scelta di “Amen” chiude la poesia con un’apertura al senso del mistero e a un’inquietudine etica, tipica della riflessione di Quasimodo sul progresso. Non è una semplice conclusione, ma un interrogativo finale sulla direzione e sul significato ultimo dell’agire umano.
Interpretazione
“Alla nuova luna” di Salvatore Quasimodo è una poesia di straordinaria densità, capace di condensare in pochi versi la complessa e spesso ambivalente relazione tra l’uomo, la scienza e la trascendenza nell’epoca contemporanea. Il lancio dello Sputnik I, evento epocale del 1957, diventa per il poeta non solo un fatto di cronaca, ma uno spunto per una riflessione di carattere quasi teologico-filosofico, in cui la Genesi biblica si confronta con la “genesi” tecnologica operata dall’uomo.
La poesia di Quasimodo, soprattutto nella fase successiva al Nobel, mostra una crescente attenzione per il “mondo a lui contemporaneo” e per il progresso scientifico-tecnologico. Questa lirica è un chiaro esempio di come il poeta si allontani dalle tematiche ermetiche e della “parola pura” per confrontarsi con la realtà storica e le sue implicazioni etiche. Se in passato Quasimodo era il cantore di una condizione umana più isolata, qui l’uomo è agente della storia, dotato di un’intelligenza capace di modificare il cosmo. L’uomo, “fatto a immagine e somiglianza” di Dio, dimostra una potenza quasi divina, mettendo “altri luminari” nel cielo, simili a quelli creati originariamente. Questa equivalenza tra creatore divino e creatore umano è audace e provocatoria.
Tuttavia, l’approccio di Quasimodo non è una celebrazione acritica del progresso. L’espressione “intelligenza laica” è rivelatrice: essa sottolinea l’autonomia della ragione umana da ogni dogma religioso, ma può celare anche una potenziale hybris. L’uomo agisce “senza timore” e “senza mai riposare”, mosso da un’insaziabile spinta al sapere e al fare. Questo, se da un lato è segno di coraggio e perseveranza, dall’altro può essere un campanello d’allarme sulla responsabilità etica. La scienza, nel suo procedere “laico”, si assume una responsabilità enorme nel manipolare e modificare la realtà, con conseguenze che non sempre sono pienamente prevedibili.
Il finale enigmatico con la parola “Amen” è la chiave interpretativa più potente. Essa non è una semplice chiusura, ma un interrogativo aperto. Potrebbe essere un “così sia” di accettazione e meraviglia di fronte alla potenza umana, ma anche un “così sia” con un’ombra di inquietudine, quasi un monito. Quasimodo, infatti, non era indifferente alle derive del progresso, soprattutto dopo le esperienze delle guerre mondiali e l’uso dell’energia atomica. L’uomo, nel mettere le sue “lune” nel cielo, deve essere consapevole delle implicazioni morali del suo agire. L'”Amen” potrebbe quindi suggerire un’invocazione, una preghiera affinché questa nuova creazione non porti a conseguenze nefaste.
Confrontando questa lirica con altri autori o forme d’arte, il tema del progresso scientifico e delle sue responsabilità è stato ampiamente esplorato. Si pensi, in letteratura, al Prometeo di Mary Shelley, che, attraverso la figura di Frankenstein, esplora i pericoli di una scienza che non si pone limiti etici e crea un mostro che sfugge al suo controllo. O, più avanti nel Novecento, la distopia di Aldous Huxley in Brave New World, dove il progresso tecnologico e scientifico è piegato al controllo sociale e all’annientamento dell’individualità, ponendo domande sulle responsabilità degli scienziati nel modellare il futuro dell’umanità.
In campo artistico, la fantascienza cinematografica, in particolare, ha spesso affrontato questi temi, mostrando scenari utopici o distopici legati all’avanzamento tecnologico. Film come 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick esplorano l’evoluzione umana e il ruolo della tecnologia, con un’ambiguità sul destino finale dell’uomo. Le figure di scienziati “geniali” ma “irresponsabili” sono un topos ricorrente, che ci spinge a riflettere sul fatto che la scienza, pur portando conoscenza, non può essere esente da un profondo senso etico.
In definitiva, “Alla nuova luna” è una poesia che, pur celebrando la potenza intellettuale dell’uomo, lo interroga sulla direzione del suo progresso. L’atto di lanciare satelliti, pur imitando l’atto divino, porta con sé un peso di responsabilità. Quasimodo, da umanista, ci ricorda che la scienza, se non guidata da un’etica profonda e da una consapevolezza del “comune destino” dell’umanità (come suggerirebbe Ferrajoli), rischia di diventare uno strumento di potere cieco, invece che di liberazione e benessere. L'”Amen” finale è un monito: la creazione dell’uomo, come quella divina, è un atto potente, ma il suo esito dipende dalle scelte etiche che l’umanità farà.