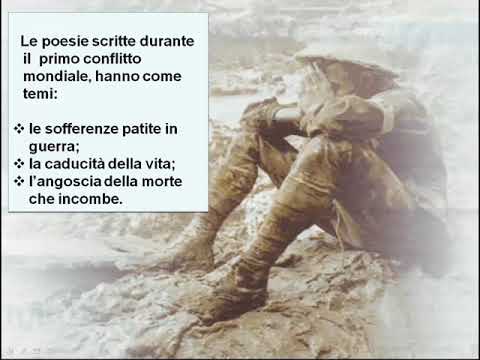Africa: Geografia Fisica, Storia, Territorio e Climi
28 Dicembre 2019
La Spagna: lezione di geografia
28 Dicembre 2019“Allegria di naufragi”, “Peso”, “Dannazione” e “Preghiera” sono poesie che appartengono alla raccolta “L’Allegria” di Giuseppe Ungaretti, e riflettono le sue esperienze durante la Prima Guerra Mondiale e i suoi sentimenti contrastanti di fronte alla morte e alla sopravvivenza.

ora il testo e l’analisi di ciascuna di queste quattro poesie:
1) Allegria di naufragi: testo
Allegria di naufragi di Giuseppe Ungaretti
E subito riprende
il viaggio
come
dopo il naufragio
un superstite 5
lupo di mare.da “L’Allegria” di Giuseppe Ungaretti
Giuseppe Ungaretti – Allegria di naufragi: Analisi della Poesia
“Allegria di naufragi” è una delle poesie più celebri e significative di Giuseppe Ungaretti (1888-1970), inclusa nella sua raccolta L’Allegria (1919, poi L’Allegria dei naufragi, infine L’Allegria). Questa lirica, brevissima e densa, condensa la poetica dell’autore, nata dall’esperienza della Prima Guerra Mondiale, e ne esprime i temi fondamentali: la fragilità della vita, la resilienza umana e la scoperta di un’inaspettata vitalità dopo la distruzione.
Analisi
La poesia è composta da sei versi liberi, distribuiti in un’unica strofa, con una sintassi essenziale e priva di punteggiatura (tranne il punto finale, che in alcune edizioni è omesso, lasciando una sospensione).
- “E subito riprende / il viaggio” (vv. 1-2): La poesia si apre con una congiunzione (“E”) che suggerisce una continuità, un’immediata ripresa dopo un evento precedente non specificato, ma intuibile dal titolo. Il “subito” enfatizza la prontezza, la reattività. Il “viaggio” è una metafora della vita stessa, del suo percorso ininterrotto. Nonostante le difficoltà, la vita (il viaggio) riprende con una forza quasi istintiva.
- “come / dopo il naufragio” (vv. 3-4): Qui Ungaretti introduce un paragone esplicito, un’analogia che chiarisce il contesto emotivo e esistenziale. Il “naufragio” è la metafora centrale della poesia. Può riferirsi all’esperienza della guerra, che distrugge certezze e vite, ma anche, più in generale, alle crisi esistenziali, alle perdite, ai momenti di distruzione personale. È un’immagine di totale annientamento, di perdita di ogni appiglio.
- “un superstite / lupo di mare.” (vv. 5-6): Il paragone si completa con la figura del “superstite / lupo di mare”. Il “superstite” è colui che è scampato alla distruzione, che ha attraversato il naufragio ed è sopravvissuto. Il “lupo di mare” è una figura archetipica di marinaio esperto, abituato alle tempeste, resiliente e indomito. Questa figura incarna la capacità umana di resistere, di non arrendersi di fronte alle avversità più estreme. Nonostante il naufragio, la sua natura profonda (il “lupo di mare”) gli permette di riprendere il suo cammino.
Temi Principali
- La Fragilità dell’Esistenza e la Distruzione: Il “naufragio” è il simbolo della precarietà della vita, della sua esposizione alla distruzione e alla morte. L’esperienza della guerra, con la sua violenza e le sue perdite, è il contesto primario di questa consapevolezza.
- La Resilienza e la Forza Vitale: Nonostante la distruzione, la vita ha una forza intrinseca che la spinge a “riprendere il viaggio”. Il “superstite lupo di mare” rappresenta la capacità umana di adattarsi, di resistere e di trovare nuove ragioni per continuare, anche dopo aver toccato il fondo.
- L’Allegria del Naufragio (Ossimoro): Il titolo stesso è un ossimoro (“Allegria di naufragi”). Questa giustapposizione di termini opposti è centrale nella poetica ungarettiana. L’allegria non è gioia spensierata, ma una consapevolezza profonda e quasi dolorosa della vita che, nonostante la distruzione e la morte (il naufragio), continua a pulsare. È la gioia di essere sopravvissuti, la gratitudine per l’esistenza stessa, una forma di vitalità che emerge proprio dalla consapevolezza della caducità. È un’allegria che nasce non nonostante il naufragio, ma dal naufragio, come un’epifania della vita.
- La Solitudine e la Nudità dell’Essere: Il “superstite” è solo, spogliato di tutto, ridotto all’essenziale. Questa condizione di nudità esistenziale, tipica della poesia di Ungaretti, permette di cogliere la verità più profonda della vita.
- Il Viaggio come Metafora della Vita: Il “viaggio” è il simbolo del percorso esistenziale, che deve essere ripreso nonostante le interruzioni e le difficoltà.
Stile e Linguaggio
La poesia è un esempio paradigmatico della poetica ungarettiana, caratterizzata da:
- Versi Liberi e Brevità: La frammentazione del verso e la brevità del componimento riflettono l’esperienza del trauma e la necessità di esprimere l’essenziale con la massima concisione. Ogni parola è caricata di significato.
- Assenza di Punteggiatura (o minima): La mancanza di punteggiatura crea un flusso continuo di pensiero, un’immediatezza emotiva e un’ambiguità che permette molteplici interpretazioni.
- Analogia e Metafora: Il paragone (“come”) e le metafore (“viaggio”, “naufragio”, “lupo di mare”) sono gli strumenti principali per veicolare il significato profondo.
- Parola “Scavata”: Ogni parola è scelta con cura e isolata per esaltarne il valore semantico e fonico, come se fosse “scavata” dal silenzio.
- Tono Essenziale e Meditativo: Nonostante la drammaticità del tema, il tono è asciutto, privo di retorica, invitando a una riflessione profonda sulla condizione umana.
Conclusione
“Allegria di naufragi” è una delle liriche più potenti e rappresentative di Giuseppe Ungaretti. Attraverso l’ossimoro del titolo e la metafora del “superstite lupo di mare”, il poeta esprime la sua visione della vita come un continuo “viaggio” segnato da “naufragi”, ma anche da un’inattesa e profonda “allegria” che nasce dalla consapevolezza di essere sopravvissuti. È un inno alla resilienza umana, alla forza vitale che emerge proprio dalla distruzione, e alla capacità di trovare un senso e una gratitudine per l’esistenza anche dopo aver affrontato il dolore più grande.

2) Peso: testo
Peso di Giuseppe Ungaretti
Quel contadino
si affida alla medaglia
di Sant’Antonio
e va leggero
Ma ben sola e ben nuda 5
senza miraggio
porto la mia anima
da “L’Allegria” di Giuseppe Ungaretti
Giuseppe Ungaretti – Peso: Analisi della Poesia
Questa breve lirica, caratteristica della poetica ungarettiana, presenta una struttura antitetica che contrappone due diverse modalità di esistenza attraverso un linguaggio essenziale e pregnante.
Struttura e movimento del testo
La poesia si articola in due momenti distinti: i primi quattro versi descrivono la condizione del contadino, mentre gli ultimi quattro quella del poeta. Il “Ma” iniziale del quinto verso marca una cesura netta, introducendo un contrasto che costituisce il nucleo semantico del componimento.
La figura del contadino
Il contadino rappresenta la dimensione della fede ingenua e popolare. La “medaglia di Sant’Antonio” simboleggia la religiosità tradizionale, concreta e materializzata negli oggetti devozionali. Questa fede gli permette di andare “leggero” attraverso l’esistenza, sostenuto dalla certezza di una protezione divina. La scelta lessicale di “si affida” sottolinea la dimensione della fiducia e dell’abbandono.
La condizione del poeta
In antitesi, il poeta presenta la propria anima come “ben sola e ben nuda”, privata di ogni sostegno esterno. L’iterazione dell’avverbio “ben” intensifica la radicalità di questa condizione esistenziale. L’assenza di “miraggi” indica il rifiuto di ogni illusione consolatoria, compresa quella religiosa tradizionale.
Il “peso” del titolo
Il titolo acquista significato proprio da questo contrasto: mentre il contadino è alleggerito dalla fede, il poeta porta il peso della lucidità, della consapevolezza disincantata. Paradossalmente, è proprio questa nudità spirituale a costituire il “peso” dell’esistenza moderna, priva di certezze metafisiche.
Linguaggio e stile
La poesia presenta le caratteristiche tipiche dell’Ungaretti maturo: versi brevi, parole isolate che acquistano pregnanza semantica, assenza di punteggiatura che crea un ritmo sospeso. La semplicità apparente del linguaggio nasconde una complessità semantica notevole, tipica della tecnica della “parola scavata” ungarettiana.
Significato esistenziale
Il componimento riflette la condizione dell’intellettuale moderno, scisso tra l’nostalgia per certezze perdute (rappresentate dal contadino) e la necessità di una ricerca autentica, anche se dolorosa. La “nudità” dell’anima diventa così condizione necessaria per un’esperienza poetica e spirituale genuina, libera da false consolazioni.

3) Dannazione: testo
Dannazione di Giuseppe Ungaretti
Chiuso fra cose mortali
(anche il cielo stellato finirà)
Perchè bramo Dio? 3
da “L’Allegria” di Giuseppe Ungaretti
Giuseppe Ungaretti – Dannazione: Analisi della Poesia

4) Preghiera: testo
Preghiera di Giuseppe Ungaretti
Quando mi desterò
dal barbaglio della promiscuità
in una limpida e attonita sfera
Quando il mio peso mi sarà leggero
Il naufragio concedimi Signore 5
di quel giovane giorno al primo grido.
da “L’Allegria” di Giuseppe Ungaretti
Giuseppe Ungaretti – Preghiera: Analisi della Poesia
“Preghiera” è una poesia di Giuseppe Ungaretti (1888-1970), inclusa nella sua celebre raccolta L’Allegria (originariamente Il porto sepolto, poi L’Allegria di naufragi). Questa lirica, breve e intensa, è un esempio paradigmatico della poetica ungarettiana, caratterizzata dall’essenzialità del verso, dalla frammentazione e da una profonda ricerca spirituale e esistenziale.
Analisi Approfondita
La poesia si articola in versi liberi, brevi e densi di significato, che formano una sorta di invocazione o supplica. La struttura è divisa in due parti principali, con un “Quando” che introduce una condizione e un “concedimi Signore” che esprime la richiesta.
Parte I: Il Desiderio di Purificazione e Leggerezza (vv. 1-4)
- “Quando mi desterò / dal barbaglio della promiscuità” (vv. 1-2): La poesia si apre con un’invocazione a un momento futuro di risveglio (“Quando mi desterò”). Questo risveglio non è da un semplice sonno, ma da una condizione di “barbaglio della promiscuità”. Il “barbaglio” suggerisce una luce accecante, confusa, che impedisce una visione chiara, mentre la “promiscuità” indica un mescolarsi indistinto, un caos di esperienze, sensazioni, forse anche di contatti umani o di peccati. È un desiderio di liberazione da ciò che è impuro, confuso, disordinato nella vita.
- “in una limpida e attonita sfera” (v. 3): Il risveglio desiderato conduce a una condizione di purezza e meraviglia. La “sfera” è un simbolo di perfezione, completezza, armonia e purezza. Gli aggettivi “limpida” (chiara, trasparente) e “attonita” (piena di stupore, di meraviglia) descrivono uno stato di grazia, di chiarezza spirituale e di profonda contemplazione. È il desiderio di un’esistenza essenziale, priva di contaminazioni e piena di consapevolezza.
- “Quando il mio peso mi sarà leggero” (v. 4): Questo verso riprende il tema della liberazione. Il “peso” può riferirsi al fardello dell’esistenza, alle sofferenze, alle colpe, alle angosce che gravano sull’anima. Il desiderio è che questo peso si dissolva, che l’essere diventi “leggero”, in una condizione di libertà e di pace interiore.
Parte II: La Richiesta del “Naufragio” (vv. 5-6)
- “Il naufragio concedimi Signore” (v. 5): Questo è il cuore paradossale della poesia. Il “naufragio”, che nell’immaginario comune evoca distruzione, perdita e morte, viene qui richiesto come un dono, una grazia (“concedimi Signore”). È un ossimoro potente, tipico di Ungaretti (si pensi a “Allegria di naufragi”). Il naufragio non è la fine, ma il mezzo per una purificazione radicale, una spoliazione totale da tutto ciò che è superfluo e impuro. Solo attraverso questa distruzione catartica si può raggiungere la “limpida e attonita sfera”. È una richiesta di annientamento del vecchio sé per permettere la nascita di un nuovo sé.
- “di quel giovane giorno al primo grido.” (v. 6): Il naufragio desiderato deve condurre a un “giovane giorno”, un nuovo inizio, un’esistenza primordiale e pura. Il “primo grido” è una metafora della nascita, del momento in cui la vita emerge nella sua forma più autentica e innocente, libera dalle contaminazioni e dai “barbagli” della “promiscuità”. È un desiderio di ritorno a uno stato di purezza originaria, di innocenza primordiale.
Temi Principali
- Purificazione e Rinascita: La poesia è una preghiera per una radicale trasformazione dell’io, un processo di spoliazione e distruzione del superfluo che conduce a una nuova e autentica esistenza.
- La Ricerca Spirituale: L’invocazione al “Signore” e le immagini di purezza e leggerezza indicano una profonda dimensione religiosa e mistica. È una supplica per una grazia divina che permetta la liberazione e la rivelazione.
- Il Paradosso del “Naufragio”: Il naufragio, lungi dall’essere un evento negativo, è visto come una condizione necessaria per la vera vita. È attraverso la perdita totale che si può trovare l’essenziale e la vera “allegria”.
- Il Contrasto tra Caos e Ordine: La “promiscuità” e il “barbaglio” si contrappongono alla “limpida e attonita sfera”, esprimendo il desiderio di superare il disordine e la confusione per raggiungere chiarezza e armonia.
- La Leggerezza dell’Essere: Il tema del “peso” che diventa “leggero” sottolinea la liberazione dalle sofferenze e dalle preoccupazioni terrene.
Stile e Linguaggio
La poesia è un esempio emblematico dello stile ungarettiano, caratterizzato da:
- Versi Liberi e Brevità: I versi sono frammentati, spesso composti da una o poche parole, isolate nello spazio bianco. Questo conferisce a ogni termine un’intensità e un peso semantico notevoli.
- Essenzialità e Concentrazione: Il linguaggio è scarno, privo di ridondanze. Ogni parola è “scavata” e caricata di significato, contribuendo a un’estrema concisione espressiva.
- Assenza di Punteggiatura: La mancanza di punteggiatura (tranne il punto finale) crea un flusso continuo di pensiero e di respiro, un’immediatezza emotiva che permette al lettore di immergersi senza interruzioni nel flusso della coscienza del poeta.
- Analogia e Metafora: La poesia è costruita su metafore potenti (“barbaglio della promiscuità”, “limpida e attonita sfera”, “peso”, “naufragio”, “giovane giorno al primo grido”) che veicolano significati complessi.
- Ossimoro: L’ossimoro del “naufragio” come dono è centrale e rivela la visione paradossale dell’autore.
- Tono Meditativo e Implorante: Il tono è quello di una preghiera intima e profonda, che esprime un desiderio ardente di trasformazione spirituale.
Conclusione
“Preghiera” è una delle liriche più significative di Ungaretti, che condensa in pochi versi la sua profonda ricerca di un senso autentico dell’esistenza. Attraverso il paradosso del “naufragio” come via per la purificazione e la rinascita, il poeta esprime il desiderio di liberarsi dal caos e dal peso della vita per raggiungere uno stato di limpida purezza e leggerezza. È una supplica al divino per una radicale trasformazione, un’invocazione a un nuovo inizio, che emerge dalla distruzione per approdare a un’esistenza essenziale e piena di meraviglia.