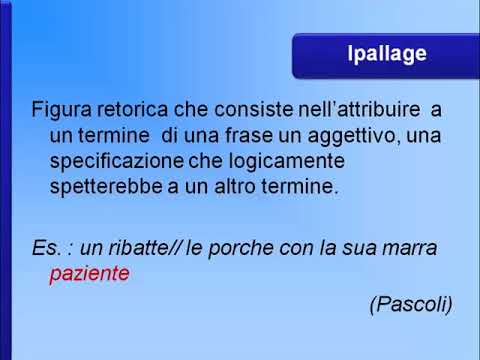Il commento di una poesia
28 Dicembre 2019
La maschera della morte rossa di Edgar Allan Poe
28 Dicembre 2019Nella poesia, il lessico (ovvero la scelta e l’insieme delle parole utilizzate dal poeta) e le figure semantiche (costruzioni retoriche che agiscono sul significato delle parole) sono due strumenti fondamentali e strettamente correlati per creare immagini potenti, esprimere concetti complessi e suscitare emozioni nel lettore.
Analizziamoli separatamente e poi vediamo come interagiscono.
1. Il Lessico nella Poesia
Il lessico poetico non è mai una scelta casuale di parole. Ogni termine viene selezionato con cura per il suo:
- Significato Denotativo: Il suo senso letterale, oggettivo.
- Significato Connotativo: Le associazioni, le suggestioni, le sfumature emotive o culturali che la parola evoca al di là del suo significato base. Ad esempio, la parola “madre” denota un genitore femminile, ma connota calore, protezione, affetto, sacrificio, ecc. Un poeta sfrutta enormemente queste connotazioni.
- Suono (Fonosemantica): Le parole vengono scelte anche per il loro suono, che può essere aspro, dolce, liquido, esplosivo, ecc., e contribuire all’atmosfera o al ritmo del verso.
- Specificità o Generalità: Il poeta può scegliere termini molto specifici e concreti (es. “assiolo”, “salmastro”) per dare precisione e tangibilità all’immagine, oppure termini più astratti o generici (“dolore”, “amore”, “tempo”) per esplorare concetti universali.
- Stratificazione Stilistica: Il lessico può attingere a diversi registri: arcaico, colloquiale, tecnico, aulico, regionale, ecc., per caratterizzare un personaggio, un ambiente o creare un particolare effetto stilistico.
- Originalità: Un lessico inatteso, accostamenti inediti di parole possono sorprendere il lettore e stimolare nuove interpretazioni.
La scelta del lessico contribuisce in modo essenziale a definire il tono della poesia (malinconico, ironico, solenne, aggressivo) e l’immaginario che essa costruisce.
2. Le Figure Semantiche
Le figure semantiche (o “figure di significato”) sono procedimenti retorici che modificano il significato letterale delle parole o delle espressioni, creando relazioni nuove o inattese tra i concetti. Sono il cuore della capacità evocativa della poesia. Le più comuni includono:
- Metafora: Sostituzione di un termine con un altro che ha con il primo un rapporto di somiglianza implicito, senza l’uso di avverbi di paragone (come “come”). È un paragone condensato.
- Esempio: “Sei un leone” (invece di: sei coraggioso come un leone).
- Similitudine: Paragone esplicito tra due termini o concetti, uniti da avverbi di paragone (“come”, “simile a”, “pare”, “quale”, “tale quale”).
- Esempio: “Sei forte come un leone”.
- Analogia: Un accostamento ancora più audace e meno logico della metafora, che mette in relazione concetti o immagini apparentemente molto distanti, basandosi su suggestioni o libere associazioni. Tipica, ad esempio, dell’Ermetismo (come visto con Ungaretti).
- Esempio (Ungaretti): “M’illumino d’immenso” (accostamento di uno stato d’animo momentaneo a una vastità cosmica).
- Sinestesia: Associazione di sensazioni percepite con organi di senso diversi.
- Esempio: “suono blu”, “silenzio verde”, “odore freddo”.
- Metonimia: Sostituzione di un termine con un altro che gli è legato da un rapporto logico o materiale (la causa per l’effetto, il contenitore per il contenuto, la materia per l’oggetto, l’autore per l’opera, il luogo per chi ci vive/lavora).
- Esempio: “Leggere Dante” (l’autore per l’opera), “bere un bicchiere” (il contenitore per il contenuto), “guadagnarsi il pane” (la parte per il tutto del nutrimento, anche se questa è anche Sineddoche).
- Sineddoche: Variante della metonimia, dove il rapporto è di tipo quantitativo (la parte per il tutto, il tutto per la parte, il singolare per il plurale, il genere per la specie).
- Esempio: “Vele” per “navi” (la parte per il tutto), “mortali” per “uomini” (la specie per il genere).
- Antitesi: Accostamento di due parole o concetti di significato opposto o molto contrastante all’interno della stessa frase o verso.
- Esempio: “pace non trovo e non ho da far guerra” (Petrarca).
- Ossimoro: Accostamento di due termini di significato apertamente contraddittorio, che genera un contrasto stridente ma ricco di suggestioni.
- Esempio: “lucido delirio”, “silenzio assordante”, “morte viva”.
- Personificazione (o Prosopopea): Attribuire qualità umane (azioni, sentimenti, pensieri) a oggetti inanimati, animali o concetti astratti.
- Esempio: “il vento ulula”, “la fortuna è cieca”.
- Iperbole: Esagerazione voluta per eccesso o per difetto, a fine espressivo.
- Esempio: “un mare di lacrime”, “veloce come il lampo”.
- Litote: Affermare un concetto negando il suo contrario, spesso per attenuare o ironizzare.
- Esempio: “don Abbondio non era nato con un cuor di leone” (anziché dire: era un uomo pauroso).
- Ironia: Affermare qualcosa intendendo in realtà l’opposto, spesso con intento critico o umoristico.
3. Interazione tra Lessico e Figure Semantiche
Lessico e figure semantiche lavorano mano nella mano. Il poeta seleziona attentamente le parole (lessico) e poi le organizza, le accosta o le sostituisce secondo le logiche delle figure semantiche.
- Un lessico ricco e ricercato può rendere le figure semantiche più originali e complesse.
- Un lessico semplice e quotidiano, usato in figure inattese, può creare effetti di spaesamento o rivelare la poesia nascosta nella realtà comune.
- Le figure semantiche a loro volta arricchiscono il lessico, caricando le parole di nuovi significati, risonanze e legami che vanno oltre la loro definizione letterale.
In sintesi, il poeta è un “artigiano” della parola che sceglie con precisione il suo materiale (il lessico) e poi lo plasma, lo trasforma e lo combina attraverso le figure semantiche per costruire il mondo di significati, immagini ed emozioni che è proprio della poesia. La maestria sta proprio nella capacità di far dialogare questi due livelli per creare un linguaggio denso, evocativo e pluristratificato.