
La Costituzione e l’ambiente: una nuova visione per il futuro
9 Giugno 2025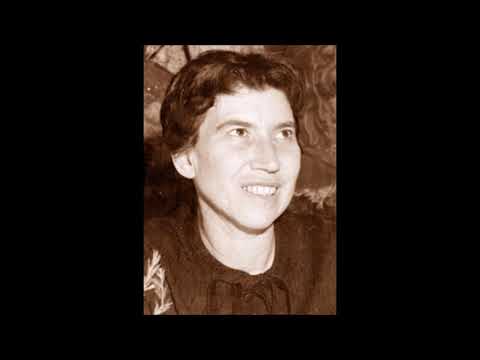
Analisi di ‘Le piccole virtù’ di Natalia Ginzburg
10 Giugno 2025Traccia e svolgimento di una Analisi del testo della poesia “Goal” di Umberto Saba, che testimonia la sua passione sportiva e umana
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – PROVA DI ITALIANO
Sessione straordinaria 2022 – Prima prova scritta
Ministero dell’Istruzione
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
PROPOSTA A1
Umberto Saba, Goal, in Il Canzoniere (1900-1954), Giulio Einaudi, Torino, 2004.
Il testo
Il portiere caduto alla difesa
ultima vana, contro terra cela
la faccia, a non veder l’amara
luce. Il compagno in ginocchio che l’induce,
con parole e con mano, a rilevarsi,
scopre pieni di lacrime i suoi occhi.
La folla – unita ebbrezza – par trabocchi
nel campo. Intorno al vincitore stanno,
al suo collo si gettano i fratelli.
Pochi momenti come questo belli,
a quanti l’odio consuma e l’amore,
è dato, sotto il cielo, di vedere.
Presso la rete inviolata il portiere
– l’altro – è rimasto. Ma non la sua anima,
con la persona vi è rimasta sola.
La sua gioia si fa una capriola,
si fa baci che manda di lontano.
Della festa – egli dice – anch’io son parte.
Umberto Saba, Goal, in Il Canzoniere (1900-1954), Giulio Einaudi, Torino, 2004
Nota informativa
Goal è stata composta nel 1933, anno immediatamente precedente i campionati mondiali di calcio che la nazionale italiana si aggiudicò dopo aver sconfitto la squadra cecoslovacca nella finale. Questo componimento conclude il gruppo Cinque poesie per il gioco del calcio, dedicate a questo sport da Saba, gran tifoso della Triestina.
Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande proposte.
- Presenta sinteticamente il contenuto della poesia.
- Analizza la struttura metrica, la scelta delle parole e le figure retoriche.
- Nella poesia sono evidenziati gli atteggiamenti e le reazioni dei due portieri: in che modo Saba li mette in rilievo?
- Come si manifesta l’esultanza della squadra vincitrice per la rete? E perché i suoi calciatori sono definiti fratelli?
- Quale significato, a tuo avviso, si può attribuire al verso conclusivo della poesia?
Interpretazione
Partendo dalla poesia proposta, nella quale viene descritto un momento specifico di una partita di calcio, elabora una tua riflessione sui sentimenti e sugli stati d’animo – individuali e collettivi – provocati da eventi sportivi. Puoi approfondire l’argomento tramite confronti con altri componimenti di Saba e con aspetti significativi della sua poetica o far riferimento a testi di altri autori a te noti nell’ambito letterario e/o artistico.

SVOLGIMENTO
Analisi di ‘Goal’ di Umberto Saba
“Goal”, poesia inclusa nella raccolta Il Canzoniere (1900-1954) di Umberto Saba, è un componimento emblematico della sua poetica del “vero” e dell’onestà. Dedicata al gioco del calcio, di cui Saba era grande appassionato, la lirica condensa in pochi versi l’universo di sentimenti e reazioni umane, individuali e collettive, che si scatenano in un momento culminante di una partita: il gol.
Comprensione e Analisi
1. Presenta sinteticamente il contenuto della poesia.
La poesia si apre con la descrizione del portiere della squadra sconfitta, che, dopo aver subito il gol (“caduto alla difesa / ultima vana”), nasconde la faccia contro il terreno per non vedere l’amara luce della sconfitta. Un suo compagno si inginocchia accanto a lui, tentando di consolarlo con parole e gesti, scoprendo i suoi occhi pieni di lacrime. Contestualmente, la scena si sposta sul campo in festa: la folla, presa da un’ebbrezza condivisa, sembra traboccare sul terreno di gioco. Attorno al calciatore che ha segnato il gol, i suoi compagni di squadra si stringono in un abbraccio fraterno. Il poeta riflette sulla rarità di momenti così belli, capaci di superare l’odio e l’amore che consumano gli uomini. Infine, l’attenzione si sposta sull’altro portiere, quello della squadra vincitrice, che è rimasto solitario presso la sua rete inviolata. La sua gioia, pur non manifestandosi con la stessa esuberanza collettiva, si esprime in un intimo, quasi fanciullesco, gesto di giubilo (“si fa una capriola”, “si fa baci che manda di lontano”), affermando con consapevolezza la sua parte nella festa.
2. Analizza la struttura metrica, la scelta delle parole e le figure retoriche.
La poesia è composta da diciotto versi endecasillabi, organizzati in strofe di lunghezza variabile, senza uno schema di rime fisso e regolare (si avvicina al metro dei versi sciolti). Sebbene non vi sia una rima tradizionale costante, la musicalità è creata da assonanze (“cela / luce / induce”) e consonanze (“occhi / trabocchi / pochi”). L’uso dell’endecasillabo, verso della grande tradizione lirica, conferisce alla poesia una certa solennità e fluidità, nonostante la semplicità del tema trattato.
La scelta delle parole è improntata a una voluta semplicità e chiarezza, tipica della “poesia onesta” di Saba. Il lessico è quotidiano, immediato, privo di preziosismi retorici, eppure profondamente evocativo. Termini come “amara luce”, “compagno”, “folla”, “fratelli”, “baci”, contribuiscono a creare un’immagine realistica e umana della scena.
Numerose sono le figure retoriche:
- Personificazione: Il portiere sconfitto “cela / la faccia, a non veder l’amara luce” (vv. 2-3), conferendogli quasi una volontà autonoma di sfuggire alla sofferenza. La gioia del portiere vincente “si fa una capriola, / si fa baci” (vv. 16-17), attribuendole una corporeità e un’azione.
- Metafora/Sineddoche: “unita ebbrezza” (v. 7) riferito alla folla, indica un’emozione collettiva totalizzante. L’espressione “a quanti l’odio consuma e l’amore” (v. 12) è una sineddoche per indicare l’intera umanità e le sue passioni distruttive o costruttive.
- Antitesi: Il contrasto tra la disperazione del portiere sconfitto e la gioia della folla/squadra vincitrice è la figura dominante. Vi è anche un contrasto implicito tra l’azione “vana” (v. 2) del portiere che subisce il gol e la “rete inviolata” (v. 13) del portiere vincitore.
- Iperbole implicita: “Pochi momenti come questo belli” (v. 10) per descrivere la gioia della vittoria sportiva, che viene elevata a uno dei vertici emotivi dell’esistenza umana.
3. Nella poesia sono evidenziati gli atteggiamenti e le reazioni dei due portieri: in che modo Saba li mette in rilievo?
Saba mette in rilievo gli atteggiamenti e le reazioni dei due portieri attraverso un sapiente contrasto di posture fisiche, manifestazioni emotive e posizioni spaziali:
- Il portiere sconfitto (v. 1-6): La sua reazione è dominata dalla disperazione e dalla vergogna. Egli è “caduto alla difesa / ultima vana”, suggerendo l’esaurimento di ogni sforzo e la fatalità della sconfitta. Il gesto di “celar la faccia, a non veder l’amara luce” indica un desiderio di isolamento, di fuga dalla realtà e dal giudizio esterno, un senso di umiliazione profondo. Le sue lacrime, scoperte dal compagno, ne rivelano la sofferenza intima. La sua postura è quella della sconfitta, della prostrazione.
- Il portiere vincitore (vv. 13-18): La sua reazione è all’opposto, ma sorprendentemente composta e interiorizzata, in contrasto con l’esplosione di giubilo della folla. Egli rimane fisicamente “presso la rete inviolata”, quasi a custodirla, a godere silenziosamente della sua integrità. La sua anima, tuttavia, non è “sola” con la persona, ma partecipa all’esultanza. La sua gioia si manifesta attraverso gesti intimi e giocosi (“si fa una capriola”, “si fa baci che manda di lontano”), quasi un’espressione fanciullesca e spontanea che non necessita di clamore. La sua posizione distante dalla folla sottolinea una gioia che è pienamente consapevole ma non necessita di essere esternata in modo eccessivo, proprio perché profondamente sentita.
Saba enfatizza la loro diversità di fronte allo stesso evento: uno è annientato dalla sconfitta, l’altro si gode una vittoria che lo rende partecipe di una festa collettiva, pur mantenendo una sua dimensione personale e più intima.
4. Come si manifesta l’esultanza della squadra vincitrice per la rete? E perché i suoi calciatori sono definiti fratelli?
L’esultanza della squadra vincitrice per la rete si manifesta in modo corale e travolgente, con una forte componente di fisicità e di gioia condivisa.
- La folla è descritta come “unita ebbrezza” (v. 7), che “par trabocchi / nel campo” (vv. 7-8), quasi una massa indistinta e incontenibile che esonda di felicità. L’ebbrezza è un’emozione che unisce, un delirio collettivo.
- I calciatori della squadra vincitrice si gettano “al suo collo” (v. 9), ovvero al collo di colui che ha segnato il gol. Questo gesto di abbraccio è fisico, diretto, spontaneo, esprimendo un’esplosione di gioia e affetto reciproco.
I calciatori sono definiti “fratelli” (v. 9) per sottolineare la profondità del loro legame. Il termine evoca:
- Solidarietà e cameratismo: Sono uniti da uno scopo comune, hanno condiviso la fatica, la tensione e, infine, la vittoria. La fraternità nasce dal comune impegno e dalla fiducia reciproca.
- Legame affettivo profondo: Va oltre la semplice appartenenza a una squadra o a un gruppo sportivo; suggerisce un legame quasi familiare, basato sull’affetto e sulla vicinanza.
- Identità collettiva: In quel momento di trionfo, le individualità si fondono in un’entità unica, una fratellanza di intenti e di gioia.
5. Quale significato, a tuo avviso, si può attribuire al verso conclusivo della poesia?
Il verso conclusivo della poesia, “Della festa – egli dice – anch’io son parte.” (v. 18), attribuito al portiere della squadra vincitrice, ha un significato profondo e complesso, che va oltre la semplice partecipazione alla gioia.
- Inclusione e consapevolezza intima: Nonostante la sua posizione periferica sul campo (“Presso la rete inviolata”, v. 13), distante dall’abbraccio collettivo che celebra il gol, il portiere vince. Egli non è l’autore diretto dell’azione, ma la sua gioia è autentica. L’affermazione “anch’io son parte” non è una rivendicazione, ma una serena e intima consapevolezza di appartenere alla vittoria e alla festa. La sua gioia è una “capriola” o “baci che manda di lontano”, gesti meno eclatanti ma carichi di una profonda e fanciullesca felicità.
- Una gioia meno effimera: Mentre la folla è presa da un’ebbrezza quasi irrazionale, la gioia del portiere appare più matura, consapevole, meno rumorosa ma forse più duratura. Non è un’esplosione esteriore, ma un’intima partecipazione che non ha bisogno di clamore per essere sentita.
- Il valore del ruolo silenzioso: Il portiere, per natura del suo ruolo, è spesso isolato, in attesa, un “ultimo” nella difesa. Questo verso celebra la sua importanza cruciale, anche se non sempre evidente, nella vittoria collettiva. Egli è parte della festa non per aver segnato, ma per aver custodito la porta inviolata, permettendo la vittoria.
- Universalità del sentimento: La sua affermazione può essere letta come una metafora della partecipazione di ogni individuo alla vita e alle sue vittorie, anche quando non si è protagonisti sotto i riflettori. Ognuno, a suo modo, contribuisce e trova la sua parte nella “festa” dell’esistenza.
In sintesi, il verso conclusivo esprime una gioia profonda e consapevole, derivante da un senso di appartenenza che trascende la mera vicinanza fisica, e celebra il valore di una partecipazione intima e meno appariscente al trionfo collettivo.
Interpretazione
La poesia “Goal” di Umberto Saba è una gemma della sua poetica, capace di catturare con straordinaria sintesi i sentimenti e gli stati d’animo – individuali e collettivi – provocati dagli eventi sportivi. L’episodio di un gol non è solo cronaca di una partita di calcio, ma diventa per Saba un’occasione per esplorare le profonde verità dell’animo umano, la sua “onesta” rappresentazione del reale che è cifra distintiva della sua opera.
La lirica illustra magistralmente la dualità dell’esperienza sportiva: da un lato la sofferenza cocente della sconfitta, dall’altro la gioia inebriante della vittoria. Il portiere sconfitto è l’incarnazione del dolore individuale, della vergogna e della disperazione. Il suo gesto di “celar la faccia” è universale: è la reazione primordiale di chi non vuole confrontarsi con l’evidenza del fallimento, un simbolo della vulnerabilità umana di fronte alla perdita. Il compagno che lo consola è il simbolo della solidarietà, dell’empatia, del “nido” umano che cerca di lenire il dolore. Questa rappresentazione si lega a un aspetto significativo della poetica sabiana: la sua attenzione per l’uomo comune, per le emozioni semplici e autentiche, prive di intellettualismi, e per la vita quotidiana nella sua immediatezza. Il dolore del portiere è un dolore che ogni individuo può provare nella sua vita, non solo in un campo da calcio.
All’opposto, l’esultanza della folla e della squadra vincitrice è la celebrazione della gioia collettiva. L'”unita ebbrezza” della folla e il legame fraterno dei calciatori (“fratelli”) evocano la capacità dello sport di unire gli animi, di creare un senso di appartenenza e di catarsi condivisa. In quel momento, le individualità si fondono in un’unica entità che celebra il trionfo, dimenticando le differenze per un’emozione comune. Questo aspetto della poesia si collega al tema del “nido” in Saba, inteso come il nucleo affettivo e sociale (la famiglia, la squadra, la città) che offre protezione, solidarietà e un senso di identità. Il campo da calcio diventa così un microcosmo sociale dove si manifestano le dinamiche più profonde dell’agire umano.
Particolarmente interessante è la figura del portiere della squadra vincitrice. La sua gioia non è fragorosa come quella della folla, ma si manifesta in gesti intimi e quasi pudici (“una capriola”, “baci che manda di lontano”). Questo silenzio e questa compostezza, pur nella partecipazione alla festa, riflettono una maturità emotiva e una consapevolezza più profonda. Egli è parte della festa non per aver segnato il gol (il gesto eclatante), ma per aver mantenuto inviolata la sua rete (l’azione silenziosa e fondamentale). La sua è una gioia che si basa sulla responsabilità del proprio ruolo e sulla consapevolezza di aver contribuito al successo collettivo anche senza i riflettori. Questo può essere interpretato come un riflesso della stessa poetica di Saba: una poesia che non cerca il clamore o l’estremismo, ma che nella sua “onestà” e nella sua apparente semplicità, riesce a cogliere le verità più complesse e i sentimenti più autentici dell’animo umano.
Il tema dei sentimenti individuali e collettivi negli eventi sportivi è universale e può essere rintracciato in diverse espressioni artistiche. Nel cinema, film sul calcio o su altri sport (come Fuga per la vittoria, L’uomo che non si arrese) hanno spesso esplorato il dramma della sconfitta, la gioia della vittoria, la solidarietà di squadra e il rapporto tra l’individuo e la massa. In letteratura, il tema del calcio è stato trattato da diversi autori, anche in Italia, come Pier Paolo Pasolini, che vedeva nel calcio una “rappresentazione rituale del mondo”. Al di là del calcio, ogni evento sportivo di massa (Olimpiadi, Mondiali di altre discipline) è capace di scatenare un’ondata di emozioni collettive che travalicano i confini nazionali, unendo popoli in un’unica, appassionata marea di tifo.
In conclusione, “Goal” di Saba, nella sua essenzialità, è molto più di una poesia sul calcio. È una meditazione sui sentimenti umani più basilari – la gioia, il dolore, la vergogna, la solidarietà – che lo sport, con la sua drammaticità e la sua ritualità, riesce a mettere a nudo. Attraverso la sua “poesia onesta”, Saba ci ricorda che la vita, come una partita di calcio, è fatta di vittorie e sconfitte, di sforzi individuali e di abbracci collettivi, e che è proprio nella semplicità di queste esperienze che risiede la sua più profonda e autentica bellezza.




