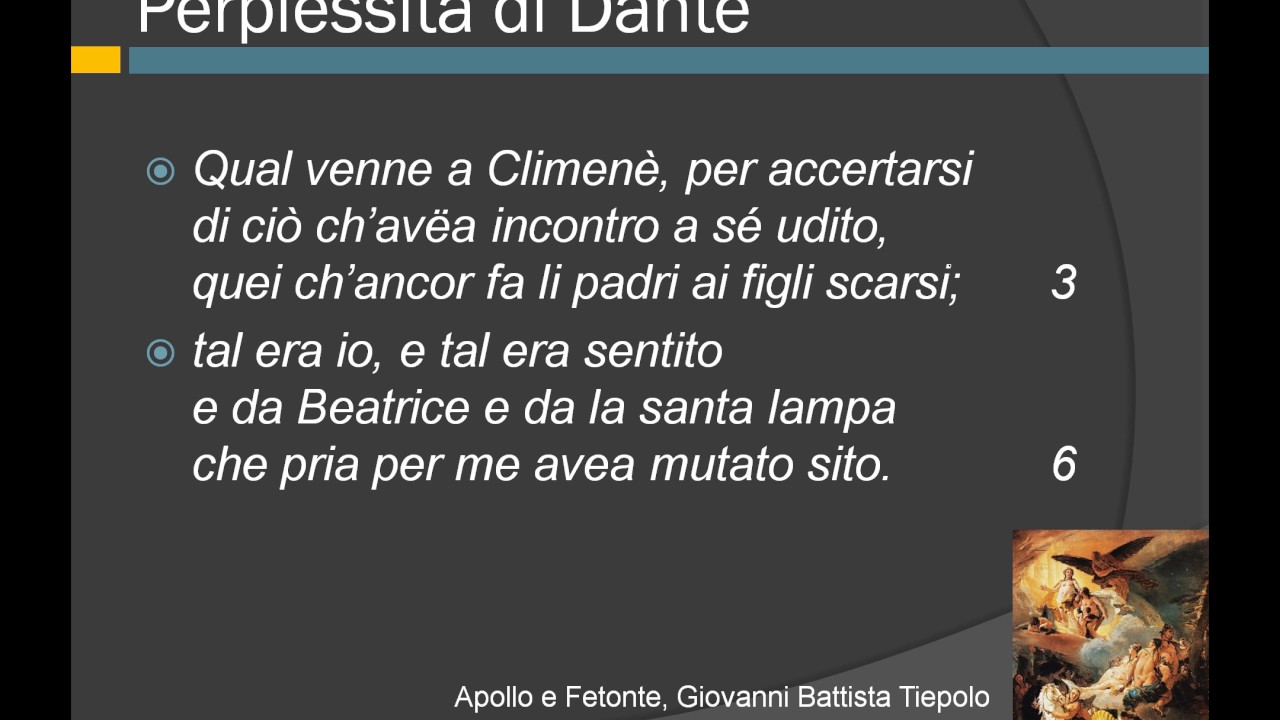
Canto diciassettesimo del Paradiso vv. 1-78
28 Dicembre 2019
La canzone della verità di Enrico Ruggeri
28 Dicembre 2019“La quiete dopo la tempesta”, componimento XXIV dei Canti di Giacomo Leopardi, scritto a Recanati nel 1829, è uno dei cosiddetti “Grandi Idilli”.
Questa lirica rappresenta un momento cruciale nell’evoluzione del pensiero leopardiano, in quanto illustra in modo esemplare la sua visione della Natura matrigna e della teoria del piacere. Il canto si articola in due parti distinte: la descrizione della gioia e del ritorno alla vita dopo un temporale, e la successiva amara riflessione filosofica sulla natura effimera e illusoria della felicità umana.
1. La Descrizione della Quiete e il Ritorno alla Vita (vv. 1-24)
La prima parte del canto è un quadro vivido e sensoriale della ripresa della vita nel borgo dopo il passaggio di un violento temporale. La natura e gli uomini sembrano risvegliarsi a nuova vita, pervasi da una gioia diffusa.
Passata è la tempesta: odo augelli far festa, e la gallina, tornata in su la via, che ripete il suo verso. Ecco il sereno rompe lá da ponente, alla montagna: sgombrasi la campagna, e chiaro nella valle il fiume appare. (vv. 1-7)
Il temporale è cessato, e i primi segni di ripresa sono uditivi: il canto festoso degli uccelli e il verso ripetuto della gallina. Poi visivi: il sereno che “rompe” da ponente, sgombrando la campagna e rendendo il fiume “chiaro nella valle”.
Un paesaggio dopo la tempesta, con il sole che spunta tra le nuvole e un arcobaleno, simbolo del ritorno alla quiete.
La gioia si diffonde tra gli uomini e le loro attività quotidiane riprendono con rinnovato vigore:
Ogni cor si rallegra, in ogni lato risorge il romorio, torna il lavoro usato. L’artigiano a mirar l’umido cielo, con l’opra in man, cantando, fassi in su l’uscio; a prova vien fuor la femminetta a côr dell’acqua della novella piova; e l’erbaiuol rinnova di sentiero in sentiero il grido giornaliero. (vv. 8-18)
Il “romorio” che risorge e il “lavoro usato” che torna indicano il ritorno alla normalità. L’artigiano esce sull’uscio cantando, la femminetta raccoglie l’acqua piovana, l’erbaiuolo riprende il suo grido. Sono tutte immagini di una ritrovata vitalità e di una felicità semplice e diffusa.
La scena si completa con il ritorno del sole e il movimento generale della vita:
Ecco il sol che ritorna, ecco sorride per li poggi e le ville. Apre i balconi, apre terrazzi e logge la famiglia: e, dalla via corrente, odi lontano tintinnio di sonagli; il carro stride del passeggier che il suo cammin ripiglia. (vv. 19-24)
Il sole che “sorride” sui poggi e sulle ville, le famiglie che aprono balconi e terrazzi, il tintinnio dei sonagli e lo stridere del carro del passeggiero: tutto contribuisce a creare un’atmosfera di gioia universale, un’esplosione di vita dopo la paura del temporale.
2. La Riflessione Filosofica: Il Piacere come Figlio dell’Affanno (vv. 25-54)
La seconda parte del canto segna un brusco passaggio dal quadro idillico alla riflessione filosofica, che smaschera la natura illusoria di questa felicità.
Si rallegra ogni core. Sí dolce, sí gradita quand’è, com’or, la vita? Quando con tanto amore l’uomo a’ suoi studi intende? o torna all’opre? o cosa nova imprende? quando de’ mali suoi men si ricorda? (vv. 25-31)
Il poeta si interroga: quando la vita è “così dolce, così gradita” come ora? La risposta implicita è: solo quando si è appena usciti da una condizione di dolore o paura. È in questi momenti che l’uomo si dedica con più amore ai suoi studi o al lavoro, e “men si ricorda” dei suoi mali.
La chiave di volta della riflessione è l’affermazione:
Piacer figlio d’affanno; gioia vana, ch’è frutto del passato timore, onde si scosse e paventò la morte chi la vita abborria; onde in lungo tormento, fredde, tacite, smorte, sudâr le genti e palpitâr, vedendo mossi alle nostre offese folgori, nembi e vento. (vv. 32-41)
Il piacere, per Leopardi, non è un’entità positiva in sé, ma è solo il “figlio d’affanno”, una “gioia vana” che nasce dal “passato timore”. La felicità che si prova dopo la tempesta non è vera felicità, ma semplicemente la cessazione della paura e del tormento (la paura della morte, il sudore e il palpitare delle genti di fronte ai “folgori, nembi e vento” che sembravano mossi “alle nostre offese”). È la teoria del piacere leopardiana applicata a un esempio concreto.
3. L’Accusa alla Natura e la Condizione Umana (vv. 42-54)
La riflessione culmina in una violenta apostrofe alla Natura, che si rivela ancora una volta “matrigna”.
O natura cortese, son questi i doni tuoi, questi i diletti sono che tu porgi ai mortali. Uscir di pena è diletto fra noi. Pene tu spargi a larga mano; il duolo spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto che per mostro e miracolo talvolta nasce d’affanno, è gran guadagno. (vv. 42-50)
L’appellativo “cortese” è ironico. Leopardi denuncia la crudeltà della Natura: i suoi “doni” e “diletti” per i mortali consistono unicamente nell’uscita dalla pena. La Natura “sparge a larga mano” le pene, mentre il “duolo spontaneo sorge”. Il piacere è un evento raro, quasi un “mostro e miracolo”, che nasce solo dall’affanno. Se si prova un po’ di piacere dopo tanto dolore, è già “gran guadagno”.
Il canto si chiude con un’amara considerazione sulla condizione umana:
Umana prole cara agli eterni! assai felice se respirar ti lice d’alcun dolor; beata se te d’ogni dolor morte risana. (vv. 50-54)
Gli uomini, pur essendo considerati “prole cara agli eterni” (un’altra ironia, dato che gli “eterni” non si curano di loro), sono “assai felici” solo se possono “respirare” per un attimo da qualche dolore. La vera “beatitudine” è concessa solo dalla morte, che “risana” da ogni dolore. La morte, quindi, è l’unica vera liberazione dalla sofferenza.
4. Temi Principali
- Piacere e Dolore: Il tema centrale. Il piacere è una condizione effimera, una momentanea sospensione del dolore, non un’entità positiva. La vita umana è intrinsecamente dolore.
- Natura Matrigna: La Natura è presentata come una forza indifferente e crudele, che illude l’uomo con brevi momenti di sollievo per poi ripiombarlo nella sofferenza. L’appellativo “cortese” è sarcastico.
- Illusione e Vero: La gioia dopo la tempesta è un’illusione, un inganno della Natura. La verità è che la vita è dolore e la vera quiete è solo nella morte.
- Condizione Umana: L’uomo è condannato a una vita di sofferenza, con rari e brevi momenti di sollievo. La morte è l’unica vera liberazione.
- Contrasto: Il canto è costruito su un forte contrasto tra la descrizione vivida e gioiosa della ripresa della vita e la successiva amara riflessione filosofica.
5. Stile e Linguaggio
- Linguaggio Idillico e Vago: Nella prima parte, il linguaggio è ricco di immagini sensoriali (suoni, colori, movimenti) e aggettivi che creano un’atmosfera di serenità e vitalità (“augelli far festa”, “sereno”, “chiaro”, “romorio”, “odoroso”, “sorride”).
- Linguaggio Filosofico e Argomentativo: Nella seconda parte, il tono diventa più riflessivo e argomentativo. Il linguaggio è più astratto e concettuale, con l’uso di termini come “affanno”, “timore”, “tormento”, “pena”, “duolo”.
- Apostrofi: L’apostrofe iniziale alla “natura cortese” è un esempio di ironia leopardiana, che svela la vera natura della forza che governa il mondo.
- Endecasillabi e Settenari Sciolti: Il canto è composto da una successione di endecasillabi e settenari sciolti, che conferiscono al testo un andamento fluido e meditativo, ma anche la possibilità di brusche interruzioni per l’espressione del dolore.
- Figure Retoriche: Numerose figure retoriche arricchiscono il testo: personificazione della Natura (“sorride”), metafore (“piacer figlio d’affanno”), ossimori (“natura cortese” in senso ironico), anafore (“apre i balconi, apre terrazzi”).
Conclusione
“La quiete dopo la tempesta” è un capolavoro della lirica leopardiana, che condensa in pochi versi la sua visione più matura e radicale della condizione umana. Partendo da un’osservazione quotidiana (il ritorno del sereno dopo un temporale), Leopardi eleva la riflessione a un livello universale, smascherando la natura illusoria del piacere e rivelando la crudeltà intrinseca della Natura. Il canto è un’espressione potente del pessimismo cosmico, ma anche della lucidità intellettuale del poeta, che non si sottrae alla verità, per quanto amara essa sia. La sua bellezza risiede proprio nella capacità di trasformare una constatazione dolorosa in una poesia di rara intensità e profondità.

Testo della poesia “LA QUIETE DOPO LA TEMPESTA” di Giacomo Leopardi
Giacomo Leopardi – Canti (1831)
La quiete dopo la tempesta
XXIV
Passata è la tempesta:
odo augelli far festa, e la gallina,
tornata in su la via,
che ripete il suo verso. Ecco il sereno
rompe lá da ponente, alla montagna: 5
sgombrasi la campagna,
e chiaro nella valle il fiume appare.
Ogni cor si rallegra, in ogni lato
risorge il romorio,
torna il lavoro usato. 10
L’artigiano a mirar l’umido cielo,
con l’opra in man, cantando,
fassi in su l’uscio; a prova
vien fuor la femminetta a côr dell’acqua
della novella piova; 15
e l’erbaiuol rinnova
di sentiero in sentiero
il grido giornaliero.
Ecco il sol che ritorna, ecco sorride
per li poggi e le ville. Apre i balconi, 20
apre terrazzi e logge la famiglia:
e, dalla via corrente, odi lontano
tintinnio di sonagli; il carro stride
del passeggier che il suo cammin ripiglia.
Si rallegra ogni core. 25
Sí dolce, sí gradita
quand’è, com’or, la vita?
Quando con tanto amore
l’uomo a’ suoi studi intende?
o torna all’opre? o cosa nova imprende? 30
quando de’ mali suoi men si ricorda?
Piacer figlio d’affanno;
gioia vana, ch’è frutto
del passato timore, onde si scosse
e paventò la morte 35
chi la vita abborria;
onde in lungo tormento,
fredde, tacite, smorte,
sudâr le genti e palpitâr, vedendo
mossi alle nostre offese 40
folgori, nembi e vento.
O natura cortese,
son questi i doni tuoi,
questi i diletti sono
che tu porgi ai mortali. Uscir di pena 45
è diletto fra noi.
Pene tu spargi a larga mano; il duolo
spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto
che per mostro e miracolo talvolta
nasce d’affanno, è gran guadagno. Umana 50
prole cara agli eterni! assai felice
se respirar ti lice
d’alcun dolor; beata
se te d’ogni dolor morte risana.




