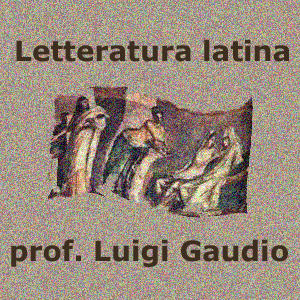
Il teatro italico delle origini
28 Dicembre 2019
La Germania nel trecento: declino dell’Impero medievale
28 Dicembre 2019Angioini e Aragonesi: La Lotta per il Mezzogiorno d’Italia
La storia del Meridione d’Italia nel tardo Medioevo è stata profondamente segnata dalla lunga e sanguinosa rivalità tra due potenti dinastie straniere: gli Angioini e gli Aragonesi. Questa contesa, durata per oltre un secolo e mezzo, vide come posta in gioco il controllo del prospero Regno di Sicilia (che all’epoca comprendeva sia l’isola che il Mezzogiorno continentale), trasformando il Mediterraneo in un campo di battaglia politico, militare ed economico.
1. Le Origini delle Dinastie
 Battaglia di Benevento (1266): Carlo d’Angiò sconfigge Manfredi di Svevia.
Battaglia di Benevento (1266): Carlo d’Angiò sconfigge Manfredi di Svevia.
- Gli Angioini:
- Provenienza: Erano un ramo cadetto della dinastia francese dei Capetingi, discendenti da Carlo, fratello del re di Francia Luigi IX (San Luigi). Il loro nome deriva dalla Contea d’Angiò, nella Loira.
- Arrivo in Italia: Furono chiamati in Italia dal Papato, che cercava di eliminare la minaccia degli Hohenstaufen (la dinastia sveva di Federico II) dal Sud Italia. Papa Urbano IV offrì la corona del Regno di Sicilia a Carlo d’Angiò. Nel 1266, Carlo d’Angiò sconfisse Manfredi di Svevia nella battaglia di Benevento e, nel 1268, sconfisse e giustiziò Corradino di Svevia (battaglia di Tagliacozzo), ponendo fine alla dominazione sveva e inaugurando quella angioina. Il Regno di Sicilia, nato dall’unione della Sicilia con il Mezzogiorno continentale, passò sotto il loro controllo.
- Gli Aragonesi:
- Provenienza: Erano la dinastia regnante della Corona d’Aragona, uno Stato in espansione che comprendeva i regni di Aragona e Valencia, la contea di Barcellona e altre terre sul Mediterraneo (come le Baleari e la Sardegna dal 1323).
- Interesse per la Sicilia: Il loro interesse per la Sicilia era sia strategico che dinastico. Pietro III d’Aragona aveva sposato Costanza di Svevia, figlia di Manfredi, e si considerava il legittimo erede del Regno di Sicilia dopo la caduta degli Hohenstaufen.
2. La Guerra del Vespro Siciliano (1282-1302)

I Vespri Siciliani, rivolta anti-angioina del 1282. (dipinto di Hayez)
Il conflitto tra Angioini e Aragonesi esplose in modo drammatico con la Guerra del Vespro Siciliano.
- Cause:
- Malcontento Siciliano: Il dominio angioino in Sicilia fu percepito come oppressivo dalla popolazione e dalla nobiltà locale. Carlo d’Angiò spostò la capitale da Palermo a Napoli, impose una tassazione elevata per finanziare i suoi ambiziosi progetti mediterranei (tra cui la riconquista di Costantinopoli), e favorì i baroni francesi a scapito di quelli siciliani.
- Interessi Aragonesi: Pietro III d’Aragona, come genero di Manfredi, era pronto a intervenire per rivendicare i suoi diritti dinastici sull’isola e per espandere la sua influenza nel Mediterraneo.
- Complotto Internazionale: Si ritiene che la rivolta fosse stata fomentata da Pietro III e dall’Impero Bizantino (che temeva i progetti espansionistici angioini), con il sostegno di baroni siciliani come Giovanni da Procida.
- Svolgimento:
- L’Insurrezione (30 marzo 1282): La scintilla scoppiò a Palermo, all’ora dei vespri del Lunedì dell’Angelo. Una rissa tra soldati francesi e siciliani si trasformò in una sanguinosa rivolta popolare contro gli Angioini, che si diffuse rapidamente in tutta l’isola. Migliaia di francesi furono massacrati.
- L’Intervento Aragonese: I Siciliani chiesero aiuto a Pietro III d’Aragona, che sbarcò in Sicilia e fu acclamato re. Carlo d’Angiò reagì con un assedio a Messina, ma fu costretto a ritirarsi.
- La Guerra (1282-1302): Il conflitto si protrasse per vent’anni, con fasi alterne e coinvolgendo anche il Papato (che appoggiava gli Angioini e scomunicò gli Aragonesi) e la Corona di Francia. La guerra fu combattuta sia in Sicilia che nel Mezzogiorno continentale, e vide importanti battaglie navali.
- La Pace di Caltabellotta (1302): La guerra si concluse con questo trattato, che sancì una spartizione del Regno di Sicilia:
- Sicilia: Rimase agli Aragonesi, con Federico III (figlio di Pietro III), che assunse il titolo di “re di Trinacria”.
- Mezzogiorno Continentale: Rimase agli Angioini, con Carlo II, che mantenne il titolo di “re di Napoli” (o “re di Sicilia citeriore”). Formalmente, Federico III avrebbe dovuto restituire l’isola agli Angioini dopo la sua morte, ma ciò non avvenne mai. Si crearono così due entità politiche separate: il Regno di Napoli (angioino) e il Regno di Sicilia (aragonese).
3. Il Prosieguo della Rivalità (XIV-XV secolo)
Nonostante la Pace di Caltabellotta, la rivalità non cessò. Per tutto il XIV secolo e l’inizio del XV, ci furono nuovi scontri e tentativi da parte degli Angioini di riconquistare la Sicilia. La politica italiana fu costantemente influenzata da questa contesa, con alleanze mutevoli tra papi, imperatori, comuni e signorie.
- La Seconda Guerra del Vespro (1313-1372): Una lunga fase di conflitti intermittenti tra Angioini e Aragonesi, che portò a un’ulteriore instabilità e a un indebolimento economico di entrambe le parti.
- Alfonso V d’Aragona “il Magnanimo”: La svolta decisiva avvenne nel XV secolo. Alfonso V, re d’Aragona e di Sicilia, ambiva a riunire l’intero Mezzogiorno. Dopo lunghe campagne militari e un assedio a Napoli, nel 1442 sconfisse Renato d’Angiò (l’ultimo sovrano angioino di Napoli) ed entrò trionfalmente a Napoli.
- La Riunificazione Aragonese: Con Alfonso V, l’intero Mezzogiorno continentale (Regno di Napoli) e la Sicilia vennero riuniti sotto la Corona d’Aragona, anche se formalmente i due regni rimasero distinti. Con la sua morte, il Regno di Napoli passò al figlio illegittimo Ferrante I, dando vita a un ramo autonomo aragonese di Napoli.
4. Conseguenze a Lungo Termine
La lotta tra Angioini e Aragonesi ebbe ripercussioni profonde:
- Frammentazione del Sud Italia: La separazione tra Regno di Napoli e Regno di Sicilia dopo i Vespri Siciliani segnò una frattura politica, economica e culturale che perdurò per secoli.
- Influenza Straniera: Il Mezzogiorno divenne terreno di conquista per potenze straniere (Francia e Spagna), che ne condizionarono la politica e l’economia. La dominazione spagnola, in particolare, durerà fino al XVIII secolo.
- Declino Economico (per la Sicilia): Sebbene i Vespri avessero portato alla cacciata degli Angioini, il lungo conflitto e la dipendenza dalla Corona d’Aragona, spesso più interessata alle Americhe, contribuirono a un periodo di stagnazione e arretratezza per la Sicilia, con il consolidamento del potere baronale.
- Rafforzamento della Nobiltà: Le continue guerre e le necessità finanziarie dei sovrani favorirono il consolidamento del potere della nobiltà feudale, sia nel Regno di Napoli che in quello di Sicilia.
- Cambiamenti Politici e Strategici nel Mediterraneo: La rivalità tra Angioini e Aragonesi spostò gli equilibri di potere nel Mediterraneo, aprendo spazi anche per altre potenze (come Venezia) e ponendo le basi per le future contese europee sul dominio della penisola italiana (es. le Guerre d’Italia del ‘500).
In conclusione, il conflitto tra Angioini e Aragonesi fu un’epoca di intense trasformazioni per il Sud Italia. Rappresentò non solo uno scontro dinastico, ma anche la lotta tra due diverse visioni politiche e due ambizioni egemoniche nel Mediterraneo, le cui conseguenze si protrassero per secoli, plasmando il destino di uno dei territori più strategici d’Europa.



