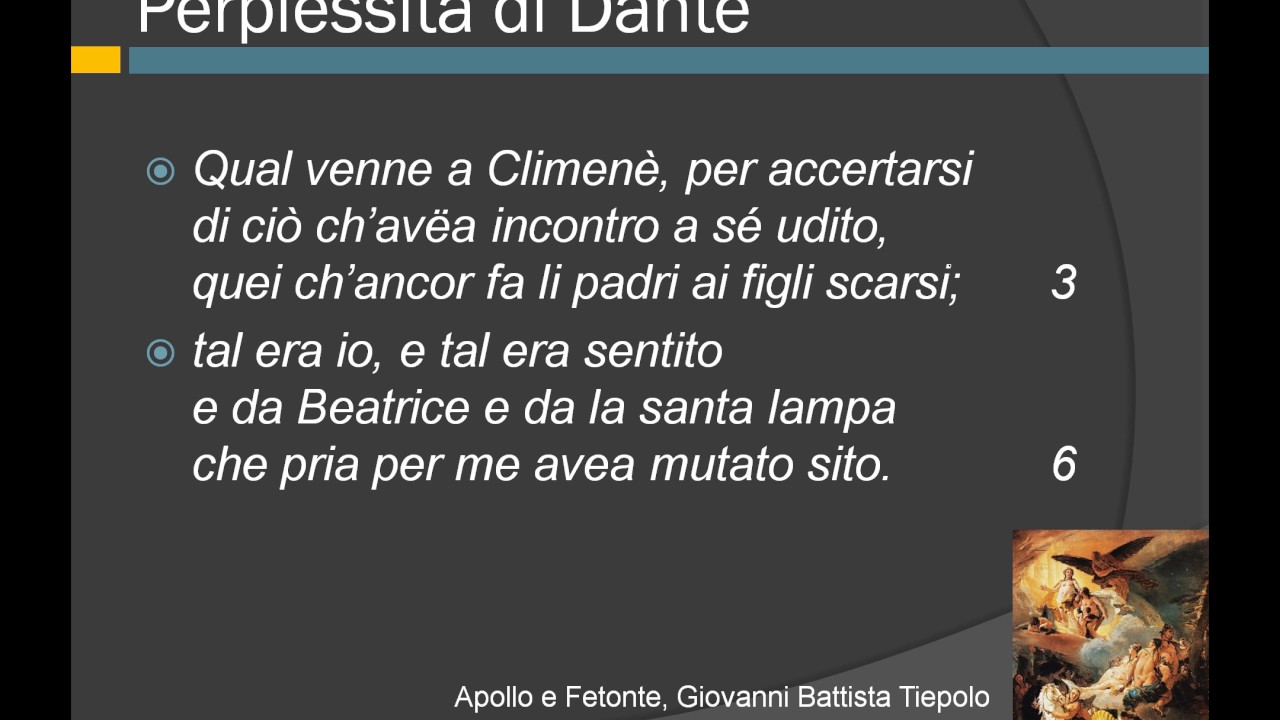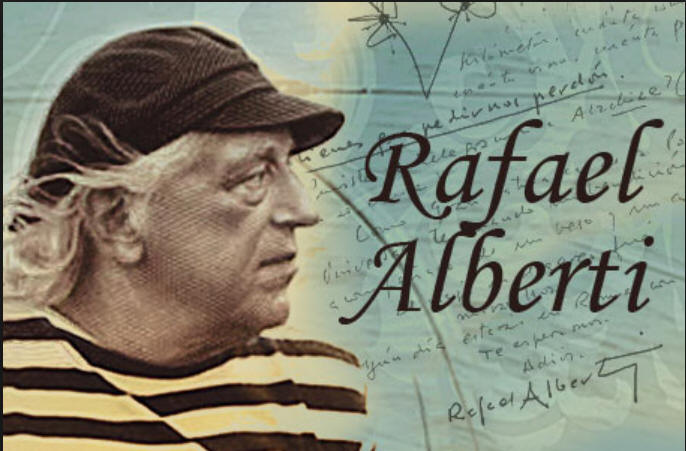
Han sradicato un albero di Rafael Alberti
28 Dicembre 2019
Mediterraneo: economia, stati e conflitti
28 Dicembre 2019Analisi e testo dei primi 78 versi del Canto diciassettesimo del Paradiso
Analisi: Paradiso, Canto XVII di Dante Alighieri
Il Canto XVII del Paradiso è uno dei momenti più intensi e cruciali dell’intera Divina Commedia. Nel cielo di Marte, l’incontro con il trisavolo Cacciaguida raggiunge il suo culmine con la profezia dell’esilio di Dante. Questo canto non solo svela il destino personale del poeta, ma ne chiarisce anche la missione profetica, ponendolo di fronte alla dura verità che dovrà affrontare e al compito di rivelarla al mondo.
1. Il Dubbio di Dante e l’Incoraggiamento di Beatrice (vv. 1-12)
Il canto si apre con una similitudine mitologica che esprime l’ansia di Dante. Egli si paragona a Fetonte, che andò da sua madre Climene per accertarsi della sua origine divina, dopo aver sentito voci che lo mettevano in dubbio.
Qual venne a Climenè, per accertarsi di ciò ch’avëa incontro a sé udito, quei ch’ancor fa li padri ai figli scarsi; tal era io, e tal era sentito e da Beatrice e da la santa lampa che pria per me avea mutato sito. (vv. 1-6)
Dante è tormentato dai dubbi sul suo futuro, avendo già udito profezie oscure nel corso del suo viaggio (da Ciacco, Farinata, Brunetto Latini, Currado Malaspina, Oderisi da Gubbio). La sua ansia è percepita da Beatrice e da Cacciaguida (“la santa lampa”).
Beatrice, con la sua consueta dolcezza, lo esorta a esprimere chiaramente il suo desiderio, non perché lei o Cacciaguida non conoscano già i suoi pensieri, ma perché Dante stesso deve abituarsi a parlare senza timore.
Per che mia donna «Manda fuor la vampa del tuo disio», mi disse, «sì ch’ella esca segnata bene de la interna stampa: non perché nostra conoscenza cresca per tuo parlare, ma perché t’ausi a dir la sete, sì che l’uom ti mesca». (vv. 7-12)
Questo incoraggiamento è fondamentale per la missione di Dante: deve imparare a “dire la sete”, cioè a esprimere la verità, anche se scomoda, per poter essere compreso dagli uomini.
Fetonte e Climene, un’immagine che introduce l’ansia di Dante.
2. La Richiesta di Dante: Chiarezza sul Futuro (vv. 13-27)
Dante si rivolge a Cacciaguida, riconoscendo la sua capacità di vedere il futuro, poiché egli contempla Dio, il “punto a cui tutti li tempi son presenti”.
«O cara piota mia che sì t’insusi, che, come veggion le terrene menti non capere in trïangol due ottusi, così vedi le cose contingenti anzi che sieno in sé, mirando il punto a cui tutti li tempi son presenti; (vv. 13-18)
Il poeta ricorda le “parole gravi” sulla sua vita futura che gli furono dette in Inferno e Purgatorio, e pur sentendosi “ben tetragono ai colpi di ventura” (cioè saldo e resistente agli urti della sorte), desidera capire quale “fortuna” (sorte) lo attende.
mentre ch’io era a Virgilio congiunto su per lo monte che l’anime cura e discendendo nel mondo defunto, dette mi fuor di mia vita futura parole gravi, avvegna ch’io mi senta ben tetragono ai colpi di ventura; per che la voglia mia saria contenta d’intender qual fortuna mi s’appressa: ché saetta previsa vien più lenta». (vv. 19-27)
La celebre similitudine finale (“ché saetta previsa vien più lenta”) esprime il desiderio umano di conoscere il male imminente per affrontarlo con maggiore preparazione e minor impatto.
Una freccia che si avvicina lentamente a un bersaglio, illustrando la metafora della “saetta previsa”.
3. La Profezia dell’Esilio: L’Amara Verità (vv. 28-69)
Cacciaguida risponde a Dante con parole “chiare” e “precise”, senza le “ambage” (linguaggio oscuro e ambiguo) tipiche degli oracoli pagani.
Così diss’ io a quella luce stessa che pria m’avea parlato; e come volle Beatrice, fu la mia voglia confessa. Né per ambage, in che la gente folle già s’inviscava pria che fosse anciso l’Agnel di Dio che le peccata tolle, ma per chiare parole e con preciso latin rispose quello amor paterno, chiuso e parvente del suo proprio riso: (vv. 28-36)
Prima di svelare la profezia, Cacciaguida spiega la natura della contingenza (gli eventi futuri non necessari) e della prescienza divina. Dio vede tutto nel “cospetto etterno”, ma questa visione non implica necessità per gli eventi futuri, così come vedere una nave scendere un torrente non ne determina il moto.
«La contingenza, che fuor del quaderno de la vostra matera non si stende, tutta è dipinta nel cospetto etterno; necessità però quindi non prende se non come dal viso in che si specchia nave che per torrente giù discende. (vv. 37-42)
Poi, con un’immagine uditiva, Cacciaguida annuncia il destino di Dante:
Da indi, sì come viene ad orecchia dolce armonia da organo, mi viene a vista il tempo che ti s’apparecchia. (vv. 43-45)
La profezia è diretta e dolorosa: Dante dovrà lasciare Firenze, come Ippolito fu costretto a lasciare Atene a causa della perfida matrigna Fedra.
Qual si partio Ipolito d’Atene per la spietata e perfida noverca, tal di Fiorenza partir ti convene. (vv. 46-48)
L’esilio è voluto e cercato dai suoi nemici, in una Firenze dove “Cristo tutto dì si merca” (dove la fede è commercializzata, allusione alla corruzione). La colpa ricadrà sui perseguitati, ma la vendetta divina (o la giustizia della storia) testimonierà la verità.
Questo si vuole e questo già si cerca, e tosto verrà fatto a chi ciò pensa là dove Cristo tutto dì si merca. La colpa seguirà la parte offensa in grido, come suol; ma la vendetta fia testimonio al ver che la dispensa. (vv. 49-54)
Le parole più celebri e strazianti della profezia descrivono le sofferenze dell’esilio:
Tu lascerai ogne cosa diletta più caramente; e questo è quello strale che l’arco de lo essilio pria saetta. Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale. (vv. 55-60)
Dante perderà tutto ciò che gli è più caro. Il “pane altrui” (il pane mangiato in esilio) ha il sapore del “sale” (amaro, difficile da digerire), e il “duro calle” dello “scendere e ‘l salir per l’altrui scale” evoca la fatica e l’umiliazione di dipendere dagli altri.
Pane salato e una scala ripida, che simboleggiano le difficoltà dell’esilio.
Il peso maggiore sarà la “compagnia malvagia e scempia” dei suoi compagni di esilio, che si riveleranno ingrati e folli. Tuttavia, Cacciaguida assicura a Dante che saranno loro, e non lui, a pagarne le conseguenze, e che Dante sarà glorificato per aver agito “per te stesso” (cioè di propria iniziativa, senza piegarsi).
E quel che più ti graverà le spalle, sarà la compagnia malvagia e scempia con la qual tu cadrai in questa valle; che tutta ingrata, tutta matta ed empia si farà contr’ a te; ma, poco appresso, ella, non tu, n’avrà rossa la tempia. Di sua bestialitate il suo processo farà la prova; sì ch’a te fia bello averti fatta parte per te stesso. (vv. 61-69)
4. Il Primo Rifugio: Il Gran Lombardo (vv. 70-78)
Dopo la dura profezia, Cacciaguida offre una prima consolazione, indicando il primo benefattore di Dante in esilio.
Lo primo tuo refugio e ’l primo ostello sarà la cortesia del gran Lombardo che ’n su la scala porta il santo uccello; (vv. 70-72)
Il “gran Lombardo” è Bartolomeo della Scala, signore di Verona, il cui stemma era una scala con un’aquila (“santo uccello”). Egli accoglierà Dante con tale “benigno riguardo” che il suo fare (nel concedere) precederà il chiedere di Dante.
ch’in te avrà sì benigno riguardo, che del fare e del chieder, tra voi due, fia primo quel che tra li altri è più tardo. (vv. 73-75)
Cacciaguida menziona poi un altro personaggio, “colui che ‘mpresso fue, nascendo, sì da questa stella forte, che notabili fier l’opere sue”, che sarà un altro benefattore. Questo è Cangrande della Scala, fratello di Bartolomeo, che diventerà il principale protettore di Dante e a cui sarà dedicato il Paradiso.
Con lui vedrai colui che ’mpresso fue, nascendo, sì da questa stella forte, che notabili fier l’opere sue. (vv. 76-78)
Lo stemma della famiglia della Scala con un’aquila, che rappresenta il “gran Lombardo” e il suo “santo uccello”.
5. Temi Principali
- Profezia e Prescienza Divina: Il canto è il culmine delle profezie della Commedia, che svelano il destino di Dante, ma anche la sua missione. La prescienza divina non annulla il libero arbitrio.
- Esilio: Tema centrale e doloroso, che Dante vive in prima persona. Viene descritto in tutte le sue sfaccettature: perdita degli affetti, umiliazione, solitudine, ingratitudine.
- Giustizia Divina e Umana: La profezia è un atto di giustizia divina, che condanna la corruzione di Firenze e la malvagità dei suoi persecutori, ma anche un monito per Dante.
- Missione del Poeta: L’esilio, pur doloroso, è funzionale alla missione di Dante: separato dalla sua città, potrà vedere la verità e denunciarla senza condizionamenti.
- La Corruzione di Firenze: La critica alla città natale è ripresa e approfondita, con l’accusa di aver “merca[to]” Cristo.
- Solidarietà e Benefattori: Nonostante l’amarezza dell’esilio, Dante troverà rifugio e sostegno in figure nobili e generose.
6. Stile e Linguaggio
- Tono Drammatico e Patetico: Il tono è carico di tensione emotiva, soprattutto nella descrizione delle sofferenze dell’esilio.
- Linguaggio Diretto e Preciso: Cacciaguida utilizza un linguaggio chiaro e senza ambiguità, in contrasto con le profezie oscure dei canti precedenti.
- Similitudini: La similitudine di Fetonte e quella di Ippolito elevano il destino personale di Dante a un livello mitologico e universale.
- Immagini Concrete: La descrizione del “pane altrui” e delle “altrui scale” è di una concretezza vivida e dolorosa.
- Apostrofi: L’apostrofe iniziale di Dante a Cacciaguida e l’esortazione di Beatrice.
- Latinismi: L’uso del latino nel saluto di Cacciaguida e nella spiegazione della contingenza conferisce solennità e un’aura di dottrina.
- Terzine Incatenate: La forma metrica è quella dell’intera Commedia.
Conclusione
Il Canto XVII del Paradiso è un momento epifanico per Dante, in cui il suo destino personale si intreccia indissolubilmente con la sua missione poetica e profetica. La profezia dell’esilio, pronunciata con chiarezza e affetto da Cacciaguida, non è solo una condanna, ma anche una purificazione necessaria. L’amarezza della perdita e dell’umiliazione si accompagna alla consapevolezza della propria dignità e della necessità di denunciare la corruzione. Questo canto segna la piena accettazione da parte di Dante del suo ruolo di testimone e di voce della verità, un ruolo che lo porterà a scrivere la Commedia come atto di giustizia e di redenzione, non solo personale ma universale.

Testo originale di Paradiso, Canto XVII, vv. 1-78 di Dante Alighieri
Dante Alighieri – Divina Commedia
Paradiso – Canto XVII (vv. 1-78)
(Cacciaguida rivela a Dante il suo futuro esilio e lo incoraggia a comporre la Commedia)
Testo e ripartizione tematica
1. Dante chiede chiarimenti sul suo futuro (vv. 1-27)
1-6
(Similitudine mitologica: Fetonte e sua madre Climene)
«Qual venne a Climenè, per accertarsi
di ciò ch’avëa incontro a sé udito,
quei ch’ancor fa li padri ai figli scarsi;
tal era io, e tal era sentito
e da Beatrice e da la santa lampa
che pria per me avea mutato sito.»
-
Chiave: Dante, come Fetonte, cerca conferme sul suo destino.
7-12
(Beatrice lo esorta a esprimere i suoi dubbi:)
«Manda fuor la vampa del tuo disio…
non perché nostra conoscenza cresca
ma perché t’ausi a dir la sete…»
-
Metafora: Il “disio” di Dante come fiamma da liberare.
19-27
(Dante chiede a Cacciaguida di spiegargli le profezie sul suo esilio:)
«dette mi fuor di mia vita futura
parole gravi…
per che la voglia mia saria contenta
d’intender qual fortuna mi s’appressa…»
-
Tema: La “saetta previsa” (male previsto) fa meno male.
2. Cacciaguida risponde senza ambiguità (vv. 28-42)
28-33
(Contrapposizione agli oracoli pagani:)
«Né per ambage… ma per chiare parole
rispuose quello amor paterno…»
-
Riferimento: Gli oracoli antichi (es. Delfi) usavano enigmi (“ambage”), mentre Cacciaguida parla chiaro.
34-42
(Spiegazione teologica della provvidenza:)
«La contingenza… tutta è dipinta nel cospetto etterno»
-
Concetto: Dio vede il futuro umano come un riflesso immediato (similitudine della nave nel torrente).
3. La profezia dell’esilio (vv. 43-78)
43-48
(Dante dovrà lasciare Firenze, come Ippolito da Atene:)
«Qual si partio Ipolito d’Atene
per la spietata noverca…
tal di Fiorenza partir ti convene.»
-
Mito: Ippolito, cacciato dalla matrigna Fedra, prefigura l’ingiustizia dell’esilio.
49-57
(La colpa dei fiorentini e la vendetta divina:)
«La colpa seguirà la parte offensa
in grido… ma la vendetta
fia testimonio al ver che la dispensa.»
-
Profezia politica: I nemici di Dante saranno puniti dalla storia.
58-69
(Durezza dell’esilio:)
«Tu lascerai ogne cosa diletta…
proverai sì come sa di sale
lo pane altrui…
e quel che più ti graverà le spalle,
sarà la compagnia malvagia e scempia…»
-
Metafore:
-
“Pane altrui”: Amarezza della dipendenza.
-
“Scale altrui”: Umiliazione del chiedere ospitalità.
-
70-78
(Il primo rifugio: Bartolomeo della Scala a Verona:)
«Lo primo tuo refugio e ’l primo ostello
sarà la cortesia del gran Lombardo
(…) che ’n su la scala porta il santo uccello»
-
Storico: Bartolomeo della Scala (signore di Verona) protesse Dante.
-
Simbolo: L’aquila (“santo uccello”) sugli stemmi scaligeri.
Temi principali
-
Preveggenza divina (vv. 34-42): Dio conosce il futuro contingente senza determinarlo.
-
Esilio come prova (vv. 55-69): Sofferenza ma anche purificazione morale.
-
Missione poetica (implicita): La Commedia sarà la risposta all’ingiustizia.
Figure retoriche
-
Similitudini: Fetonte (vv. 1-3), Ippolito (v. 46), nave nel torrente (vv. 37-39).
-
Metafore: “Saetta previsa” (v. 27), “pane altrui” (v. 59), “scale altrui” (v. 60).
-
Antitesi: Firenze ingrata vs. Verona ospitale.
Contesto storico
-
Esilio di Dante (1302): Condannato dai Guelfi Neri, trovò accoglienza presso varie corti nord-italiane.
-
Critica alla Firenze corrotta: Ricorrente in Paradiso (cfr. Canti XV-XVI).