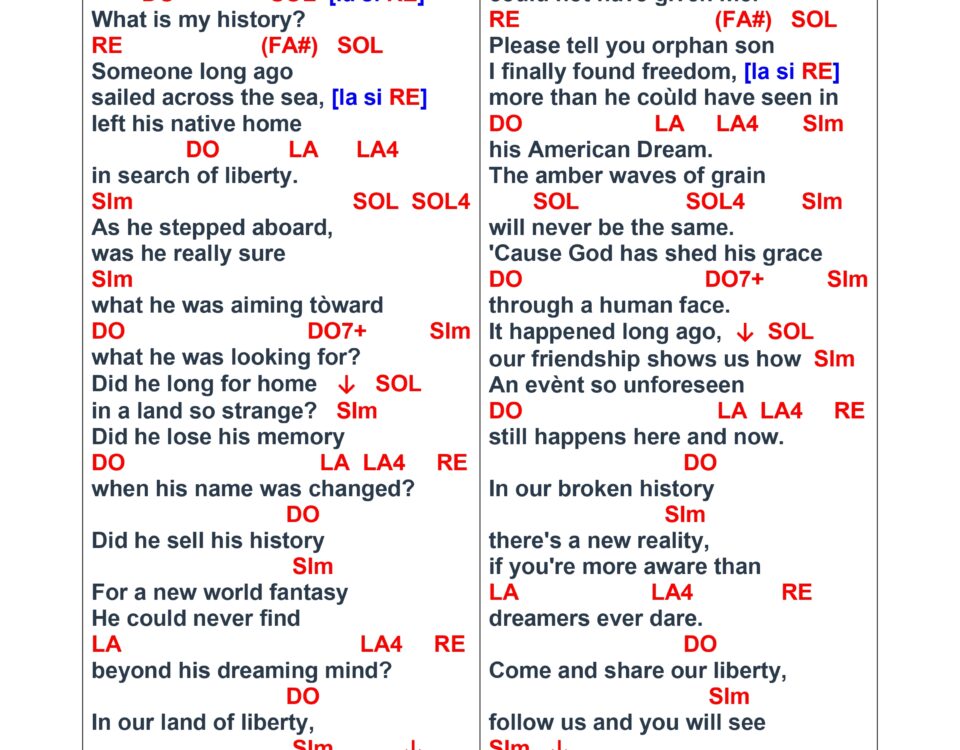Capitolo trentacinquesimo dei Promessi Sposi
28 Dicembre 2019
Capitolo trentatreesimo dei Promessi Sposi
28 Dicembre 2019Riassunto, analisi, commento e testo del capitolo trentaquattresimo de I Promessi Sposi (1840) di Alessandro Manzoni
Capitolo Trentaquattresimo
Il Capitolo XXXIV de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni è uno dei più drammatici e memorabili del romanzo, poiché descrive l’ingresso di Renzo in una Milano devastata dalla peste. Il capitolo è un affresco realistico e commovente degli orrori dell’epidemia, della follia collettiva e della profonda desolazione che ha colpito la città. È un momento di prova estrema per Renzo, che si trova di fronte a uno spettacolo di morte e disumanizzazione.
Sinossi della Trama
Renzo, giunto alle porte di Milano, è consapevole degli ordini severissimi che vietano l’ingresso senza la “bulletta di sanità”, ma sa anche che, di fatto, è possibile entrare. Il suo piano è di tentare la prima porta che incontra e, in caso di intoppo, proseguire lungo le mura.
Arrivato sotto le mura, Renzo si ferma, osservando la desolazione: fumo denso di vestiti e masserizie infette che bruciano, aria pesante, cielo coperto, campagna arida. La solitudine e il silenzio, così vicini a una grande città, lo riempiono di costernazione.
Prende una strada a caso, dirigendosi verso Porta Nuova. Sente un tintinnio di campanelli e voci, e, superato un baluardo, vede una guardia stanca e trascurata. La porta è aperta, ma bloccata da una barella su cui due monatti caricano il corpo del capo dei gabellieri, appena colpito dalla peste. Renzo, approfittando della situazione, offre un mezzo ducatone alla guardia, che lo lascia passare.
Appena entrato, un altro gabelliere lo richiama, ma Renzo finge di non sentire e prosegue. Incontra un cittadino che, scambiandolo per un untore, lo minaccia con un bastone e lo scaccia. Renzo, pur irritato, non reagisce, pensando di non voler litigare. Il cittadino, tornato a casa, racconta di aver scampato un untore, rafforzando la paranoia collettiva.
Renzo prosegue il suo cammino attraverso una Milano desolata e silenziosa. Incontra un cadavere sformato e poi una povera donna con dei bambini, chiusa in casa perché sospetta di peste. La donna lo implora di avvertire il commissario, poiché da un giorno non hanno cibo. Renzo, commosso, le offre i due pani che aveva con sé, ricordando i pani trovati durante la sua precedente fuga da Milano, e pensando che questa è una vera opera di misericordia.
Chiede alla donna indicazioni per la casa dei signori dove Lucia era a servizio (casa ***, ovvero di Don Ferrante e Donna Prassede), ma lei non sa indicargliela con precisione. Renzo prosegue, sentendo un rumore crescente di ruote, cavalli e campanelli. Arrivato in piazza San Marco, vede l’abbominevole macchina della tortura (la gogna), eretta in varie piazze per punire chiunque fosse ritenuto colpevole di trasgressione.
Poco dopo, vede arrivare un convoglio di carri funebri, carichi di cadaveri nudi o mal coperti, spinti dai monatti con frustate e bestemmie. È uno spettacolo orribile di morte e disumanizzazione. Un pensiero atroce balena nella mente di Renzo: “forse là, là insieme, là sotto… Oh, Signore! fate che non sia vero!”.
Superato il convoglio, Renzo prosegue e incontra un prete che ha appena finito di confessare. Gli chiede indicazioni per la casa di Don Ferrante. Il prete, pur con cautela, gliele fornisce. Renzo, pur avendo ottenuto le informazioni, è colto da una nuova ansia all’idea di essere vicino alla meta, dove potrebbe scoprire la sorte di Lucia.
Il cammino di Renzo lo porta attraverso il “carrobio di porta Nuova”, una zona desolata e fetida, dove i pochi abitanti rimasti sono fuggiti. La città è un luogo di morte: porte inchiodate, sigillate o segnate con croci di carbone. Per strada, cenci, fasce marciose, strame ammorbato e cadaveri. Il silenzio è rotto solo dai carri funebri, dai lamenti degli infermi e dalle grida dei monatti. La gente si muove con precauzione, evitando il contatto, coprendosi il naso con pasticche odorose o boccette di mercurio. Tutti sono trasandati, con barbe e capelli lunghi, per il sospetto verso i barbieri, uno dei quali era stato condannato come untore. L’ignoranza e la paura hanno sostituito la ragione.
Renzo giunge in una delle strade più larghe e vede quattro carri fermi, con monatti che entrano ed escono dalle case, caricando corpi. Il rumore è un misto di grida lugubri e bestemmie. In mezzo a questo orrore, Renzo si ferma, colpito da una scena di profonda pietà: una donna, con un aspetto di “bellezza velata e offuscata”, porta in braccio una bambina morta, vestita di bianco come per una festa. La tiene come se fosse viva, con una tenerezza che commuove Renzo.
Un monatto si avvicina per prendere la bambina, ma la madre si ritrae, chiedendogli di non toccarla. Gli offre del denaro in cambio della promessa di non spogliare la bambina e di seppellirla così com’è. Il monatto accetta, e la madre, dopo averle dato un ultimo bacio, la depone sul carro, dicendo: “addio, Cecilia! riposa in pace! Stasera verremo anche noi, per restar sempre insieme. Prega intanto per noi; ch’io pregherò per te e per gli altri”. Poi rientra in casa, e dalla finestra si affaccia con un’altra bambina, viva ma con i segni della morte, per morire con lei. Renzo, sconvolto, prega Dio di accoglierle.
Proseguendo, Renzo incontra un altro convoglio di ammalati condotti al lazzeretto, spinti dai monatti. Tra la confusione, si vedono esempi di fermezza e pietà, con familiari che accompagnano i malati. Renzo, con l’ansia crescente, domanda a un monatto la strada per la casa di Don Ferrante, ma riceve una risposta volgare. Chiede allora a un commissario, che gliela indica.
Con il cuore in gola, Renzo giunge al portone della casa di Don Ferrante. Bussa, e una donna si affaccia alla finestra, con un viso sospettoso. Renzo chiede di Lucia, e la donna risponde: “La non c’è più; andate”. Poi, alla domanda di Renzo, aggiunge: “Al lazzeretto; con la peste”. La finestra si chiude, lasciando Renzo afflitto e disperato. Tenta di richiamare la donna, ma invano. Vede un’altra donna che, scambiandolo per un untore, tenta di richiamare gente per farlo catturare, ma poi si arrende e fugge.
Analisi del Capitolo
Il Capitolo XXXIV è un’immersione totale nell’orrore della peste a Milano, un momento di grande realismo storico e di profonda commozione.
- La Peste come Flagello Totale: Manzoni descrive la peste non solo come una malattia, ma come un flagello che distrugge ogni aspetto della vita civile e morale. La città è deserta, le strade sono piene di cadaveri e sporcizia, la giustizia è sospesa (simboleggiata dalla gogna, strumento di tortura), e la paura genera paranoia (gli untori) e disumanizzazione.
- La Follia Collettiva e la Disumanizzazione: La paura della peste ha reso gli animi “insalvatichiti”, portando alla dimenticanza della pietà e del riguardo sociale. La gente si guarda con sospetto, si evitano, e i monatti, figure grottesche e blasfeme, rappresentano il culmine di questa disumanizzazione. L’episodio del cittadino che scambia Renzo per un untore è un esempio lampante della paranoia diffusa.
- Il Viaggio di Renzo: Un’Odissea nella Morte: Il percorso di Renzo attraverso Milano è un’odissea nella morte. Egli è un testimone impotente degli orrori, un “viaggiatore” che attraversa un paesaggio apocalittico. La sua ricerca di Lucia è l’unico filo di speranza in un mondo di desolazione.
- La Figura della Madre di Cecilia: Questo è uno dei momenti più commoventi e celebri del romanzo. La madre di Cecilia incarna la dignità, la tenerezza e la forza dell’amore materno di fronte alla morte. Il suo gesto di adornare la figlia morta e le sue ultime parole (“Stasera verremo anche noi, per restar sempre insieme”) sono un’espressione sublime di pietà e di fede nella ricongiunzione ultraterrena. Questa scena, pur nella sua tragicità, è un inno alla carità e alla dignità umana che resistono anche nell’orrore.
- La Carità e la Speranza: Nonostante la desolazione, Manzoni inserisce momenti di carità e di speranza, come il gesto di Renzo che offre i pani alla donna chiusa in casa, o gli esempi di familiari che accompagnano i malati al lazzeretto. Questi gesti, pur piccoli, mostrano che la pietà umana non è del tutto estinta.
- Il Ruolo della Provvidenza: Anche in questo capitolo di estrema sofferenza, la Provvidenza è presente. La salvezza di Renzo all’ingresso in città, la sua capacità di trovare aiuto e informazioni, e la sua stessa sopravvivenza, sono segni di un disegno superiore che lo guida.
- Il Colpo di Scena Finale: La notizia che Lucia è al lazzeretto, e malata di peste, è un colpo di scena drammatico che riaccende l’angoscia di Renzo e del lettore. La sua ricerca non è finita, ma si è trasformata in una corsa contro il tempo e contro la morte.
Commento
Il Capitolo XXXIV è un capolavoro di realismo e di pathos. Manzoni, con la sua prosa vivida e dettagliata, riesce a trasportare il lettore nel cuore della Milano appestata, rendendo tangibile l’orrore dell’epidemia. La descrizione della città, dei suoi abitanti e delle loro reazioni è un affresco storico di grande potenza.
La scena della madre di Cecilia è un momento di altissima liricità e di profonda commozione, che eleva il romanzo a vette di universalità. Essa rappresenta la capacità dell’amore e della dignità umana di resistere anche di fronte alla tragedia più grande.
Il viaggio di Renzo è un percorso di iniziazione e di prova. Egli si confronta con la morte, la follia e la disumanizzazione, ma mantiene la sua integrità morale e la sua fede. La sua ricerca di Lucia, che si conclude con la terribile notizia della sua malattia, lo spinge verso una nuova e più disperata fase della sua odissea.
In sintesi, il Capitolo XXXIV è un capitolo fondamentale che, pur nella sua tragicità, mostra la capacità dell’uomo di resistere all’orrore e di mantenere la propria umanità, e prepara il terreno per il culmine drammatico della vicenda nel lazzeretto.
Testo del CAPITOLO XXXIV
CAPITOLO XXXIV

CAPITOLO XXXIV.
In quanto alla maniera di penetrare in città, Renzo aveva sentito, così all’ingrosso, che c’eran ordini severissimi di non lasciar entrar nessuno, senza bulletta di sanità; ma che in vece ci s’entrava benissimo, chi appena sapesse un po’ aiutarsi e cogliere il momento. Era infatti così; e lasciando anche da parte le cause generali, per cui in que’ tempi ogni ordine era poco eseguito; lasciando da parte le speciali, che rendevano così malagevole la rigorosa esecuzione di questo; Milano si trovava ormai in tale stato, da non veder cosa giovasse guardarlo, e da cosa; e chiunque ci venisse, poteva parer piuttosto noncurante della propria salute, che pericoloso a quella de’ cittadini.Su queste notizie, il disegno di Renzo era di tentare d’entrar dalla prima porta a cui si fosse abbattuto; se ci fosse qualche intoppo, riprender le mura di fuori, finchè ne trovasse un’altra di più facile accesso. E sa il cielo quante porte s’immaginava che Milano dovesse avere. Arrivato dunque sotto le mura, si fermò a guardar d’intorno, come fa chi, non sapendo da che parte gli convenga di prendere, par che n’aspetti, e ne chieda qualche indizio da ogni cosa. Ma, a destra e a sinistra, non vedeva che due pezzi d’una strada storta; dirimpetto, un tratto di mura; da nessuna parte, nessun segno d’uomini viventi: se non che, da un certo punto del terrapieno, s’alzava una colonna d’un fumo oscuro e denso, che salendo s’allargava e s’avvolgeva in ampi globi, perdendosi poi nell’aria immobile e bigia. Eran vestiti, letti e altre masserizie infette che si bruciavano: e di tali triste fiammate se ne faceva di continuo, non lì soltanto, ma in varie parti delle mura.
Il tempo era chiuso, l’aria pesante, il cielo velato per tutto da una nuvola o da un nebbione uguale, inerte, che pareva negare il sole, senza prometter la pioggia; la campagna d’intorno, parte incolta, e tutta arida; ogni verzura scolorita, e neppure una gocciola di rugiada sulle foglie passe e cascanti. Per di più, quella solitudine, quel silenzio, così vicino a una gran città, aggiungevano una nuova costernazione all’inquietudine di Renzo, e rendevan più tetri tutti i suoi pensieri.
Stato lì alquanto, prese la diritta, alla ventura, andando, senza saperlo, verso porta Nuova, della quale, quantunque vicina, non poteva accorgersi, a cagione d’un baluardo, dietro cui era allora nascosta. Dopo pochi passi, principiò a sentire un tintinnìo di campanelli, che cessava e ricominciava ogni tanto, e poi qualche voce d’uomo. Andò avanti e, passato il canto del baluardo, vide per la prima cosa, un casotto di legno, e sull’uscio, una guardia appoggiata al moschetto, con una cert’aria stracca e trascurata: dietro c’era uno stecconato, e dietro quello, la porta, cioè due alacce di muro, con una tettoia sopra, per riparare i battenti; i quali erano spalancati, come pure il cancello dello stecconato. Però, davanti appunto all’apertura, c’era in terra un tristo impedimento: una barella, sulla quale due monatti accomodavano un poverino, per portarlo via. Era il capo de’ gabellieri, a cui, poco prima, s’era scoperta la peste. Renzo si fermò, aspettando la fine: partito il convoglio, e non venendo nessuno a richiudere il cancello, gli parve tempo, e ci s’avviò in fretta; ma la guardia, con una manieraccia, gli gridò: “olà!” Renzo si fermò di nuovo su due piedi, e, datogli d’occhio, tirò fuori un mezzo ducatone, e glielo fece vedere. Colui, o che avesse già avuta la peste, o che la temesse meno di quel che amava i mezzi ducatoni, accennò a Renzo che glielo buttasse; e vistoselo volar subito a’ piedi, susurrò: “ va’ innanzi presto.” Renzo non se lo fece dir due volte; passò lo stecconato, passò la porta, andò avanti, senza che nessuno s’accorgesse di lui, o gli badasse; se non che, quando ebbe fatti forse quaranta passi, sentì un altro “olà” che un gabelliere gli gridava dietro. Questa volta, fece le viste di non sentire, e, senza voltarsi nemmeno, allungò il passo. – Olà! – gridò di nuovo il gabelliere, con una voce però che indicava più impazienza che risoluzione di farsi ubbidire; e non essendo ubbidito, alzò le spalle, e tornò nella sua casaccia, come persona a cui premesse più di non accostarsi troppo ai passeggieri, che d’informarsi de’ fatti loro.
La strada che Renzo aveva presa, andava allora, come adesso, diritta fino al canale detto il Naviglio: i lati erano siepi o muri d’orti, chiese e conventi, e poche case. In cima a questa strada, e nel mezzo di quella che costeggia il canale, c’era una colonna, con una croce detta la croce di sant’Eusebio. E per quanto Renzo guardasse innanzi, non vedeva altro che quella croce. Arrivato al crocicchio che divide la strada circa alla metà, e guardando dalle due parti, vide a dritta, in quella strada che si chiama lo stradone di santa Teresa, un cittadino che veniva appunto verso di lui. — Un cristiano, finalmente! — disse tra sè; e si voltò subito da quella parte, pensando di farsi insegnar la strada da lui. Questo pure aveva visto il forestiero che s’avanzava; e andava squadrandolo da lontano, con uno sguardo sospettoso; e tanto più, quando s’accorse che, in vece d’andarsene per i fatti suoi, gli veniva incontro. Renzo, quando fu poco distante, si levò il cappello, da quel montanaro rispettoso che era; e tenendolo con la sinistra, mise l’altra mano nel cocuzzolo, e andò più direttamente verso lo sconosciuto. Ma questo, stralunando gli occhi affatto, fece un passo addietro, alzò un noderoso bastone, e voltata la punta, ch’era di ferro, alla vita di Renzo, gridò: “via! via! via!”

“Oh oh!” gridò il giovine anche lui; rimise il cappello in testa, e, avendo tutt’altra voglia, come diceva poi, quando raccontava la cosa, che di metter su lite in quel momento, voltò le spalle a quello stravagante, e continuò la sua strada, o, per meglio dire, quella in cui si trovava avviato.
L’altro tirò avanti anche lui per la sua, tutto fremente, e voltandosi, ogni momento, indietro. E arrivato a casa, raccontò che gli s’era accostato un untore, con un’aria umile, mansueta, con un viso d’infame impostore, con lo scatolino dell’unto, o l’involtino della polvere (non era ben certo qual de’ due) in mano, nel cocuzzolo del cappello, per fargli il tiro, se lui non l’avesse saputo tener lontano. “Se mi s’accostava un passo di più,” soggiunse, “l’infilavo addirittura, prima che avesse tempo d’accomodarmi me, il birbone. La disgrazia fu ch’eravamo in un luogo così solitario, ché se era in mezzo Milano, chiamavo gente, e mi facevo aiutare a acchiapparlo. Sicuro che gli si trovava quella scellerata porcheria nel cappello. Ma lì da solo a solo, mi son dovuto contentare di fargli paura, senza risicare di cercarmi un malanno; perchè un po’ di polvere è subito buttata; e coloro hanno una destrezza particolare; e poi hanno il diavolo dalla loro. Ora sarà in giro per Milano: chi sa che strage fa! E fin che visse, che fu per molt’anni, ogni volta che si parlasse d’untori, ripeteva la sua storia, e soggiungeva: “quelli che sostengono ancora che non era vero, non lo vengano a dire a me; perchè le cose bisogna averle viste.”
Renzo, lontano dall’immaginarsi come l’avesse scampata bella, e agitato più dalla rabbia che dalla paura, pensava, camminando, a quell’accoglienza, e indovinava bene a un di presso ciò che lo sconosciuto aveva pensato di lui; ma la cosa gli pareva così irragionevole, che concluse tra sè che colui doveva essere un qualche mezzo matto. — La principia male, — pensava però: — par che ci sia un pianeta per me, in questo Milano. Per entrare, tutto mi va a seconda; e poi, quando ci son dentro, trovo i dispiaceri lì apparecchiati. Basta… coll’aiuto di Dio… se trovo… se ci riesco a trovare… eh! tutto sarà stato niente. —
Arrivato al ponte, voltò, senza esitare, a sinistra, nella strada di san Marco, parendogli, a ragione, che dovesse condurre verso l’interno della città. E andando avanti, guardava in qua e in là, per veder se poteva scoprire qualche creatura umana; ma non ne vide altra che uno sformato cadavere nel piccol fosso che corre tra quelle poche case (che allora erano anche meno), e un pezzo della strada. Passato quel pezzo, sentì gridare: “o quell’uomo!” e guardando da quella parte, vide poco lontano, a un terrazzino d’una casuccia isolata, una povera donna, con una nidiata di bambini intorno; la quale, seguitandolo a chiamare, gli fece cenno anche con la mano. Ci andò di corsa; e quando fu vicino, “o quel giovine,” disse quella donna: “per i vostri poveri morti, fate la carità d’andare a avvertire il commissario che siamo qui dimenticati. Ci hanno chiusi in casa come sospetti, perchè il mio povero marito è morto; ci hanno inchiodato l’uscio, come vedete; e da ier mattina, nessuno è venuto a portarci da mangiare. In tante ore che siam qui, non m’è mai capitato un cristiano che me la facesse questa carità: e questi poveri innocenti moion di fame.”
“Di fame!” esclamò Renzo; e, cacciate le mani nelle tasche, “ecco, ecco,” disse, tirando fuori i due pani: “calatemi giù qualcosa da metterli dentro.”
“ Dio ve ne renda merito; aspettate un momento,” disse quella donna; e andò a cercare un paniere, e una fune da calarlo, come fece. A Renzo intanto gli vennero in mente que’ pani che aveva trovati vicino alla croce, nell’altra sua entrata in Milano, e pensava: — ecco: è una restituzione, e forse meglio che se gli avessi restituiti al proprio padrone: perchè qui è veramente un’opera di misericordia. —
“In quanto al commissario che dite, la mia donna,” disse poi, mettendo i pani nel paniere, “io non vi posso servire in nulla; perchè, per dirvi la verità, son forestiero, e non son niente pratico di questo paese. Però, se incontro qualche uomo un po’ domestico e umano, da potergli parlare, lo dirò a lui.”

La donna lo pregò che facesse così, e gli disse il nome della strada, onde lui sapesse indicarla.
“Anche voi,” riprese Renzo, “credo che potrete farmi un piacere, una vera carità, senza vostro incomodo. Una casa di cavalieri, di gran signoroni, qui di Milano, casa *** sapreste insegnarmi dove sia?”
“So che la c’è questa casa”, rispose la donna: “ma dove sia, non lo so davvero. Andando avanti di qua, qualcheduno che ve la insegni, lo troverete. E ricordatevi di dirgli anche di noi.”
“Non dubitate,” disse Renzo, e andò avanti.
A ogni passo, sentiva crescere e avvicinarsi un rumore che già aveva cominciato a sentire mentre era lì fermo a discorrere: un rumor di ruote e di cavalli, con un tintinnìo di campanelli, e ogni tanto un chioccar di fruste, con un accompagnamento d’urli. Guardava innanzi, ma non vedeva nulla. Arrivato allo sbocco di quella strada, scoprendosegli davanti la piazza di san Marco, la prima cosa che gli diede nell’occhio, furon due travi ritte, con una corda, e con certe carrucole; e non tardò a riconoscere (ch’era cosa famigliare in quel tempo) l’abbominevole macchina della tortura. Era rizzata in quel luogo, e non in quello soltanto, ma in tutte le piazze e nelle strade più spaziose, affinchè i deputati d’ogni quartiere, muniti a questo d’ogni facoltà più arbitraria, potessero farci applicare immediatamente chiunque paresse loro meritevole di pena: o sequestrati che uscissero di casa, o subalterni che non facessero il loro dovere, o chiunque altro. Era uno di que’ rimedi eccessivi e inefficaci de’ quali, a quel tempo, e in que’ momenti specialmente, si faceva tanto scialacquìo.
Ora, mentre Renzo guarda quello strumento, pensando perchè possa essere alzato in quel luogo, sente avvicinarsi sempre più il rumore, e vede spuntar dalla cantonata della chiesa un uomo che scoteva un campanello: era un apparitore; e dietro a lui due cavalli che, allungando il collo, e puntando le zampe, venivano avanti a fatica; e strascinato da quelli, un carro di morti, e dopo quello un altro, e poi un altro e un altro; e di qua e di là, monatti alle costole de’ cavalli, spingendoli, a frustate, a punzoni, a bestemmie. Eran que’ cadaveri, la più parte ignudi, alcuni mal involtati in qualche cencio, ammonticchiati, intrecciati insieme, come un gruppo di serpi che lentamente si svolgano al tepore della primavera; chè, a ogni intoppo, a ogni scossa, si vedevan que’ mucchi funesti tremolare e scompaginarsi bruttamente, e ciondolar teste, e chiome verginali arrovesciarsi, e braccia svincolarsi, e batter sulle rote, mostrando all’occhio già inorridito come un tale spettacolo poteva divenire più doloroso e più sconcio.
Il giovine s’era fermato sulla cantonata della piazza, vicino alla sbarra del canale, e pregava intanto per que’ morti sconosciuti. Un atroce pensiero gli balenò in mente: — forse là, là insieme, là sotto… Oh, Signore! fate che non sia vero! fate ch’io non ci pensi! —
Passato il convoglio funebre, Renzo si mosse, attraversò la piazza, prendendo lungo il canale a mancina, senz’altra ragione della scelta, se non che il convoglio era andato dall’altra parte. Fatti que’ quattro passi tra il fianco della chiesa e il canale, vide a destra il ponte Marcellino; prese di lì, e riuscì in Borgo Nuovo. E guardando innanzi, sempre con quella mira di trovar qualcheduno da farsi insegnar la strada, vide in fondo a quella un prete in farsetto, con un bastoncino in mano, ritto vicino a un uscio socchiuso, col capo chinato, e l’orecchio allo spiraglio; e poco dopo lo vide alzar la mano e benedire. Congetturò quello ch’era di fatto, cioè che finisse di confessar qualcheduno; e disse tra sè: — questo è l’uomo che fa per me. Se un prete, in funzion di prete, non ha un po’ di carità, un po’ d’amore e di buona grazia, bisogna dire che non ce ne sia più in questo mondo. —
Intanto il prete, staccatosi dall’uscio, veniva dalla parte di Renzo, tenendosi, con gran riguardo, nel mezzo della strada. Renzo, quando gli fu vicino, si levò il cappello, e gli accennò che desiderava parlargli, fermandosi nello stesso tempo, in maniera da fargli intendere che non si sarebbe accostato di più.
Quello pure si fermò, in atto di stare a sentire, puntando però in terra il suo bastoncino davanti a sè, come per farsene un baluardo.

Renzo espose la sua domanda, alla quale il prete soddisfece, non solo con dirgli il nome della strada dove la casa era situata, ma dandogli anche, come vide che il poverino n’aveva bisogno, un po’ d’itinerario; indicandogli, cioè, a forza di diritte e di mancine, di chiese e di croci, quell’altre sei o otto strade che aveva da passare per arrivarci.
“Dio la mantenga sano, in questi tempi, e sempre,” disse Renzo: e mentre quello si moveva per andarsene, “un’altra carità,” soggiunse; e gli disse della povera donna dimenticata. Il buon prete ringraziò lui d’avergli dato occasione di fare una carità così necessaria; e, dicendo che andava ad avvertire chi bisognava, tirò avanti. Renzo si mosse anche lui, e, camminando, cercava di fare a se stesso una ripetizione dell’itinerario, per non esser da capo a dover domandare a ogni cantonata. Ma non potreste immaginarvi come quell’operazione gli riuscisse penosa, e non tanto per la difficoltà della cosa in sè, quanto per un nuovo turbamento che gli era nato nell’animo. Quel nome della strada, quella traccia del cammino l’avevan messo così sottosopra. Era l’indizio che aveva desiderato e domandato, e del quale non poteva far di meno; nè gli era stato detto nient’altro, da che potesse ricavare nessun augurio sinistro; ma che volete? quell’idea un po’ più distinta d’un termine vicino, dove uscirebbe d’una grand’incertezza, dove potrebbe sentirsi dire: è viva, o sentirsi dire: è morta; quell’idea l’aveva così colpito che, in quel momento, gli sarebbe piaciuto più di trovarsi ancora ai buio di tutto, d’essere al principio del viaggio, di cui ormai toccava la fine. Raccolse però le sue forze, e disse a se stesso: — ehi! se principiamo ora a fare il ragazzo, com’anderà? — Così rinfrancato alla meglio, seguitò la sua strada, inoltrandosi nella città.
Quale città! e cos’era mai, al paragone, quello ch’era stata l’anno avanti, per cagion della fame!
Renzo s’abbatteva appunto a passare per una delle parti più squallide e più desolate: quella crociata di strade che si chiamava il carrobio di porta Nuova. (C’era allora una croce nel mezzo, e, dirimpetto ad essa, accanto a dove ora è san Francesco di Paola, una vecchia chiesa col titolo di sant’Anastasia). Tanta era stata in quel vicinato la furia del contagio, e il fetor de’ cadaveri lasciati lì che i pochi rimasti vivi erano stati costretti a sgomberare: sicchè, alla mestizia che dava al passeggiero quell’aspetto di solitudine e d’abbandono, s’aggiungeva l’orrore e lo schifo delle tracce e degli avanzi della recente abitazione. Renzo affrettò il passo, facendosi coraggio col pensare che la meta non doveva essere così vicina, e sperando che, prima d’arrivarci, troverebbe mutata, almeno in parte, la scena; e infatti, di lì a non molto, riuscì in un luogo che poteva pur dirsi città di viventi; ma quale città ancora, e quali viventi! Serrati, per sospetto e per terrore, tutti gli usci di strada, salvo quelli che fossero spalancati per esser le case disabitate, o invase; altri inchiodati e sigillati, per esser nelle case morta o ammalata gente di peste; altri segnati d’una croce fatta col carbone, per indizio ai monatti, che c’eran de’ morti da portar via: il tutto più alla ventura che altro, secondo che si fosse trovato piuttosto qua che là un qualche commissario della Sanità o altro impiegato, che avesse voluto eseguir gli ordini, o fare un’angheria. Per tutto cenci e, più ributtanti de’ cenci, fasce marciose, strame ammorbato, o lenzoli buttati dalle finestre; talvolta corpi, o di persone morte all’improvviso, nella strada, e lasciati lì fin che passasse un carro da portarli via, o cascati da’ carri medesimi, o buttati anch’essi dalle finestre: tanto l’insistere e l’imperversar del disastro aveva insalvatichiti gli animi, e fatto dimenticare ogni cura di pietà, ogni, riguardo sociale! Cessato per tutto ogni rumor di botteghe, ogni strepito di carrozze, ogni grido di venditori, ogni chiacchierìo di passeggieri, era ben raro che quel silenzio di morte fosse rotto da altro che da rumor di carri funebri, da lamenti di poveri, da rammarichìo d’infermi, da urli di frenetici, da grida di monatti. All’alba, a mezzogiorno, a sera, una campana del duomo dava il segno di recitar certe preci assegnate dall’arcivescovo: a quel tocco rispondevan le campane dell’altre chiese; e allora avreste veduto persone affacciarsi alle finestre, a pregare in comune; avreste sentito un bisbiglio di voci e di gemiti, che spirava una tristezza mista pure di qualche conforto.
Morti a quell’ora forse i due terzi de’ cittadini, andati via o ammalati una buona parte del resto, ridotto quasi a nulla il concorso della gente di fuori, de’ pochi che andavan per le strade, non se ne sarebbe per avventura, in un lungo giro, incontrato uno solo in cui non si vedesse qualcosa di strano, e che dava indizio d’una funesta mutazione di cose. Si vedevano gli uomini più qualificati, senza cappa nè mantello, parte allora essenzialissima del vestiario civile; senza sottana i preti, e anche de’ religiosi in farsetto; dismessa in somma ogni sorte di vestito che potesse con gli svolazzi toccar qualche cosa, o dare (ciò che si temeva più di tutto il resto) agio agli untori. E fuor di questa cura d’andar succinti e ristretti il più che fosse possibile, negletta e trasandata ogni persona; lunghe le barbe di quelli che usavan portarle, cresciute a quelli che prima costumavan di raderle; lunghe pure e arruffate le capigliature, non solo per quella trascuranza che nasce da un invecchiato abbattimento, ma per esser divenuti sospetti i barbieri, da che era stato preso e condannato, come untor famoso, uno di loro, Giangiacomo Mora: nome che, per un pezzo, conservò una celebrità municipale d’infamia, e ne meriterebbe una ben più diffusa e perenne di pietà. I più tenevano da una mano un bastone, alcuni anche una pistola, per avvertimento minaccioso a chi avesse voluto avvicinarsi troppo; dall’altra pasticche odorose, o palle di metallo o di legno traforate, con dentro spugne inzuppate d’aceti medicati; e se le andavano ogni tanto mettendo al naso, o ce le tenevano di continuo. Portavano alcuni attaccata al collo una boccetta con dentro un po’ d’argento vivo, persuasi che avesse la virtù d’assorbire e di ritenere ogni esalazione pestilenziale; e avevan poi cura di rinnovarlo ogni tanti giorni. I gentiluomini, non solo uscivano senza il solito seguito, ma si vedevano, con una sporta in braccio, andare a comprar le cose necessarie al vitto. Gli amici, quando pur due s’incontrassero per la strada, si salutavan da lontano, con cenni taciti e frettolosi.

Ognuno, camminando, aveva molto da fare, per iscansare gli schifosi e mortiferi inciampi di cui il terreno era sparso e, in qualche luogo, anche affatto ingombro: ognuno cercava di stare in mezzo alla strada, per timore d’altro sudiciume, o d’altro più funesto peso che potesse venir giù dalle finestre; per timore delle polveri venefiche che si diceva esser spesso buttate da quelle su’ passeggieri; per timore delle muraglie, che potevan esser unte. Così l’ignoranza, coraggiosa e guardinga alla rovescia, aggiungeva ora angustie all’angustie, e dava falsi terrori, in compenso de’ ragionevoli e salutari che aveva levati da principio.
Tal era ciò che di meno deforme e di men compassionevole si faceva vedere intorno, i sani, gli agiati: chè, dopo tante immagini di miseria, e pensando a quella ancor più grave, per mezzo alla quale dovrem condurre il lettore, non ci fermeremo ora a dir qual fosse lo spettacolo degli appestati che si strascicavano o giacevano per le strade, de’ poveri, de’ fanciulli, delle donne. Era tale, che il riguardante poteva trovar quasi un disperato conforto in ciò che ai lontani e ai posteri fa la più forte e dolorosa impressione; nel pensare, dico, nel vedere quanto que’ viventi fossero ridotti a pochi.
In mezzo a questa desolazione aveva Renzo fatto già una buona parte del suo cammino, quando, distante ancor molti passi da una strada in cui doveva voltare, sentì venir da quella un vario frastono, nel quale si faceva distinguere quel solito orribile tintinnìo.
Arrivato alla cantonata della strada, ch’era una delle più larghe, vide quattro carri fermi nel mezzo; e come, in un mercato di granaglie, si vede un andare e venire di gente, un caricare e un rovesciar di sacchi, tale era il movimento in quel luogo: monatti ch’entravan nelle case, monatti che n’uscivan con un peso su le spalle, e lo mettevano su l’uno o l’altro carro: alcuni con la divisa rossa, altri senza quel distintivo, molti con uno ancor più odioso, pennacchi e fiocchi di vari colori, che quegli sciagurati portavano come per segno d’allegria, in tanto pubblico lutto. Ora da una, ora da un’altra finestra, veniva una voce lugubre: “qua, monatti!” E con suono ancor più sinistro, da quel tristo brulichìo usciva qualche vociaccia che rispondeva: “ora, ora.” Ovvero eran pigionali che brontolavano, e dicevano di far presto: ai quali i monatti rispondevano con bestemmie.
Entrato nella strada, Renzo allungò il passo, cercando di non guardar quegl’ingombri, se non quanto era necessario per iscansarli; quando il suo sguardo s’incontrò in un oggetto singolare di pietà, d’una pietà che invogliava l’animo a contemplarlo; di maniera che si fermò, quasi senza volerlo.
Scendeva dalla soglia d’uno di quegli usci, e veniva verso il convoglio, una donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa; e vi traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non guasta, da una gran passione, e da un languor mortale: quella bellezza molle a un tempo e maestosa, che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era affaticata, ma non cascante; gli occhi non davan lacrime, ma portavan segno d’averne sparse tante; c’era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo, che attestava un’anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che, tra tante miserie, la indicasse così particolarmente alla pietà, e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito ne’ cuori. Portava essa in collo una bambina di forse nov’anni, morta; ma tutta ben accomodata, co’ capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l’avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo, e data per premio. Nè la teneva a giacere, ma sorretta, a sedere sur un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva; se non che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una parte, con una certa inanimata gravezza, e il capo posava sull’omero della madre, con un abbandono più forte del sonno: della madre, chè, se anche la somiglianza de’ volti non n’avesse fatto fede, l’avrebbe detto chiaramente quello de’ due ch’esprimeva ancora un sentimento.
Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però d’insolito rispetto, con un’esitazione involontaria. Ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo, “no!” disse: “non me la toccate per ora; devo metterla io su quel carro: prendete.” Così dicendo, aprì una mano, fece vedere una borsa, e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò: “promettetemi di non levarle un filo d’intorno, né di lasciar che altri ardisca di farlo, e di metterla sotto terra così.”Il monatto si mise una mano al petto; e poi, tutto premuroso, e quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato, che per l’inaspettata ricompensa, s’affaccendò a far un po’ di posto sul carro per la morticina. La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come sur un letto, ce l’accomodò, le stese sopra un panno bianco, e disse l’ultime parole: “addio, Cecilia! riposa in pace! Stasera verremo anche noi, per restar sempre insieme. Prega intanto per noi; ch’io pregherò per te e per gli altri.” Poi voltatasi di nuovo al monatto, “voi,” disse, “passando di qui verso sera, salirete a prendere anche me, e non me sola.”
Così detto, rientrò in casa, e, un momento dopo, s’affacciò alla finestra, tenendo in collo un’altra bambina più piccola, viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne esequie della prima, finché il carro non si mosse, finché lo poté vedere; poi disparve. E che altro poté fare, se non posar sul letto l’unica che le rimaneva, e mettersele accanto per morire insieme? come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccia, al passar della falce che pareggia tutte l’erbe del prato.
“O Signore!” esclamò Renzo: “esauditela! tiratela a voi, lei e la sua creaturina: hanno patito abbastanza! hanno patito abbastanza!”
Riavuto da quella commozione straordinaria, e mentre cerca di tirarsi in mente l’itinerario per trovare se alla prima strada deve voltare, e se a diritta o a mancina, sente anche da questa venire un altro e diverso strepito, un suono confuso di grida imperiose, di fiochi lamenti, un pianger di donne, un mugolìo di fanciulli.
Andò avanti, con in cuore quella solita trista e oscura aspettativa. Arrivato al crocicchio, vide da una parte una moltitudine confusa che s’avanzava, e si fermò lì, per lasciarla passare. Erano ammalati che venivan condotti al lazzeretto; alcuni, spinti a forza, resistevano in vano, in vano gridavano che volevan morire sul loro letto, e rispondevano con inutili imprecazioni alle bestemmie e ai comandi de’ monatti che li guidavano;

altri camminavano in silenzio, senza mostrar dolore, nè alcun altro sentimento, come insensati; donne co’ bambini in collo; fanciulli spaventati dalle grida, da quegli ordini, da quella compagnia, più che dal pensiero confuso della morte, i quali ad alte strida imploravano la madre e le sue braccia fidate, e la casa loro. Ahi! e forse la madre, che credevano d’aver lasciata addormentata sul suo letto, ci s’era buttata, sorpresa tutt’a un tratto dalla peste; e stava lì senza sentimento, per esser portata sur un carro al lazzeretto, o alla fossa, se il carro veniva più tardi. Forse, o sciagura degna di lacrime ancor più amare! la madre, tutta occupata de’ suoi patimenti, aveva dimenticato ogni cosa, anche i figli, e non aveva più che un pensiero: di morire in pace. Pure, in tanta confusione, si vedeva ancora qualche esempio di fermezza e di pietà: padri, madri, fratelli, figli, consorti, che sostenevano i cari loro, e gli accompagnavano con parole di conforto: nè adulti soltanto, ma ragazzetti, ma fanciulline che guidavano i fratellini più teneri, e, con giudizio e con compassione da grandi, raccomandavano loro d’essere ubbidienti, gli assicuravano che s’andava in un luogo dove c’era chi avrebbe cura di loro per farli guarire.
In mezzo alla malinconia e alla tenerezza di tali viste, una cosa toccava più sul vivo, e teneva in agitazione il nostro viaggiatore. La casa doveva esser lì vicina, e chi sa se tra quella gente… Ma passata tutta la comitiva, e cessato quel dubbio, si voltò a un monatto che veniva dietro, e gli domandò della strada e della casa di don Ferrante. “In malora, tanghero,” fu la risposta che n’ebbe. Nè si curò di dare a colui quella che si meritava; ma, visto, a due passi, un commissario che veniva in coda al convoglio, e aveva un viso un po’ più di cristiano, fece a lui la stessa domanda. Questo, accennando con un bastone la parte donde veniva, disse: “la prima strada a diritta, l’ultima casa grande a sinistra.”
Con una nuova e più forte ansietà in cuore, il giovine prende da quella parte. È nella strada; distingue subito la casa tra l’altre, più basse e meschine; s’accosta al portone che è chiuso, mette la mano sul martello, e ce la tien sospesa, come in un’urna, prima di tirar su la polizza dove fosse scritta la sua vita, o la sua morte. Finalmente alza il martello, e dà un picchio risoluto.
Dopo qualche momento, s’apre un poco una finestra; una donna fa capolino, guardando chi era, con un viso ombroso che par che dica: monatti? vagabondi? commissari? untori? diavoli?
“Quella signora,” disse Renzo guardando in su, e con voce non troppo sicura: – ci sta qui a servire una giovine di campagna, che ha nome Lucia?
“La non c’è più; andate,” rispose quella donna, facendo atto di chiudere.
“Un momento, per carità! La non c’è più? Dov’è?”
“Al lazzeretto;” e di nuovo voleva chiudere.
“Ma un momento, per l’amor del cielo! Con la peste?”
“Già. Cosa nuova, eh? Andate.”
“Oh povero me! Aspetti: era ammalata molto? Quanto tempo è…?”
Ma intanto la finestra fu chiusa davvero.
“Quella signora! quella signora! una parola, per carità! per i suoi poveri morti! Non le chiedo niente del suo: ohe!” Ma era come dire al muro.
Afflitto della nuova, e arrabbiato della maniera, Renzo afferrò ancora il martello, e, così appoggiato alla porta, andava stringendolo e storcendolo, l’alzava per picchiar di nuovo alla disperata, poi lo teneva sospeso. In quest’agitazione, si voltò per vedere se mai ci fosse d’intorno qualche vicino, da cui potesse forse aver qualche informazione più precisa, qualche indizio, qualche lume. Ma la prima, l’unica persona che vide, fu un’altra donna, distante forse un venti passi; la quale, con un viso ch’esprimeva terrore, odio, impazienza e malizia, con cert’occhi stravolti che volevano insieme guardar lui, e guardar lontano, spalancando la bocca come in atto di gridare a più non posso, ma rattenendo anche il respiro, alzando due braccia scarne, allungando e ritirando due mani grinzose e piegate a guisa d’artigli, come se cercasse d’acchiappar qualcosa, si vedeva che voleva chiamar gente, in modo che qualcheduno non se n’accorgesse. Quando s’incontrarono a guardarsi, colei, fattasi ancor più brutta, si riscosse come persona sorpresa.
“Che diamine…?” cominciava Renzo, alzando anche lui le mani verso la donna; ma questa, perduta la speranza di poterlo far cogliere all’improvviso, lasciò scappare il grido che aveva rattenuto fin allora: “l’untore! dagli! dagli! dagli all’untore!
“Chi? io! ah strega bugiarda! sta zitta,” gridò Renzo; e fece un salto verso di lei, per impaurirla e farla chetare.

Ma s’avvide subito, che aveva bisogno piuttosto di pensare ai casi suoi. Allo strillar della vecchia, accorreva gente di qua e di là; non la folla che, in un caso simile, sarebbe stata, tre mesi prima; ma più che abbastanza per poter fare d’un uomo solo quel che volessero. Nello stesso tempo, s’aprì di nuovo la finestra, e quella medesima sgarbata di prima ci s’affacciò questa volta, e gridava anche lei: “pigliatelo, pigliatelo; che dev’essere uno di que’ birboni che vanno in giro a unger le porte de’ galantuomini.”
Renzo non istette lì a pensare: gli parve subito miglior partito sbrigarsi da coloro, che rimanere a dir le sue ragioni: diede un’occhiata a destra e a sinistra, da che parte ci fosse men gente, e svignò di là. Rispinse con un urtone uno che gli parava la strada; con un gran punzone nel petto, fece dare indietro otto o dieci passi un altro che gli correva incontro; e via di galoppo, col pugno in aria, stretto, nocchiuto, pronto per qualunque altro gli fosse venuto tra’ piedi. La strada davanti era sempre libera; ma dietro le spalle sentiva il calpestìo e, più forti del calpestìo, quelle grida amare: “dàgli! dàgli! all’untore!” Non sapeva quando fossero per fermarsi; non vedeva dove si potrebbe mettere in salvo. L’ira divenne rabbia, l’angoscia si cangiò in disperazione; e, perso il lume degli occhi, mise mano al suo coltellaccio, lo sfoderò, si fermò su due piedi, voltò indietro il viso più torvo e più cagnesco che avesse fatto a’ suoi giorni; e, col braccio teso, brandendo in aria la lama luccicante, gridò: “chi ha cuore, venga avanti, canaglia! che l’ungerò io davvero con questo.”

Ma, con maraviglia, e con un sentimento confuso di consolazione, vide che i suoi persecutori s’eran già fermati, e stavan lì come titubanti, e che, seguitando a urlare, facevan, con le mani per aria, certi cenni da spiritati, come a gente che venisse di lontano dietro a lui. Si voltò di nuovo, e vide (chè il gran turbamento non gliel aveva lasciato vedere un momento prima) un carro che s’avanzava, anzi una fila di que’ soliti carri funebri, col solito accompagnamento; e dietro, a qualche distanza, un altro mucchietto di gente che avrebbero voluto anche loro dare addosso all’untore, e prenderlo in mezzo; ma eran trattenuti dall’impedimento medesimo. Vistosi così tra due fuochi, gli venne in mente che ciò che era di terrore a coloro, poteva essere a lui di salvezza; pensò che non era tempo di far lo schizzinoso; rimise il coltellaccio nel fodero, si tirò da una parte, prese la rincorsa verso i carri, passò il primo, e adocchiò nel secondo un buono spazio vòto. Prende la mira, spicca un salto; è su, piantato sul piede destro, col sinistro in aria, e con le braccia alzate.
“Bravo! bravo!” esclamarono, a una voce, i monatti, alcuni de’ quali seguivano il convoglio a piedi, altri eran seduti sui carri, altri, per dire l’orribil cosa com’era, sui cadaveri, trincando da un gran fiasco che andava in giro. “Bravo! bel colpo!”
“Sei venuto a metterti sotto la protezione de’ monatti; fa’ conto d’essere in chiesa,” gli disse uno de’ due che stavano sul carro dov’era montato.
I nemici, all’avvicinarsi del treno, avevano, i più, voltate le spalle, e se n’andavano, non lasciando di gridare: “dàgli! dàgli! all’untore!” Qualcheduno si ritirava più adagio, fermandosi ogni tanto, e voltandosi, con versacci e con gesti di minaccia, a Renzo; il quale, dal carro, rispondeva loro dibattendo i pugni in aria.
“Lascia fare a me,” gli disse un monatto; e strappato d’addosso a un cadavere un laido cencio, l’annodò in fretta, e, presolo per una delle cocche, l’alzò come una fionda verso quegli ostinati, e fece le viste di buttarglielo, gridando: “aspetta, canaglia!” A quell’atto, fuggiron tutti, inorriditi; e Renzo non vide più che schiene di nemici, e calcagni che ballavano rapidamente per aria, a guisa di gualchiere.
Tra i monatti s’alzò un urlo di trionfo, uno scroscio procelloso di risa, un “uh!” prolungato, come per accompagnar quella fuga.
“Ah ah! vedi se noi sappiamo proteggere i galantuomini?” disse a Renzo quel monatto: “val più uno di noi che cento di que’ poltroni.”
“Certo, posso dire che vi devo la vita,” rispose Renzo: “e vi ringrazio con tutto il cuore.”
“Di che cosa?” disse il monatto: “tu lo meriti: si vede che sei un bravo giovine. Fai bene a ungere questa canaglia: ungili, estirpali costoro, che non vaglion qualcosa, se non quando son morti; che, per ricompensa della vita che facciamo, ci maledicono, e vanno dicendo che, finita la morìa, ci voglion fare impiccar tutti. Hanno a finir prima loro che la morìa, e i monatti hanno a restar soli, a cantar vittoria, e a sguazzar per Milano.”
“Viva la morìa, e moia la marmaglia!” esclamò l’altro; e, con questo bel brindisi, si mise il fiasco alla bocca, e, tenendolo con tutt’e due le mani, tra le scosse del carro, diede una buona bevuta, poi lo porse a Renzo, dicendo: “bevi alla nostra salute.”

“Ve l’auguro a tutti, con tutto il cuore,” disse Renzo: “ma non ho sete; non ho proprio voglia di bere in questo momento”.
“Tu hai avuto una bella paura, a quel che mi pare,” disse il monatto: “m’hai l’aria d’un pover’uomo; ci vuol altri visi a far l’untore.”
“Ognuno s’ingegna come può,” disse l’altro.
“Dammelo qui a me,” disse uno di quelli che venivano a piedi accanto al carro, “chè ne voglio bere anch’io un altro sorso, alla salute del suo padrone, che si trova qui in questa bella compagnia…. lì, lì, appunto, mi pare, in quella bella carrozzata.”
E, con un suo atroce e maledetto ghigno, accennava il carro davanti a quello su cui stava il povero Renzo. Poi, composto il viso a un atto di serietà ancor più bieco e fellonesco, fece una riverenza da quella parte, e riprese: “si contenta, padron mio, che un povero monattuccio assaggi di quello della sua cantina? Vede bene: si fa certe vite: siam quelli che l’abbiam messo in carrozza, per condurlo in villeggiatura. E poi, già a loro signori il vino fa subito male: i poveri monatti han lo stomaco buono.”
E tra le risate de’ compagni, prese il fiasco, e l’alzò; ma, prima di bere, si voltò a Renzo, gli fissò gli occhi in viso, e gli disse, con una cert’aria di compassione sprezzante: “bisogna che il diavolo col quale hai fatto il patto, sia ben giovine; chè, se non eravamo lì noi a salvarti, lui ti dava un bell’aiuto.” E tra un nuovo scroscio di risa, s’attaccò il fiasco alle labbra.
“E noi? eh! e noi?” gridaron più voci dal carro ch’era avanti. Il birbone, tracannato quanto ne volle, porse, con tutt’e due le mani, il gran fiasco a quegli altri suoi simili, i quali se lo passaron dall’uno all’altro, fino a uno che, votatolo, lo prese per il collo, gli fece fare il mulinello, e lo scagliò a fracassarsi sulle lastre, gridando: “viva la morìa!” Dietro a queste parole, intonò una loro canzonaccia; e subito alla sua voce s’accompagnaron tutte l’altre di quel turpe coro. La cantilena infernale, mista al tintinnìo de’ campanelli, al cigolìo de’ carri, al calpestìo de’ cavalli, risonava nel vòto silenzioso delle strade, e, rimbombando nelle case, stringeva amaramente il cuore de’ pochi che ancor le abitavano.
Ma cosa non può alle volte venire in acconcio? cosa non può far piacere in qualche caso? Il pericolo d’un momento prima aveva resa più che tollerabile a Renzo la compagnia di que’ morti e di que’ vivi; e ora fu a’ suoi orecchi una musica, sto per dire, gradita, quella che lo levava dall’impiccio d’una tale conversazione. Ancor mezzo affannato, e tutto sottosopra, ringraziava intanto alla meglio in cuor suo la Provvidenza, d’essere uscito d’un tal frangente, senza ricever male nè farne; la pregava che l’aiutasse ora a liberarsi anche da’ suoi liberatori; e dal canto suo, stava all’erta, guardava quelli, guardava la strada, per cogliere il tempo di sdrucciolar giù quatto quatto, senza dar loro occasione di far qualche rumore, qualche scenata, che mettesse in malizia i passeggieri.
Tutt’a un tratto, a una cantonata, gli parve di riconoscere il luogo: guardò più attentamente, e ne fu sicuro. Sapete dov’era? Sul corso di porta orientale, in quella strada per cui era venuto adagio, e tornato via in fretta, circa venti mesi prima. Gli venne subito in mente che di lì s’andava diritto al lazzeretto; e questo trovarsi sulla strada giusta, senza studiare, senza domandare, l’ebbe per un tratto speciale della Provvidenza, e per buon augurio del rimanente. In quel punto, veniva incontro ai carri un commissario, gridando a’ monatti di fermare, e non so che altro: il fatto è che il convoglio si fermò, e la musica si cambiò in un diverbio rumoroso. Uno de’ monatti ch’eran sul carro di Renzo, saltò giù: Renzo disse all’altro: “vi ringrazio della vostra carità: Dio ve ne renda merito;” e giù anche lui, dall’altra parte.
“Va’, va’, povero untorello,” rispose colui: “non sarai tu quello che spianti Milano.”
Per fortuna, non c’era chi potesse sentire. Il convoglio era fermato sulla sinistra del corso: Renzo prende in fretta dall’altra parte, e, rasentando il muro, trotta innanzi verso il ponte; lo passa, continua per la strada del borgo, riconosce il convento de’ cappuccini, è vicino alla porta, vede spuntar l’angolo del lazzeretto, passa il cancello, e gli si spiega davanti la scena esteriore di quel recinto: un indizio appena e un saggio, e già una vasta, diversa, indescrivibile scena.
Lungo i due lati che si presentano a chi guardi da quel punto, era tutto un brulichìo; erano ammalati che andavano, in compagnie, al lazzeretto; altri che sedevano o giacevano sulle sponde del fossato che lo costeggia; sia che le forze non fosser loro bastate per condursi fin dentro al ricovero, sia che, usciti di là per disperazione, le forze fosser loro ugualmente mancate per andar più avanti. Altri meschini erravano sbandati, come stupidi, e non pochi fuor di sé affatto; uno stava tutto infervorato a raccontar le sue immaginazioni a un disgraziato che giaceva oppresso dal male; un altro dava nelle smanie; un altro guardava in qua e in là con un visino ridente, come se assistesse a un lieto spettacolo. Ma la specie più strana e più rumorosa d’una tal trista allegrezza, era un cantare alto e continuo, il quale pareva che non venisse fuori da quella miserabile folla, e pure si faceva sentire più che tutte l’altri voci: una canzone contadinesca d’amore gaio e scherzevole, di quelle che chiamavan villanelle; e andando con lo sguardo dietro al suono, per iscoprire chi mai potesse esser contento, in quel tempo, in quel luogo, si vedeva un meschino che, seduto tranquillamente in fondo al fossato, cantava a più non posso, con la testa per aria.
Renzo aveva appena fatti alcuni passi lungo il lato meridionale dell’edifizio, che si sentì in quella moltitudine un rumore straordinario, e di lontano voci che gridavano: guarda! piglia! S’alza in punta di piedi, e vede un cavallaccio che andava di carriera, spinto da un più strano cavaliere: era un frenetico che, vista quella bestia sciolta e non guardata, accanto a un carro, c’era montato in fretta a bisdosso, e, martellandole il collo co’ pugni, e facendo sproni de’ calcagni, la cacciava in furia; e monatti dietro, urlando; e tutto si ravvolse in un nuvolo di polvere, che volava lontano.
Così, già sbalordito e stanco di veder miserie, il giovine arrivò alla porta di quel luogo dove ce n’erano adunate forse più che non ce ne fosse di sparse in tutto lo spazio che gli era già toccato di percorrere. S’affaccia a quella porta, entra sotto la volta, e rimane un momento immobile a mezzo del portico.