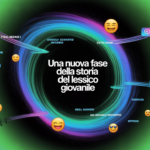
Una nuova fase della storia del lessico giovanile
14 Giugno 2025
Lo sport al femminile, tra stereotipi da abbattere ed empowerment da coltivare
14 Giugno 2025📚 Traccia e svolgimento di un tema argomentativo sul testo “Come mangiare il gelato” di Umberto Eco (Accademia della Crusca)

TRACCIA
ESAME DI STATO 2023 – PRIMA PROVA SCRITTA
Ministero dell’Istruzione e del Merito – SESSIONE STRAORDINARIA 2023
PROPOSTA B3
Umberto Eco, Come mangiare il gelato, in Come viaggiare con un salmone, La nave di Teseo, Milano, 2016, pp. 133-135.
«Quando ero piccolo si comperavano ai bambini due tipi di gelati, venduti da quei carrettini bianchi con coperchi argentati: o il cono da due soldi o la cialda da quattro soldi. Il cono da due soldi era piccolissimo, stava appunto bene in mano a un bambino, e si confezionava traendo il gelato dal contenitore con l’apposita paletta e accumulandolo sul cono. La nonna consigliava di mangiare il cono solo in parte, gettando via il fondo a punta, perché era stato toccato dalla mano del gelataio (eppure quella parte era la più buona e croccante, e la si mangiava di nascosto, fingendo di averla buttata).
La cialda da quattro soldi veniva confezionata con una macchinetta speciale, anch’essa argentata, che comprimeva due superfici circolari di pasta contro una sezione cilindrica di gelato. Si faceva scorrere la lingua nell’interstizio sino a che essa non raggiungeva più il nucleo centrale di gelato, e a quel punto si mangiava tutto, le superfici essendo ormai molli e impregnate di nettare. La nonna non aveva consigli da dare: in teoria le cialde erano state toccate solo dalla macchinetta, in pratica il gelataio le aveva prese in mano per consegnarle, ma era impossibile identificare la zona infetta.
Io ero però affascinato da alcuni coetanei cui i genitori acquistavano non un gelato da quattro soldi, ma due coni da due soldi. Questi privilegiati marciavano fieri con un gelato nella destra e uno nella sinistra, e muovendo agilmente il capo leccavano ora dall’uno ora dall’altro. Tale liturgia mi appariva così sontuosamente invidiabile che molte volte avevo chiesto di poterla celebrare. Invano. I miei erano inflessibili: un gelato da quattro soldi sì, ma due da due soldi assolutamente no.
Come ognuno vede, né la matematica né l’economia né la dietetica giustificavano questo rifiuto. E neppure l’igiene, posto che poi si gettassero entrambe le estremità dei due coni. Una pietosa giustificazione argomentava, invero mendacemente, che un fanciullo occupato a volgere lo sguardo da un gelato all’altro fosse più incline a inciampare in sassi, gradini o abrasioni del selciato. Oscuramente intuivo che ci fosse un’altra motivazione, crudelmente pedagogica, della quale però non riuscivo a rendermi conto.
Ora, abitante e vittima di una civiltà dei consumi e dello sperpero (quale quella degli anni trenta non era), capisco che quei cari ormai scomparsi erano nel giusto. Due gelati da due soldi in luogo di uno da quattro non erano economicamente uno sperpero, ma lo erano certo simbolicamente. Proprio per questo li desideravo: perché due gelati suggerivano un eccesso. E proprio per questo mi erano negati: perché apparivano indecenti, insulto alla miseria, ostentazione di privilegio fittizio, millantata agiatezza. Mangiavano due gelati solo i bambini viziati, quelli che le fiabe giustamente punivano, come Pinocchio quando disprezzava la buccia e il torsolo. […]
L’apologo rischia di apparire privo di morale, in un mondo in cui la civiltà dei consumi vuole ormai viziati anche gli adulti, e promette loro sempre qualche cosa di più, dall’orologino accluso al fustino al ciondolo regalo per chi acquista la rivista. Come i genitori di quei ghiottoni ambidestri che invidiavo, la civiltà dei consumi finge di dare di più, ma in effetti dà per quattro soldi quello che vale quattro soldi. […]
Ma la morale di quei tempi ci voleva tutti spartani, e quella odierna ci vuole tutti sibariti¹.»
Umberto Eco, Come mangiare il gelato, in Come viaggiare con un salmone, La nave di Teseo, Milano, 2016, pp. 133-135.
Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande proposte.
- Riassumi il contenuto del testo individuando la tesi di fondo.
- Nel brano l’autore fa riferimento ad una ‘liturgia’ che da bambino avrebbe più volte chiesto ai genitori di poter ‘celebrare’. Individua a quale comportamento allude il testo e spiega il significato che, a tuo avviso, si può attribuire in questo contesto al termine ‘liturgia’.
- Eco aveva intuito nel diniego dei genitori una motivazione ‘crudelmente pedagogica’: spiega il senso dell’avverbio usato.
- Cosa intende affermare l’autore con la frase ‘la civiltà dei consumi […] dà per quattro soldi quello che vale quattro soldi’?
Produzione
Per quanto formulata ormai anni fa la provocazione di Umberto Eco (1932-2016), risulta ancora oggi di grande attualità: esprimi le tue opinioni sul tema del rapporto fra individuo e società dei consumi e sui rischi sottesi agli stili di vita che ci vengono quotidianamente proposti, elaborando un testo in cui tesi e argomentazioni siano organizzate in un discorso coerente e coeso.
Note:
¹ Nella tradizione antica la città di Sparta era simbolo di morigeratezza e austerità, mentre quella di Sibari costituiva il modello di uno stile di vita improntato a lusso e mollezza di costumi.

SVOLGIMENTO
Analisi del testo “Come mangiare il gelato” di Umberto Eco
Il brano “Come mangiare il gelato”, tratto da Come viaggiare con un salmone di Umberto Eco, è una riflessione arguta e ironica che, partendo da un’esperienza d’infanzia apparentemente banale (il consumo di gelato), analizza le profonde differenze tra la civiltà dei consumi del passato e quella attuale. Eco utilizza l’aneddoto personale per indagare il valore simbolico e pedagogico degli oggetti e dei comportamenti, delineando una critica sottile all’ostentazione e allo sperpero.
Comprensione e Analisi
1. Riassumi il contenuto del testo individuando la tesi di fondo.
Il testo racconta i ricordi d’infanzia di Umberto Eco legati all’acquisto del gelato: il cono da due soldi e la cialda da quattro soldi, con i consigli igienici della nonna. L’autore era particolarmente affascinato e invidioso dei coetanei che ricevevano non un gelato da quattro soldi, ma due coni da due soldi, un atto che gli appariva come una “liturgia sontuosamente invidiabile” ma che i suoi genitori gli negavano inflessibilmente. Eco riconosce che questo rifiuto non era giustificato da ragioni matematiche, economiche, dietetiche o igieniche, ma intuiva una “motivazione, crudelmente pedagogica”. Da adulto, egli comprende che i genitori avevano ragione: due gelati da due soldi, pur non essendo uno sperpero economico, lo erano simbolicamente. Essi suggerivano un “eccesso”, apparivano “indecenti” e un'”ostentazione di privilegio fittizio”, un comportamento da “bambini viziati”. L’autore estende poi questa riflessione alla civiltà dei consumi attuale, che, al contrario di quella degli anni trenta, vuole “viziati anche gli adulti” e promette sempre di più, ma in realtà offre solo ciò che si paga, senza reale valore aggiunto. Eco conclude che la morale del suo tempo lo voleva “spartano”, mentre quella odierna lo vuole “sibarita”.
La tesi di fondo di Umberto Eco è che il valore simbolico del consumo (in particolare dell’eccesso e dello sperpero) è stato radicalmente trasformato dalla società contemporanea rispetto al passato, passando da una morale che negava l’ostentazione a una che, al contrario, la promuove e la rende ordinaria, pur fingendo di offrire un valore aggiunto che in realtà non esiste.
2. Nel brano l’autore fa riferimento ad una ‘liturgia’ che da bambino avrebbe più volte chiesto ai genitori di poter ‘celebrare’. Individua a quale comportamento allude il testo e spiega il significato che, a tuo avviso, si può attribuire in questo contesto al termine ‘liturgia’.
Il comportamento a cui allude il testo con il termine “liturgia” è l’atto di mangiare simultaneamente due coni da due soldi, tenendone uno in ogni mano e leccando “ora dall’uno ora dall’altro”. Questo rituale era praticato da alcuni coetanei di Eco, i quali “marciavano fieri con un gelato nella destra e uno nella sinistra, e muovendo agilmente il capo leccavano ora dall’uno ora dall’altro”.
Il significato che, a mio avviso, si può attribuire in questo contesto al termine ‘liturgia’ è profondo e ironico al contempo:
- Rituale Sacrale: La liturgia è per definizione un rito religioso, una sequenza di azioni e parole che assumono un valore simbolico e sacrale. Usando questo termine, Eco eleva un semplice atto di consumo (mangiare il gelato) a un rito quasi sacro e desiderabile. L’atto di mangiare due gelati contemporaneamente, pur non avendo una giustificazione logica o economica (costava quanto una cialda), acquisiva un significato di eccesso ritualizzato, di celebrazione di un privilegio o di un’abbondanza.
- Azione Formalizzata e Desiderata: La liturgia implica anche una sequenza di azioni precise e ripetibili, che vengono eseguite con una certa solennità e che suscitano un forte desiderio in chi le osserva. Il bambino Eco, non potendo compiere tale rito, ne è affascinato e lo invidia profondamente, desiderando di “celebrarlo” a sua volta.
- Simbolo di Status/Ostentazione: La liturgia, pur nella sua semplicità infantile, rappresentava un’ostentazione di privilegio o di agiatezza, un segno visibile di un “di più” che i genitori di Eco non volevano concedergli. In questo senso, è una liturgia del consumo eccessivo e non necessario.
3. Eco aveva intuito nel diniego dei genitori una motivazione ‘crudelmente pedagogica’: spiega il senso dell’avverbio usato.
L’avverbio ‘crudelmente’ usato da Eco per descrivere la motivazione pedagogica del diniego dei genitori assume un senso che va oltre la semplice durezza, indicando una lezione amara, necessaria ma difficile da accettare per il bambino.
- Necessità e Ineluttabilità della Negazione: La negazione è “crudele” perché non si basa su motivazioni logiche facilmente comprensibili (“né la matematica né l’economia né la dietetica giustificavano questo rifiuto”), e neppure su una giustificazione “pietosa” (come il rischio di inciampare). È una negazione quasi arbitraria dal punto di vista infantile, ma profondamente voluta dai genitori.
- Insegnamento di un Valore Profondo: La crudeltà sta nel fatto che la lezione impartita è quella della moderazione, del non-sperpero simbolico, del rifiuto dell’eccesso gratuito. I genitori volevano insegnare che non tutto ciò che è desiderabile o fattibile è eticamente accettabile, soprattutto se suggerisce uno sperpero o un’ostentazione di privilegio (“apparivano indecenti, insulto alla miseria, ostentazione di privilegio fittizio, millantata agiatezza”). Questa lezione è “crudele” perché nega al bambino un piacere semplice ma simbolico di grande importanza.
- Confronto con la Reale moderazione nei consumi: La crudeltà è nel confrontare il bambino con una realtà più ampia di sobrietà e “spartanità” (come la morale dei tempi) che va oltre la sua comprensione immediata. È una lezione che lo introduce ai limiti e ai valori morali della società, anche a costo di un piccolo dispiacere infantile.
- Beneficio a lungo termine: Sebbene “crudele” nell’immediato, l’autore riconosce da adulto che i genitori “erano nel giusto”. La crudeltà è quindi funzionale a un bene superiore, a una formazione del carattere che respinge il vizio e l’eccesso fine a sé stesso.
In sintesi, “crudelmente” non significa cattiveria, ma la fermezza e la durezza di una lezione morale che, pur causando un’immediata frustrazione nel bambino, mira a insegnargli un valore fondamentale di moderazione e decoro.
4. Cosa intende affermare l’autore con la frase ‘la civiltà dei consumi […] dà per quattro soldi quello che vale quattro soldi’?
Con la frase “la civiltà dei consumi […] dà per quattro soldi quello che vale quattro soldi” (r. 29-30), Umberto Eco intende affermare che la società consumistica moderna crea un’illusione di generosità o di valore aggiunto, ma in realtà offre solo ciò che è esattamente proporzionale al prezzo pagato, senza alcun reale beneficio o “dono” gratuito.
Questa frase si contrappone all’esempio dell’orologino o del ciondolo “regalo” accluso a un prodotto (fustino o rivista). La civiltà dei consumi “finge di dare di più” (il regalo, l’offerta speciale, il “valore aggiunto”), suggerendo che si stia ricevendo qualcosa in omaggio o a un prezzo vantaggioso. Tuttavia, in realtà, il costo di quel “regalo” o di quell’apparente surplus è già stato incorporato nel prezzo totale del prodotto principale. L’acquirente non riceve nulla di “gratuito” o di “superiore” al valore monetario complessivo dell’acquisto.
- Critica all’illusione del valore: Eco critica l’abilità della civiltà dei consumi nel generare un desiderio di “di più” e nel far credere al consumatore di ottenere un vantaggio, quando invece si tratta di un’operazione di marketing che non altera il valore intrinseco dell’acquisto.
- Denuncia della manipolazione psicologica: La frase evidenzia come la società moderna dei consumi, a differenza della moralità “spartana” del passato che negava l’eccesso simbolico, ora fomenti il desiderio di “eccesso” e “sperpero” (come i due gelati), ma lo faccia in modo calcolato e commerciale, rendendo l’adulto “viziato” e sempre alla ricerca di un’illusoria gratificazione.
- Assenza di vero “dono”: Implicito nella frase è il concetto che, nel consumo moderno, manca la dimensione del vero dono, dell’eccesso disinteressato. Tutto è prezzato, tutto è merce, anche ciò che si presenta come un “omaggio”.
In sostanza, Eco vuole sottolineare la trasparenza (e la banalità) della logica consumistica che, pur vestita da generosità, offre esattamente ciò per cui si paga, smascherando l’illusione di un valore aggiunto o di uno sperpero autentico.
Produzione
Il Dilemma del Consumo: L’Individuo Tra Desideri Costruiti e la Ricerca di Autenticità
L’articolo di Umberto Eco, con la sua provocazione sul “come mangiare il gelato”, si rivela ancora oggi di straordinaria attualità, offrendo una lente acuta per riflettere sul rapporto fra individuo e società dei consumi, e sui rischi sottesi agli stili di vita che ci vengono quotidianamente proposti. La sua analisi, che contrappone la “morale spartana” del passato alla “sibarita” odierna, tocca nervi scoperti della nostra epoca, caratterizzata da una spinta incessante al possesso e a un’omologazione che rischia di svuotare le esperienze di significato autentico. Condivido la preoccupazione di Eco: la civiltà dei consumi, pur promettendo appagamento, rischia di intrappolare l’individuo in un ciclo di desideri artificiali e di sperpero, compromettendo la sua capacità di discernimento e di autentica realizzazione.
La società in cui viviamo è indubbiamente una “civiltà dei consumi e dello sperpero”, come la definisce Eco. Fin dalla più tenera età, siamo bombardati da messaggi che associano la felicità al possesso di beni materiali e all’adesione a stili di vita predefiniti. La pubblicità, i social media, le vetrine dei negozi non ci propongono solo prodotti, ma un intero universo di desideri e aspirazioni. Il “di più” è l’imperativo categorico: non un telefono, ma l’ultimo modello; non un viaggio, ma l’esperienza “instagrammabile”; non un vestito, ma l’ultima tendenza. Questo crea un circolo vizioso in cui il desiderio non è mai pienamente appagato, poiché il prossimo prodotto, la prossima esperienza, è sempre dietro l’angolo.
Il rischio principale di questo stile di vita è la costruzione artificiale dei desideri. Se l’Eco bambino desiderava due gelati per un significato simbolico di “eccesso” e “privilegio”, in una società che glielo negava con “crudeltà pedagogica”, oggi la civiltà dei consumi non nega più l’eccesso, ma lo rende la norma, lo rende banale. “Ti vuole viziato anche l’adulto”, e promette sempre “qualche cosa di più”, ma, come sagacemente osserva l’autore, “dà per quattro soldi quello che vale quattro soldi”. L’illusione del “regalo” o del “valore aggiunto” maschera la logica spietata del mercato, che trasforma ogni aspetto dell’esistenza in merce e ogni desiderio in un’occasione di profitto. Questo porta a una perdita di discernimento: l’individuo fatica a distinguere tra ciò che è un bisogno reale e ciò che è un desiderio indotto, tra il valore intrinseco di un oggetto e la sua valenza simbolica creata dal marketing. La conseguenza è uno sperpero non solo economico, ma anche di risorse naturali e di tempo, in un’ansia da prestazione che coinvolge ogni aspetto della vita.
I rischi sottesi a questi stili di vita sono molteplici e profondi:
- Superficialità e omologazione: La ricerca costante di ciò che è di tendenza o ciò che ha “più like” (come ho notato analizzando il testo di Cortelazzo sul linguaggio giovanile, vedi Proposta B2 Sessione straordinaria 2023) porta a una superficialità delle scelte e a una omologazione dei gusti. L’individuo, per sentirsi parte della “gregge” dei consumatori “sibariti”, si conforma a modelli esterni, perdendo la propria autenticità e unicità.
- Impatto ambientale: Il ciclo incessante di produzione, consumo e sperpero ha conseguenze devastanti sull’ambiente. La “cultura dell’usa e getta”, l’obsolescenza programmata e l’estrazione intensiva di risorse naturali sono tutte manifestazioni di uno stile di vita non sostenibile, che la “morale spartana” del passato, con la sua attenzione alla conservazione e all’essenzialità, avrebbe probabilmente condannato (un tema che richiama le preoccupazioni sull’ambiente in Costituzione, vedi C2 Sessione ordinaria 2023).
- Insoddisfazione cronica e fragilità psicologica: Il mito del “tutto e subito” e del desiderio perennemente stimolato crea un senso di insoddisfazione cronica. Se la felicità è legata a ciò che si possiede, e c’è sempre qualcosa di nuovo da desiderare, l’individuo è condannato a una ricerca infinita e frustrante. Questo può portare a ansia, stress e a una generale fragilità psicologica, incapaci come siamo di “attendere” (come analizzato da Belpoliti, vedi C2 Sessione straordinaria 2023) e di sopportare la noia.
- Indebitamento e disuguaglianze: La spinta al consumo può portare a situazioni di indebitamento personale e familiare, e accentua le disuguaglianze sociali, poiché non tutti possono permettersi di partecipare a pieno regime a questo stile di vita “sibarita”.
In conclusione, la provocazione di Umberto Eco ci invita a riflettere criticamente sulla direzione che la nostra società sta prendendo. La sua distinzione tra il valore economico e quello simbolico, e la sua denuncia dell’illusione di un “di più” che in realtà è solo un “valore per quattro soldi”, sono un monito potente. Per me, come individuo che cresce in questa civiltà dei consumi, la sfida è quella di sviluppare un senso critico affinato, che mi permetta di distinguere tra bisogni autentici e desideri indotti. È un invito a riscoprire una “morale spartana” non come privazione, ma come scelta consapevole di autenticità, di sobrietà e di valorizzazione di ciò che ha un significato profondo, al di là dell’effimero richiamo del mercato. Solo così potremo evitare di essere “bambini viziati” perennemente insoddisfatti, e costruire una vita più ricca di valore, non di merci.




