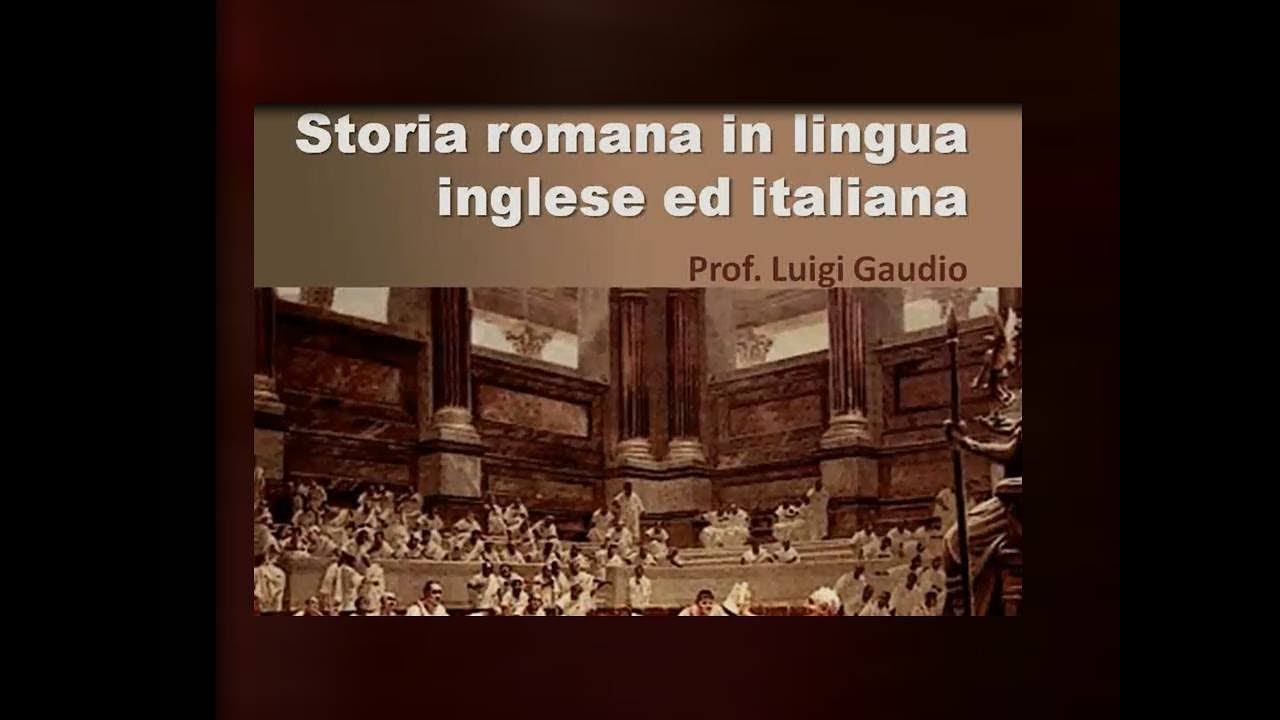
Andare a scuola a Roma
28 Dicembre 2019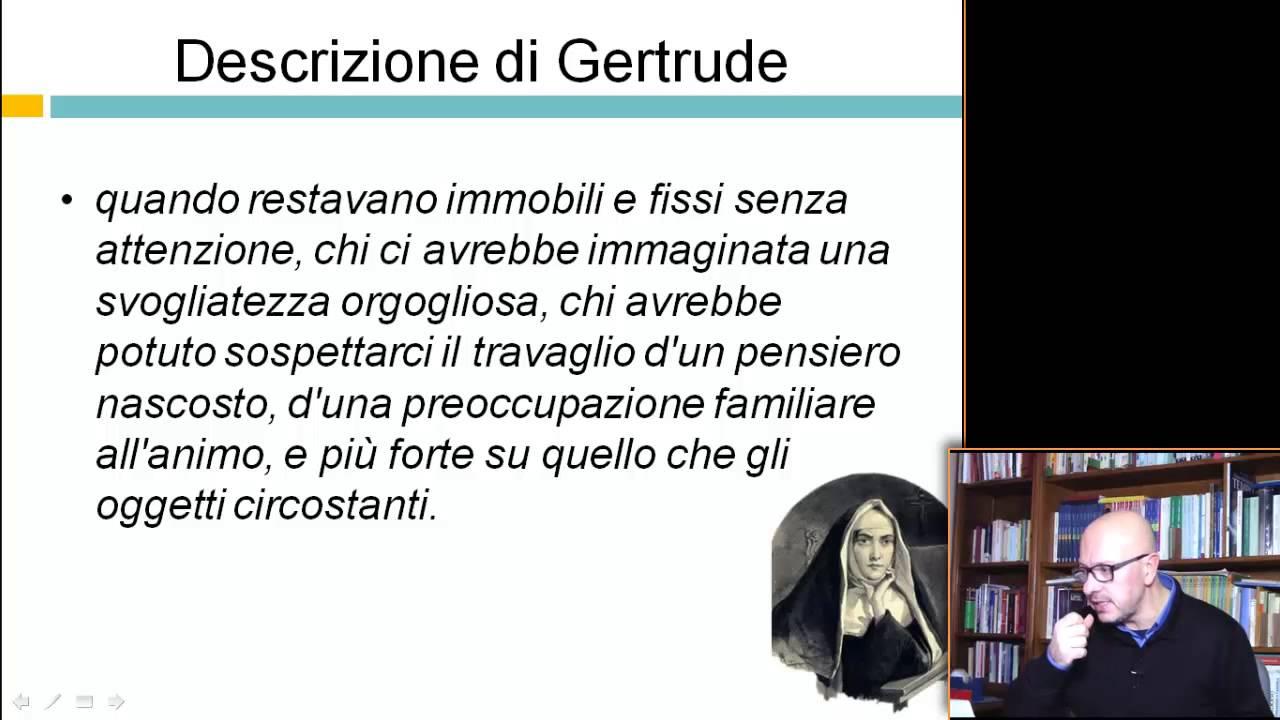
Capitoli nono e decimo dei Promessi Sposi
28 Dicembre 2019Il rapporto tra Roma e Cartagine rappresenta uno dei più drammatici rovesciamenti di alleanze della storia antica, culminato in tre conflitti che ridisegnarono completamente l’equilibrio del Mediterraneo.
Le origini dell’alleanza
Inizialmente Roma e Cartagine erano alleate, unite da interessi complementari nel Mediterraneo occidentale. I primi trattati risalgono al VI secolo a.C., quando Roma era ancora una potenza regionale italica e Cartagine dominava i commerci marittimi. Il trattato del 509 a.C., menzionato da Polibio, delimitava le rispettive sfere d’influenza: Roma si concentrava sull’espansione terrestre in Italia, mentre Cartagine manteneva il controllo delle rotte commerciali marine.
Questa partnership funzionò finché gli interessi rimasero distinti. Cartagine, fondata dai Fenici di Tiro nell’814 a.C., aveva costruito un impero commerciale basato su una rete di colonie e empori sparsi per tutto il Mediterraneo occidentale. Roma, invece, stava gradualmente unificando la penisola italiana attraverso un sistema di alleanze e conquiste.
La rottura dell’equilibrio
La situazione cambiò radicalmente quando Roma completò la conquista dell’Italia meridionale. La presa di Taranto nel 272 a.C. mise Roma in diretto contatto con la Sicilia, tradizionale zona d’influenza cartaginese. L’isola divenne il punto di frizione che trasformò gli alleati in nemici mortali.
Il pretesto scatenante fu la questione dei Mamertini a Messina nel 264 a.C. Questi mercenari campani, che avevano occupato la città, chiesero aiuto sia a Roma che a Cartagine quando furono minacciati da Ierone II di Siracusa. La decisione romana di intervenire, nonostante l’opposizione del Senato più conservatore, segnò l’inizio del primo conflitto punico.
La Prima Guerra Punica (264-241 a.C.)
Questo conflitto rivelò immediatamente le diverse nature delle due potenze. Roma dovette trasformarsi da potenza terrestre in potenza navale, costruendo la sua prima vera flotta da guerra. L’innovazione del “corvo”, il ponte d’abbordaggio che permetteva di trasformare i combattimenti navali in scontri di fanteria, dimostrò la capacità romana di adattamento tecnologico.
Le vittorie navali di Milazzo (260 a.C.) e Ecnomo (256 a.C.) portarono Roma a tentare l’invasione dell’Africa con la spedizione di Regolo. Il fallimento di questa operazione, culminato nella sconfitta e cattura del console, mostrò i limiti della strategia romana e la resilienza punica.
La guerra si trascinò per oltre vent’anni, logorandosi in una serie di assedi e battaglie navali. La vittoria romana alle Egadi nel 241 a.C. fu decisiva: Cartagine, esausta economicamente, dovette cedere la Sicilia e pagare un’indennità di 3.200 talenti.
L’intervallo tra le guerre
Il periodo tra la prima e la seconda guerra punica fu caratterizzato dall’espansione cartaginese in Spagna sotto la guida della famiglia barcide. Amilcare Barca, poi Asdrubale e infine Annibale costruirono un nuovo impero che doveva compensare le perdite siciliane. Il trattato dell’Ebro (226 a.C.) stabiliva che Cartagine non doveva espandersi oltre questo fiume, ma l’accordo conteneva già i semi del futuro conflitto.
Roma, dal canto suo, consolidava il controllo dell’Italia e si espandeva nell’Adriatico, sottomettendo gli Illiri e stabilendo le prime teste di ponte nei Balcani.
La Seconda Guerra Punica (218-201 a.C.)
L’assedio di Sagunto da parte di Annibale nel 219 a.C. fornì a Roma il casus belli. La risposta cartaginese fu straordinaria: invece di una guerra navale in Sicilia, Annibale concepì l’audace piano di portare la guerra in Italia attraversando le Alpi.
La marcia di Annibale rimane una delle più grandi gesta militari della storia antica. Con un esercito multietnico di circa 90.000 uomini e 37 elefanti, attraversò i Pirenei, la Gallia e le Alpi, arrivando in Italia con forze ridotte ma determinate.
Le vittorie di Annibale al Trebbia (218 a.C.), al Trasimeno (217 a.C.) e soprattutto a Canne (216 a.C.) portarono Roma sull’orlo del collasso. Canne, in particolare, rappresenta un capolavoro tattico: la doppia manovra avvolgente annientò otto legioni romane, uccidendo circa 50.000 soldati, inclusi 80 senatori.
La risposta romana fu magistrale nella sua semplicità: la strategia fabian di logoramento, evitando battaglie campali e attaccando le linee di rifornimento nemiche. Fabio Massimo, soprannominato “il Temporeggiatore”, capì che Roma poteva permettersi una guerra lunga, mentre Annibale no.
Il punto di svolta arrivò con Scipione Africano, che portò la guerra in Spagna e poi in Africa. La battaglia di Zama (202 a.C.) vide finalmente la sconfitta di Annibale su un campo di battaglia, ponendo fine alla guerra.
La Terza Guerra Punica (149-146 a.C.)
L’ultima guerra fu più un’esecuzione che un conflitto. Cartagine, pur rispettando i termini del trattato di pace, aveva recuperato economicamente, suscitando la paranoia romana. Catone il Censore concludeva ogni suo discorso in Senato con “Carthago delenda est” (Cartagine deve essere distrutta).
Il pretesto fu fornito dal conflitto con Massinissa, re di Numidia e alleato romano. Quando Cartagine tentò di difendersi, Roma dichiarò guerra. L’assedio durato tre anni terminò con la completa distruzione della città nel 146 a.C. per opera di Scipione Emiliano.
Le conseguenze
Le guerre puniche trasformarono Roma da potenza italica in signora del Mediterraneo. La distruzione di Cartagine eliminò l’unico rivale capace di contrastare l’espansione romana, aprendo la strada al dominio su Grecia, Asia Minore e Oriente.
Sul piano interno, le guerre accelerarono la trasformazione sociale di Roma: l’arricchimento della classe dirigente, l’impoverimento dei piccoli proprietari terrieri, lo sviluppo del latifondo e della schiavitù su larga scala, l’afflusso di ricchezze dall’estero. Questi cambiamenti avrebbero generato le contraddizioni che portarono alla crisi della Repubblica.
Dal punto di vista strategico, le guerre puniche dimostrarono l’importanza del controllo del mare per il dominio del Mediterraneo e stabilirono i principi della geopolitica romana: eliminazione dei rivali, controllo delle risorse, creazione di un sistema di alleanze subordinate.
La rivalità romano-cartaginese rimane un esempio paradigmatico di come interessi economici e strategici possano trasformare alleati in nemici irriducibili, culminando nella distruzione totale di una delle più antiche e prospere civiltà del mondo antico.




