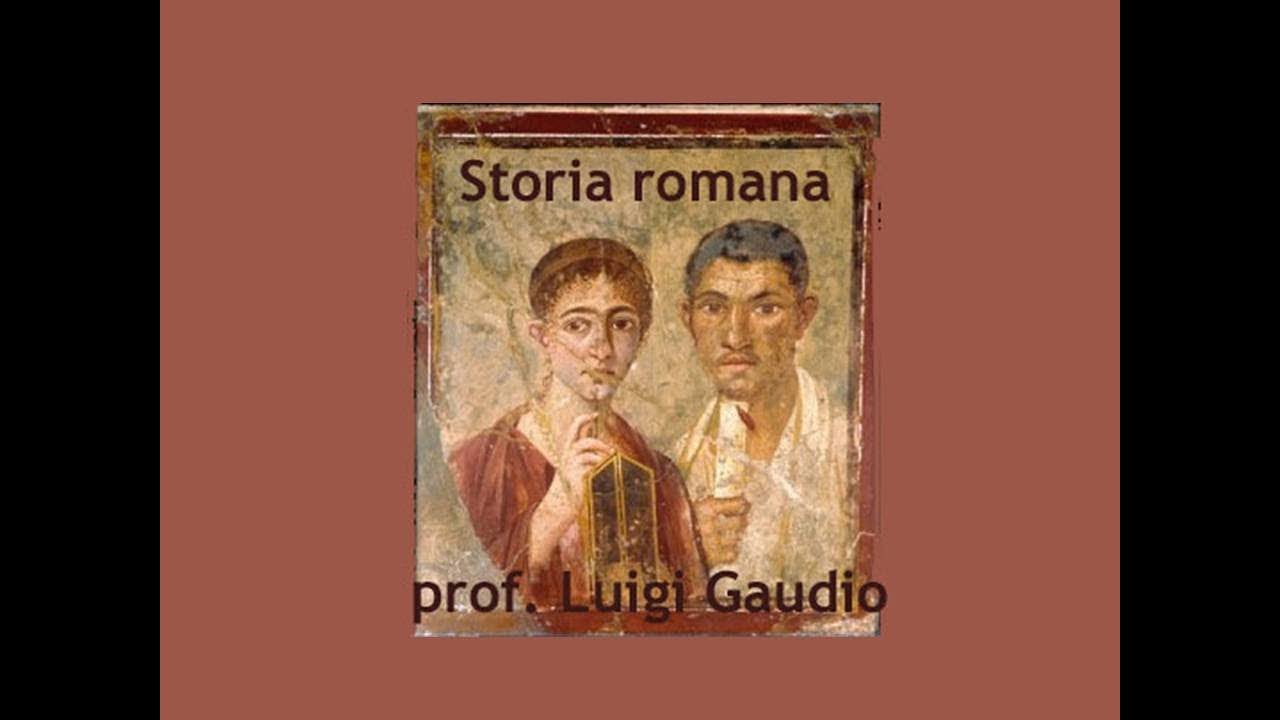
Guerre contro i Sanniti e contro Pirro
28 Dicembre 2019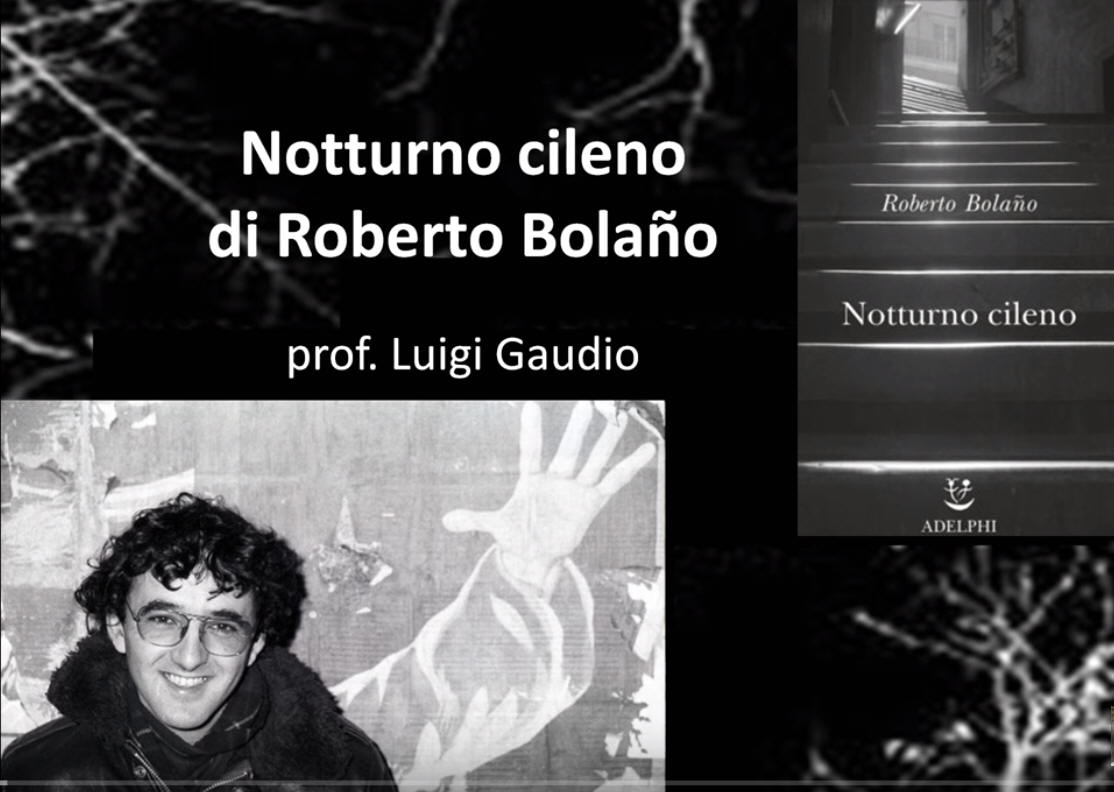
Notturno cileno di Roberto Bolano
28 Dicembre 2019La transizione dal latino al volgare rappresenta uno dei momenti più significativi nella storia culturale italiana, segnando la nascita di una tradizione letteraria autonoma che avrebbe influenzato profondamente lo sviluppo della nostra identità nazionale.
Il contesto storico-linguistico
Nel corso dei secoli VIII-XI, il latino parlato si era progressivamente trasformato nelle varie parlate romanze. Mentre il latino rimaneva la lingua della cultura, dell’amministrazione e della Chiesa, nelle comunicazioni quotidiane si affermavano sempre più i volgari locali. Questa diglossia caratterizzò a lungo la società medievale italiana.
Le prime testimonianze
La più antica testimonianza scritta in volgare italiano è tradizionalmente identificata nell’Indovinello veronese (fine VIII – inizio IX secolo), un breve testo che recita: “Se pareba boves, alba pratalia araba, et albo versorio teneba, et negro semen seminaba”. Questo enigma, che descrive metaforicamente l’atto dello scrivere, rappresenta un momento di passaggio cruciale.
Il Placito capuano del 960 costituisce invece la prima testimonianza giuridica ufficiale: “Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte Sancti Benedicti”. Qui il volgare entra per la prima volta in un documento legale, segnando il riconoscimento istituzionale della lingua parlata.
L’emergere della letteratura volgare
La vera svolta letteraria si ha nel XIII secolo con diverse tradizioni regionali che si sviluppano contemporaneamente. La Scuola siciliana di Federico II rappresenta il primo movimento poetico consapevole in volgare, elaborando temi e forme che sarebbero divenuti centrali nella tradizione lirica italiana. Giacomo da Lentini e i poeti della corte federiciana creano un modello linguistico e stilistico che influenzerà profondamente la poesia successiva.
Parallelamente, nell’Italia settentrionale emerge una ricca produzione didattico-morale e religiosa. Il Ritmo laurenziano e i primi testi agiografici mostrano come il volgare stesse conquistando spazi sempre più ampi, dalla devozione popolare alla riflessione morale.
Le conseguenze culturali
Questo passaggio non rappresenta solo un fatto linguistico, ma una vera rivoluzione culturale. L’uso del volgare democratizza l’accesso alla cultura scritta, permettendo a un pubblico più ampio di partecipare alla vita intellettuale. Nascono nuovi generi letterari, si sviluppano forme metriche originali, si elaborano registri stilistici che daranno vita alla ricchezza espressiva della letteratura italiana.
La scelta del volgare comporta anche una nuova consapevolezza identitaria. Gli autori non si limitano a tradurre modelli latini, ma creano opere originali che riflettono la sensibilità e la cultura del loro tempo e del loro territorio.
Verso Dante
Tutte queste esperienze confluiranno nell’opera di Dante, che con il De vulgari eloquentia teorizza la dignità letteraria del volgare e con la Commedia ne dimostra le infinite possibilità espressive. Dante non solo corona questo processo evolutivo, ma pone le basi per una tradizione letteraria che continua ancora oggi.
La nascita della letteratura italiana dal latino al volgare rappresenta quindi un fenomeno complesso, che intreccia innovazione linguistica, trasformazione sociale e creatività artistica, dando origine a una delle tradizioni letterarie più ricche e influenti d’Europa.
🎤🎧 Audio Lezioni di Letteratura delle origini, duecento e trecento del prof. Gaudio
Ascolta “Letteratura origini duecento e trecento” su Spreaker.




