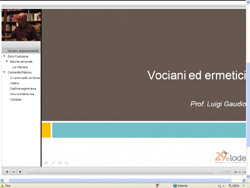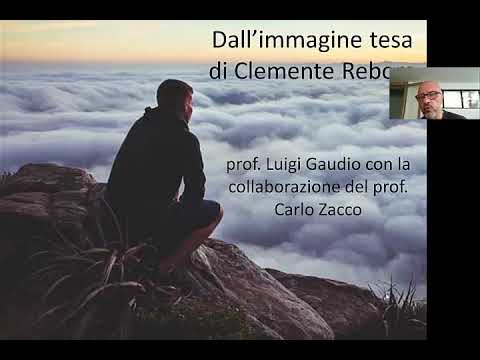Museo Picasso Barcellona: storia, collezione e significato
28 Dicembre 2019
Lettura in classe dell’ultima parte del romanzo Il ragazzo selvatico di Paol…
28 Dicembre 2019Testo e analisi della poesia Dall’immagine tesa di Clemente Rebora
Introduzione
“Dall’immagine tesa” è una delle poesie più celebri e intense di Clemente Rebora (1885-1957), inclusa nella sua raccolta Frammenti lirici (1913), sebbene spesso associata al suo percorso di ricerca spirituale e interiore. Questa lirica esplora i temi dell’attesa, della solitudine, della percezione sensoriale e della speranza di una rivelazione, il tutto espresso attraverso un linguaggio essenziale e vibrante.
Testo della Poesia
Dall’immagine tesa
vigilo l’istante
con imminenza di attesa –
e non aspetto nessuno:
5 nell’ombra accesa
spio il campanello
che impercettibile spande
un polline di suono –
e non aspetto nessuno:
10 fra quattro mura
stupefatte di spazio
più che un deserto
non aspetto nessuno.
Ma deve venire,
15 verrà, se resisto
a sbocciare non visto,
verrà d’improvviso,
quando meno l’avverto.
Verrà quasi perdono
20 di quanto fa morire,
verrà a farmi certo
del suo e mio tesoro,
verrà come ristoro
delle mie e sue pene,
25 verrà, forse già viene
il suo bisbiglio.
Analisi del testo
La poesia si sviluppa in versi liberi, con una struttura che alterna momenti di attesa sospesa a un’affermazione di speranza, culminando in una percezione quasi mistica.
1. L’Attesa Sospesa e la Solitudine (vv. 1-13) La lirica si apre con un’immagine di intensa vigilanza: “Dall’immagine tesa / vigilo l’istante / con imminenza di attesa”. L'”immagine tesa” può riferirsi sia a una tensione interiore del poeta, sia a un’immagine visiva che lo tiene in uno stato di allerta. L’attesa è “imminente”, suggerendo che qualcosa è sul punto di accadere. Tuttavia, questa tensione è paradossalmente vuota: “e non aspetto nessuno”. Questa ripetizione (vv. 4, 9, 13) enfatizza un senso di solitudine e di attesa senza oggetto, un’inquietudine esistenziale.
Il poeta si concentra su dettagli sensoriali minimi: “nell’ombra accesa / spio il campanello / che impercettibile spande / un polline di suono”. L’ossimoro “ombra accesa” suggerisce una luce fioca o una percezione acuta nel buio. Il “campanello” e il “polline di suono” indicano una percezione quasi impercettibile, un suono così tenue da essere quasi una sensazione tattile o visiva. Questa attenzione ai dettagli minimi rivela una sensibilità estrema, tipica di chi è solo e si aggrappa a ogni stimolo esterno. Lo spazio circostante è descritto come “fra quattro mura / stupefatte di spazio / più che un deserto”, un’immagine potente che amplifica il senso di vuoto e isolamento. Le mura sono “stupefatte” dalla loro stessa immensità, che diventa più opprimente di un deserto, sottolineando l’assenza di presenza umana.
2. La Certezza di una Venuta (vv. 14-18) Il tono cambia bruscamente con l’affermazione “Ma deve venire, / verrà”. La negazione dell’attesa (“non aspetto nessuno”) viene superata da una certezza quasi profetica. La venuta è condizionata dalla resistenza del poeta a “sbocciare non visto”, ovvero a non rivelarsi o a non consumarsi prematuramente. La venuta sarà “d’improvviso, / quando meno l’avverto”, sottolineando la natura inaspettata e forse trascendente di ciò che arriverà. È una venuta che non dipende dalla volontà o dall’attesa razionale, ma da una forza superiore o da un destino.
3. La Natura Redentrice della Venuta (vv. 19-26) La parte finale della poesia descrive la natura di questa venuta, che assume connotazioni salvifiche e consolatorie:
- “Verrà quasi perdono / di quanto fa morire”: Ciò che verrà porterà sollievo e redenzione dalle sofferenze che affliggono la vita e la portano alla morte.
- “verrà a farmi certo / del suo e mio tesoro”: Questa venuta porterà una certezza, una rivelazione di un “tesoro” condiviso, che appartiene sia all’entità che viene sia al poeta. È una scoperta di valore reciproco e profondo.
- “verrà come ristoro / delle mie e sue pene”: Sarà un sollievo dalle sofferenze, sia quelle del poeta che quelle dell’altro (o dell’entità che viene). Questo suggerisce una condivisione del dolore e una reciproca consolazione.
- “verrà, forse già viene / il suo bisbiglio”: L’ultima immagine è di una percezione quasi impercettibile, un “bisbiglio”, che richiama il “polline di suono” del campanello. La venuta non è un evento fragoroso, ma una presenza sottile, quasi un sussurro che si manifesta nel silenzio e nell’attesa. Il “forse già viene” lascia aperta la possibilità che la rivelazione sia già in atto, percepibile solo a un livello quasi impercettibile.
Temi Principali:
- L’Attesa e la Rivelazione: La poesia è una profonda meditazione sull’attesa, che da vuota e solitaria si trasforma in una certezza di una venuta salvifica.
- Solitudine e Incomunicabilità: Il senso di vuoto e l’assenza di “nessuno” sottolineano la condizione di isolamento dell’io.
- Percezione Sensoriale e Spiritualità: L’attenzione ai dettagli minimi (il suono, l’ombra) e la loro trasformazione in presagi di una rivelazione spirituale.
- La Grazia e la Redenzione: La venuta è descritta in termini di “perdono” e “ristoro”, suggerendo una dimensione di salvezza o di liberazione dal dolore.
- Il Mistero e l’Improvviso: La venuta è inaspettata (“d’improvviso”) e si manifesta in modo sottile (“bisbiglio”), sottolineando la natura misteriosa della rivelazione.
Stile e Linguaggio: Rebora utilizza uno stile essenziale, con versi brevi e un ritmo che mima l’ansia dell’attesa e la delicatezza della percezione.
- Anafora: La ripetizione di “e non aspetto nessuno” e “verrà” crea un effetto di insistenza e di progressione emotiva.
- Ossimori: “ombra accesa” è un esempio di figura retorica che crea un’immagine vivida e paradossale.
- Immagini Sensoriali: L’uso di “polline di suono” e “bisbiglio” rende la percezione quasi sinestetica.
- Linguaggio Essenziale: La prosa è asciutta, ma carica di significato, tipica della fase più matura e introspettiva di Rebora.
- Punteggiatura: L’uso dei trattini e degli spazi bianchi contribuisce a creare pause e a enfatizzare il ritmo e il senso di sospensione.
Conclusione
“Dall’immagine tesa” è una delle poesie più emblematiche di Clemente Rebora, che condensa in pochi versi la sua profonda ricerca spirituale e la sua indagine sulla condizione umana. La lirica è un inno all’attesa, non come passività, ma come tensione vigile verso una rivelazione che, pur inattesa e sottile, promette perdono e ristoro. È una poesia che invita a guardare oltre la solitudine e il vuoto, a percepire il “bisbiglio” di una presenza che può donare senso e certezza, anche nel cuore del mistero.