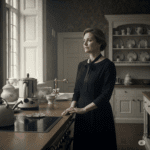
Un fiocco nero di Hans Christian Andersen
28 Dicembre 2019
Canto ventiquattresimo del Paradiso
28 Dicembre 2019Analisi e testo del Proemio dei “Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio” di Niccolò Machiavelli
Analisi del Proemio dei “Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio” di Niccolò Machiavelli
Il Proemio dei “Discorsi” è un’introduzione fondamentale al pensiero politico di Machiavelli, in cui l’autore esplicita le motivazioni, gli intenti e la metodologia della sua opera. A differenza de “Il Principe”, che è un trattato sul principato, i “Discorsi” si concentrano sulla repubblica e sulla storia romana, offrendo una riflessione più ampia sulla politica e sulla natura umana.
1. La Natura Invidiosa degli Uomini e l’Innovazione (paragrafi 1-2)
Machiavelli apre il Proemio riconoscendo la difficoltà e il pericolo intrinseco nel proporre “modi ed ordini nuovi”. La natura umana è descritta come “invida”, ovvero più incline a biasimare che a lodare ciò che è nuovo. Nonostante questa consapevolezza, Machiavelli si dichiara spinto da un “naturale desiderio” di operare per il “comune benefizio”. Questo sottolinea un intento civico e patriottico che differenzia i “Discorsi” dall’immagine più cinica che a volte si attribuisce a “Il Principe”.
Egli è consapevole che la sua “povertà d’ingegno”, la “poca esperienza delle cose presenti” e la “debole notizia delle antiche” potrebbero rendere il suo sforzo “difettivo”. Tuttavia, il suo scopo non è tanto l’immediato successo personale, quanto piuttosto l’apertura di una nuova strada (“una via, la quale non essendo stata per ancora da alcuno pesta”), che altri, con maggiore “virtù, discorso e giudizio”, potranno perfezionare. Questo denota un’umiltà intellettuale e al contempo una fiducia nell’importanza del suo progetto.
2. L’Ammirazione Smodata per l’Antichità e la Mancanza di Imitazione (paragrafi 3-4)
Il cuore del Proemio risiede nella critica di Machiavelli all’atteggiamento dei suoi contemporanei nei confronti dell’antichità. Egli osserva con stupore e dolore (“maravigli e dolga”) come si tributi un enorme onore a frammenti materiali dell’antichità (come una statua antica, che viene “comperata gran prezzo” e imitata dagli artisti), mentre le “virtuosissime operazioni” politiche e militari degli antichi Romani, così come le loro leggi e ordinamenti, siano più ammirate che imitate.
Machiavelli evidenzia una profonda contraddizione: nella medicina e nel diritto civile, si fa costantemente ricorso ai giudizi e ai rimedi degli antichi (“le leggi civili non sono altro che sentenze date dagli antichi jureconsulti”; “nè ancora la medicina è altro che esperienza fatta dagli antichi medici”). Eppure, nell’ambito più cruciale dell’organizzazione dello Stato, della guerra, dell’amministrazione della giustizia e dell’accrescimento dell’impero, non si trova “nè Principe, nè Repubblica, nè Capitano, nè cittadino che agli esempj degli antichi ricorra”.
3. Le Cause della Mancata Imitazione e l’Errore degli Uomini (paragrafo 5)
Machiavelli attribuisce questa grave lacuna a diverse cause:
- La “debolezza nella quale la presente educazione ha condotto il Mondo”: un’educazione che non valorizza l’azione politica e militare.
- Il “male che uno ambizioso ozio ha fatto a molte provincie e città cristiane”: una critica implicita alla decadenza morale e alla passività politica.
- Ma soprattutto, la “non avere vera cognizione delle Istorie”: gli uomini leggono le storie antiche con piacere, ma si fermano alla “varietà degli accidenti”, senza coglierne il “senso” profondo o il “sapore” che hanno in sé.
L’errore più grande, secondo Machiavelli, è giudicare l’imitazione degli antichi “non solo difficile, ma impossibile”. Questo implica una falsa convinzione che la natura umana, il “cielo, il sole, gli elementi, gli uomini fossero variati di moto, di ordine e di potenza, da quello ch’egli erano anticamente”. Machiavelli, al contrario, crede nella costante e immutabile natura umana, e pertanto nella validità universale e atemporale degli insegnamenti storici. Se la natura umana non è cambiata, allora le soluzioni politiche che hanno funzionato in passato possono funzionare anche nel presente.
4. L’Intento dei “Discorsi”: Trarre Utilità dalla Storia (paragrafo 6)
Per “trarre gli uomini di questo errore”, Machiavelli si propone di scrivere sui libri di Tito Livio, commentandoli e traendo da essi ciò che egli giudica “necessario per maggiore intelligenza di essi”. L’obiettivo finale è che i lettori possano “trarne quella utilità, per la quale si debbe ricercare la cognizione della Istoria”. La storia non è quindi un semplice racconto di eventi passati, ma una maestra di vita politica, un laboratorio di esperienze da cui trarre insegnamenti pratici per il governo degli Stati. L’utilità è il criterio guida della sua indagine.
Machiavelli riconosce la difficoltà dell’impresa, ma, incoraggiato da altri, confida di poterla portare avanti, magari lasciando “breve cammino” a chi volesse seguirlo.
Lo Stile del Proemio e de “Il Principe” a Confronto
Mentre il Proemio dei “Discorsi” condivide alcune caratteristiche stilistiche con “Il Principe”, presenta anche delle peculiarità che ne riflettono la diversa natura e il diverso pubblico.
Similitudini con “Il Principe”:
- Chiarezza e Precisione: Anche qui la prosa è chiara, diretta e incisiva, mirata a comunicare idee con efficacia.
- Logica Argomentativa: La struttura del pensiero è rigorosa, con l’esposizione di un problema (la mancata imitazione degli antichi), l’analisi delle cause e la proposta di una soluzione (la scrittura dei “Discorsi”).
- Riferimento all’Esperienza e alla Storia: L’argomentazione si fonda sull’osservazione della realtà presente e sull’analisi della storia (in questo caso, l’ammirazione delle statue contro l’indifferenza per le virtù antiche).
Differenze dallo Stile de “Il Principe”:
- Tono più Riflessivo e Didattico: Se ne “Il Principe” il tono è spesso quello del consigliere pragmatico e talvolta assertivo, nei “Discorsi” emerge un tono più riflessivo, da studioso e maestro. L’obiettivo è quello di educare e guidare i lettori alla comprensione della storia e alla sua applicazione pratica.
- Meno Immediatezza e Maggiore Profondità Teorica: I “Discorsi” sono un’opera più estesa e teorica. Il Proemio stesso è più elaborato e argomentato rispetto alla brevità e alla concisione quasi perentoria del Proemio de “Il Principe”.
- Riferimento Esplicito all’Utilità Comune: L’intento di “rechino comune benefizio a ciascuno” è qui esplicitamente dichiarato, accentuando la dimensione civica e morale del progetto.
- Uso della Ipostasi e della Personificazione: L’invida natura degli uomini, la storia che non viene letta con “senso” o “sapore” sono esempi di come Machiavelli renda astratti i concetti.
- Ricorso all’Autorità di Tito Livio: L’intera opera è costruita come un commento a Livio, il che conferisce un’aura di maggiore erudizione e un legame più stretto con la tradizione storiografica.
In conclusione, il Proemio dei “Discorsi” è una dichiarazione di intenti programmatici. Machiavelli si presenta come un innovatore audace che, nonostante l’invidia umana, si propone di ripristinare il valore pratico della storia antica, convinto che il passato, se ben compreso e imitato, possa fornire gli strumenti per superare la crisi politica e morale del presente e costruire una repubblica virtuosa.

Machiavelli sostiene l’idea della riscoperta e dell’utilità degli insegnamenti storici
Testo del Proemio dei “Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio” di Niccolò Machiavelli
Niccolò Machiavelli – Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio (edizione 1824) (XVI secolo)
Ancora che per la invida natura degli uomini sia sempre stato pericoloso il trovare modi ed ordini nuovi, quando il cercare acque e terre incognite, per essere quelli più pronti a biasimare che a laudare le azioni d’altri; nondimeno spinto da quel naturale desiderio, che fu sempre in me, di operare senz’alcun rispetto quelle cose che io creda rechino comune benefizio a ciascuno, ho deliberato entrare per una via, la quale non essendo stata per ancora da alcuno pesta, se la mi arrecherà fastidio e difficultà, mi potrebbe ancora arrecare premio, mediante quelli che umanamente di queste mie fatiche considerassero. E se l’ingegno povero, la poca esperienza delle cose presenti, la debole notizia delle antiche, faranno questo mio conato difettivo e di non molta utilità, daranno almeno la via ad alcuno, che con più virtù, più discorso e giudizio, potrà a questa mia intenzione satisfare; il che se non mi arrecherà laude, non mi dovrebbe partorire biasimo.
E quando io considero quanto onore si attribuisca all’antichità, e come molte volte, lasciando andare molti altri esempj, un fragmento d’un’antica statua sia stato comperato gran prezzo, per averlo appresso di sè, onorarne la sua casa, poterlo fare imitare da coloro che di quell’arte si dilettano, e come quelli poi con ogn’industria si sforzano in tutte le loro opere rappresentarlo; e veggendo dall’altro canto le virtuosissime operazioni che le Istorie ci mostrano, che sono state operate da Regni e da Repubbliche antiche, dai Re, capitani, cittadini, datori di leggi, ed altri che si sono per la loro patria affaticati, essere più presto ammirate che imitate, anzi in tanto da ciascuno in ogni parte fuggite, che di quella antica virtù non ci è rimaso alcun segno, non posso fare che insieme non me ne maravigli e dolga; e tanto più, quanto io veggio nelle differenze che intra i cittadini civilmente nascono, o nelle malattie, nelle quali gli uomini incorrono, essersi sempre ricorso a quelli giudizj, o a quelli rimedj, che dagli antichi sono stati giudicati o ordinati.
Perchè le leggi civili non sono altro che sentenze date dagli antichi jureconsulti, le quali, ridotte in ordine, a’ presenti nostri jureconsulti giudicare insegnano; nè ancora la medicina è altro che esperienza fatta dagli antichi medici, sopra la quale fondano i medici presenti li loro giudizj. Nondimeno nello ordinare le Repubbliche, nel mantenere gli Stati, nel governare i Regni, nell’ordinare la milizia, ed amministrare la guerra, nel giudicare i sudditi, nello accrescere lo Imperio, non si trova nè Principe, nè Repubblica, nè Capitano, nè cittadino che agli esempj degli antichi ricorra. Il che mi persuado che nasca, non tanto dalla debolezza nella quale la presente educazione ha condotto il Mondo, o da quel male che uno ambizioso ozio ha fatto a molte provincie e città cristiane, quanto dal non avere vera cognizione delle Istorie, per non trarne, leggendole, quel senso, nè gustare di loro quel sapore che le hanno in sè.
Donde nasce che infiniti che leggono, pigliano piacere di udire quella varietà degli accidenti che in esse si contengono, senza pensare altrimente d’imitarle, giudicando la imitazione non solo difficile, ma impossibile; come se il cielo, il sole, gli elementi, gli uomini fossero variati di moto, di ordine e di potenza, da quello ch’egli erano anticamente. Volendo pertanto trarre gli uomini di questo errore, ho giudicato necessario scrivere sopra tutti quelli libri di Tito Livio, che dalla malignità de’ tempi non ci sono stati interrotti, quello che io secondo le antiche e moderne cose giudicherò essere necessario per maggiore intelligenza di essi, acciocchè coloro che questi miei Discorsi leggeranno, possano trarne quella utilità, per la quale si debbe ricercare la cognizione della Istoria. E benchè questa impresa sia difficile, nondimeno ajutato da coloro, che mi hanno ad entrare sotto a questo peso confortato, credo portarlo in modo, che ad un altro resterà breve cammino a condurlo al luogo destinato.




