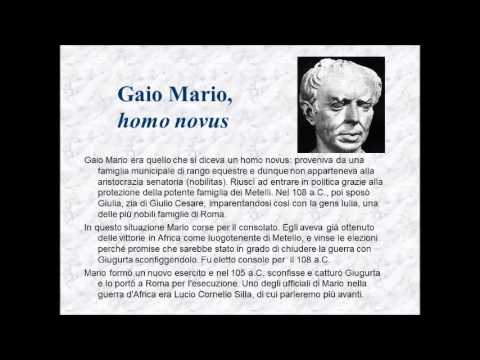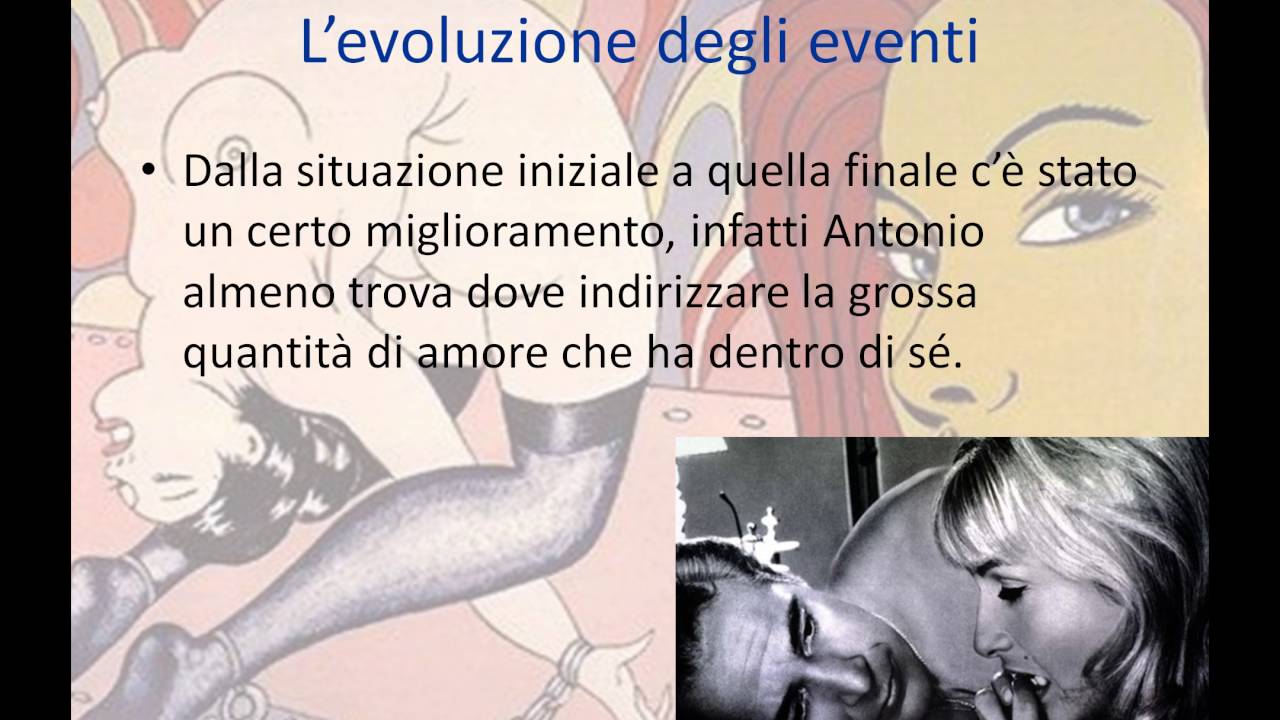
Un amore di Dino Buzzati
28 Dicembre 2019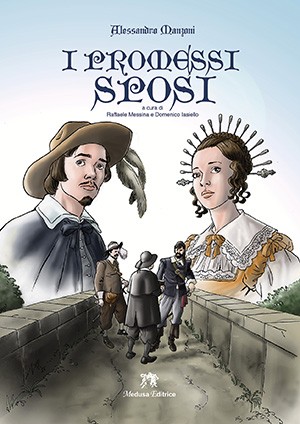
Il sedicesimo capitolo dei Promessi Sposi
28 Dicembre 2019La prima guerra civile tra Gaio Mario e Lucio Cornelio Silla fu una delle conseguenze del profondo dissenso politico e sociale che aveva agitato Roma a partire dalle riforme dei fratelli Gracchi nel II secolo a.C.
Le riforme agrarie e sociali di Tiberio e Gaio Gracco (133-121 a.C.) avevano acceso un conflitto tra due fazioni principali della politica romana: i populares, sostenitori delle riforme popolari, e gli optimates, difensori dell’aristocrazia senatoria e dell’ordine tradizionale.
Contesto: le riforme dei Gracchi e le tensioni sociali
Le riforme dei Gracchi miravano a risolvere la crisi agraria e la povertà crescente tra i contadini romani. Tiberio Gracco cercò di ridistribuire le terre pubbliche (l’ager publicus) ai cittadini romani più poveri, sfidando così il potere dei grandi latifondisti e dell’aristocrazia senatoria. Queste riforme incontrarono una forte opposizione e portarono alla sua morte violenta nel 133 a.C. Gaio Gracco, fratello minore di Tiberio, proseguì con ulteriori riforme (anche politiche), tra cui l’estensione della cittadinanza agli alleati italici, provocando ulteriori tensioni e una reazione violenta che culminò con la sua morte nel 121 a.C.
Nonostante la sconfitta dei Gracchi, il loro programma politico aveva seminato i germi del conflitto tra i populares (che cercavano di rafforzare il potere delle assemblee popolari e il ruolo dei tribuni della plebe) e gli optimates (che cercavano di mantenere il potere nelle mani del Senato e dell’aristocrazia). Questo conflitto si sarebbe amplificato nei decenni successivi, fino a esplodere nella guerra civile tra Mario e Silla.
Gaio Mario: il generale dei populares
Gaio Mario era un homo novus, cioè il primo della sua famiglia a raggiungere posizioni di grande prestigio a Roma. Era un generale di grande talento e, dopo una serie di brillanti successi militari (tra cui la vittoria sui Cimbri e i Teutoni), divenne una figura di spicco della fazione populare. Mario promosse riforme militari cruciali, come la professionalizzazione dell’esercito, che permise anche ai cittadini senza proprietà di entrare nelle legioni. Questa riforma cambiò la struttura dell’esercito romano, rendendo i soldati più fedeli ai loro comandanti piuttosto che allo Stato, e creò le premesse per il successivo uso politico dell’esercito.
Mario divenne console ben sette volte (un record per l’epoca), e il suo prestigio crebbe immensamente. Tuttavia, con il passare del tempo, la sua posizione politica divenne sempre più conflittuale, soprattutto a causa della sua rivalità con Lucio Cornelio Silla, un generale giovane e ambizioso che si distingueva come sostenitore degli optimates.
Silla e la guerra civile
La rivalità tra Mario e Silla esplose nel 88 a.C., quando Silla fu nominato console e gli fu affidato il comando dell’esercito per condurre la guerra contro Mitridate VI, il re del Ponto, che aveva minacciato i territori romani in Asia Minore. Tuttavia, Mario, desideroso di ottenere il prestigioso comando per sé, riuscì a far votare una legge dall’assemblea popolare per trasferire a lui l’incarico di guidare l’esercito.
Silla, profondamente offeso e sostenuto dal Senato e dagli optimates, prese una decisione senza precedenti nella storia romana: marciò su Roma con il suo esercito, violando il sacro principio che nessun generale poteva entrare in armi nella città. Questo atto segnò il primo vero colpo di stato militare nella storia di Roma e portò alla fuga di Mario dalla città.
Silla ristabilì il suo controllo, riprendendo il comando per la guerra contro Mitridate, ma quando partì per l’Oriente, Mario, approfittando della sua assenza, tornò a Roma con i suoi sostenitori e riprese il potere nel 87 a.C. Tuttavia, il ritorno di Mario fu di breve durata: morì nel 86 a.C., poco dopo aver ripreso il controllo della città.
Seconda guerra civile: il ritorno di Silla
Dopo la morte di Mario, il conflitto non si fermò. Nel 83 a.C., Silla tornò vittorioso dall’Oriente e marciò nuovamente su Roma per affrontare i sostenitori mariani. Questa volta la guerra civile fu particolarmente cruenta, con battaglie in tutta Italia. Silla ottenne una vittoria decisiva nella battaglia di Porta Collina nel 82 a.C. e consolidò il suo potere.
Dopo la vittoria, Silla si dichiarò dittatore a tempo indeterminato (dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae causa), una carica straordinaria che gli permise di governare con poteri assoluti. Durante la sua dittatura, Silla intraprese una serie di proscrizioni, liste di nemici politici (soprattutto mariani) condannati a morte senza processo. Le loro proprietà furono confiscate, e migliaia di cittadini furono eliminati fisicamente o economicamente, rafforzando così il controllo sillano.
Conseguenze della guerra civile
La guerra civile tra Mario e Silla segnò un punto di non ritorno per la Repubblica romana. Sebbene Silla tentasse di ristabilire l’ordine repubblicano attraverso una serie di riforme costituzionali volte a rafforzare il potere del Senato e a limitare quello dei tribuni della plebe, il suo utilizzo della forza militare come strumento politico aprì la strada all’instabilità e alle future guerre civili.
Il conflitto tra Mario e Silla non solo dimostrò la crescente centralità dell’esercito nella politica romana, ma inaugurò una fase di lotte intestine che culminerà nelle guerre civili tra Cesare e Pompeo, e infine nella caduta della Repubblica stessa. Le riforme dei Gracchi avevano messo in luce le tensioni sociali ed economiche latenti, ma fu la guerra civile tra Mario e Silla a rendere evidente che la Repubblica romana era ormai incapace di gestire pacificamente il conflitto tra le sue fazioni politiche.