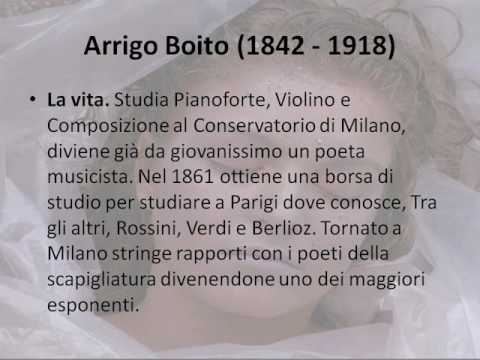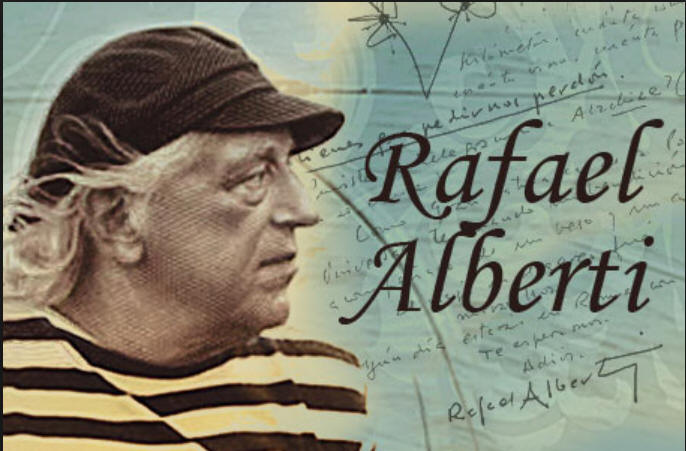
Han sradicato un albero di Rafael Alberti
28 Dicembre 2019
Mediterraneo: economia, stati e conflitti
28 Dicembre 2019Dualismo di Arrigo Boito – Il libro dei versi (1902)
“Dualismo” è una delle poesie più celebri e rappresentative di Arrigo Boito (1842-1918), compositore, librettista e poeta, pubblicata nella raccolta Il libro dei versi del 1900 (anche se il testo qui riportato indica 1902, la prima edizione è del 1877, poi ripubblicata e ampliata). Questa lirica è un manifesto della poetica scapigliata di Boito e, più in generale, del movimento, che si caratterizzava per la ribellione contro il conformismo borghese e per l’esplorazione delle contraddizioni interiori dell’individuo. Il “dualismo” a cui si riferisce il titolo è la profonda scissione che l’autore percepisce in sé stesso e, per estensione, nell’animo umano: la coesistenza di opposti, il bene e il male, l’aspirazione al sublime e l’attrazione per il turpe, il sacro e il profano, l’ideale e il reale.
Analisi del Testo
Strofa 1: L’Identità Scissa
Son luce ed ombra; angelica
Farfalla o verme immondo,
Sono un caduto chèrubo
Dannato a errar sul mondo,
O un demone che sale,
Affaticando l’ale,
Verso un lontano ciel.
La poesia si apre con una dichiarazione perentoria e ossimorica dell’io lirico: “Son luce ed ombra”. Questa antitesi fondamentale definisce immediatamente il tema del dualismo. Seguono una serie di metafore che esprimono la scissione interiore: “angelica Farfalla o verme immondo”, “caduto chèrubo” (angelo decaduto) o “demone che sale”. L’immagine del cherubino caduto suggerisce una purezza originaria corrotta, mentre il demone che ascende indica una possibile redenzione o un’ambizione spirituale, pur partendo dal basso. La condizione è di “errare sul mondo”, un senso di smarrimento e condanna.
Strofa 2: Le Voci Interiori
Ecco perchè nell’intime
Cogitazioni io sento
La bestemmia dell’angelo
Che irride al suo tormento,
O l’umile orazione
Dell’esule dimone
Che riede a Dio, fedel.
Il “dualismo” si manifesta nelle “intime cogitazioni” del poeta. Egli percepisce due voci contrastanti: la “bestemmia dell’angelo” che, caduto, si ribella e si beffa della propria sofferenza, e l'”umile orazione” del demone “esule” che, al contrario, cerca la redenzione e ritorna a Dio. Questa strofa approfondisce la natura del conflitto: non è solo una coesistenza di opposti, ma una lotta tra ribellione e sottomissione, tra orgoglio e umiltà.
Strofa 3: Le Emozioni Contraddittorie
Ecco perchè m’affascina
L’ebbrezza di due canti,
Ecco perchè mi lacera
L’angoscia di due pianti,
Ecco perchè il sorriso
Che mi contorce il viso
O che m’allarga il cuor.
Il dualismo si estende alle emozioni e alle reazioni psicologiche. Il poeta è attratto da “due canti” (simbolo di gioia e dolore, o di ispirazioni contrastanti) e lacerato da “due pianti”. Il sorriso stesso è ambivalente: può “contorcere il viso” (amarezza, ironia, dolore mascherato) o “allargare il cuor” (gioia genuina). Questa strofa evidenzia l’incapacità di provare un’emozione pura, essendo ogni sentimento contaminato dal suo opposto.
Strofa 4: I Pensieri e l’Arte
Ecco perchè la torbida
Ridda de’ miei pensieri,
Or mansüeti e rosei.
Or violenti e neri;
Ecco perchè, con tetro
Tedio, avvicendo il metro
De’ carmi animator.
Il conflitto si riflette anche nella sfera intellettuale e artistica. I pensieri sono una “torbida ridda” (danza confusa) che oscillano tra l’innocenza (“mansüeti e rosei”) e la violenza (“violenti e neri”). Questa instabilità interiore si proietta sulla creazione artistica: il poeta, con “tetro tedio”, alterna il “metro de’ carmi animator”, suggerendo una difficoltà o una stanchezza nel mantenere una coerenza stilistica, quasi che l’ispirazione stessa sia soggetta a questa scissione.
Strofa 5 e 6: La Condizione Umana e un Dio Indifferente
O creature fragili
Dal genio onnipossente!
Forse noi siam l’homunculus
D’un chimico demente,
Forse di fango e foco
Per ozïoso gioco
Un buio Iddio ci féE ci scagliò sull’umida
Gleba che c’incatena,
Poi dal suo ciel guatandoci
Rise alla pazza scena,
E un dì a distrar la noia
Della sua lunga gioia
Ci schiaccerà col piè.
La riflessione si allarga dalla condizione individuale a quella universale dell’uomo. Gli esseri umani sono “creature fragili” create da un “genio onnipossente” che viene però descritto in termini inquietanti: un “chimico demente” o un “buio Iddio”. Questa è una visione profondamente pessimistica e materialistica della creazione, tipica della Scapigliatura, che rigetta l’idea di un Dio benevolo. L’uomo è un “homunculus”, una creazione artificiale e imperfetta, fatta “di fango e foco” per un “ozioso gioco” divino. Il Dio di Boito è indifferente e crudele: ci ha “scagliati” sulla “gleba che c’incatena” (la terra come prigione) e ci osserva dall’alto ridendo della “pazza scena” della nostra esistenza. L’apice del cinismo è l’idea che un giorno, per “distrar la noia della sua lunga gioia”, ci “schiaccerà col piè”. È una visione nichilista e deterministica, dove l’uomo è un giocattolo nelle mani di un’entità superiore capricciosa e disinteressata.
Strofa 7: L’Esistenza Famelica
E noi viviam, famelici
Di fede o d’altri inganni,
Rigirando il rosario
Monotono degli anni,
Dove ogni gemma brilla
Di pianto, acerba stilla
Fatta d’acerbo duol.
L’uomo vive “famelico di fede o d’altri inganni”, indicando una sete inappagata di senso, che sia una fede autentica o una semplice illusione consolatoria. La vita è un “rosario monotono degli anni”, una successione ripetitiva di sofferenze (“ogni gemma brilla di pianto, acerba stilla / Fatta d’acerbo duol”). L’immagine del rosario, strumento di preghiera, viene qui svuotata del suo significato sacro e trasformata in simbolo di una ripetizione dolorosa e priva di speranza.
Strofa 8: La Speranza del Demone Redento
Talor, se sono il dèmone
Redento che s’indìa,
Sento dall’alma effondersi
Una speranza pia
E sul mio buio viso
Del gaio paradiso
Mi fulgureggia il sol.
Questa strofa introduce un barlume di speranza, ma sempre nell’ottica del dualismo. Se il poeta si identifica con il “demone redento che s’indìa” (che si divinizza, che ascende a Dio), allora sente una “speranza pia” e il suo “buio viso” viene illuminato dal “sol” del “gaio paradiso”. È un momento di elevazione spirituale, ma è “talor” (talvolta), suggerendo che non è una condizione stabile, bensì un’oscillazione.
Strofa 9 e 10: L’Illusione e l’Estro Creativo
L’illusïon — libellula
Che bacia i fiorellini
— L’illusïon — scoiattolo
Che danza in cima i pini
— L’illusïon — fanciulla
Che trama e si trastulla
Colle fibre del cor,Viene ancora a sorridermi
Nei dì più mesti e soli
E mi sospinge l’anima
Ai canti, ai carmi, ai voli;
E a turbinar m’attira
Nella profonda spira
Dell’estro idëator.
L'”illusione” è presentata con una serie di metafore leggere e vitali (“libellula”, “scoiattolo”, “fanciulla”). Questa illusione, pur essendo tale, ha un potere salvifico: “viene ancora a sorridermi / Nei dì più mesti e soli” e spinge l’anima “ai canti, ai carmi, ai voli”, cioè alla creazione artistica. L’illusione è la forza motrice dell'”estro ideatore”, che trascina il poeta nella “profonda spira” della creatività. Qui l’arte è vista come un rifugio, una via di fuga dalla desolazione della realtà.
Strofa 11: Il Sogno di un’Arte Eterea
E sogno un’Arte eterea
Che forse in cielo ha norma,
Franca dai rudi vincoli
Del metro e della forma,
Piena dell’Ideale
Che mi fa batter l’ale
E che seguir non so.
Il poeta sogna un’Arte “eterea”, quasi divina, libera dai “rudi vincoli del metro e della forma” (un’aspirazione alla libertà artistica, tipica della Scapigliatura che si opponeva alle convenzioni). Questa Arte è “piena dell’Ideale”, un concetto platonico di perfezione che lo spinge a un’elevazione, ma che egli “non sa seguire”, sottolineando l’irraggiungibilità dell’assoluto.
Strofa 12: Il Risveglio dell’Angelo Fiaccato
Ma poi, se avvien che l’angelo
Fiaccato si ridesti,
I santi sogni fuggono
Impäuriti e mesti;
Allor, davanti al raggio
Del mutato miraggio,
Quasi rapito, sto.
Il momento di elevazione è effimero. Quando l'”angelo fiaccato” (la parte più nobile e spirituale del poeta, ma indebolita) si ridesta, i “santi sogni” (le aspirazioni ideali) fuggono. Il “mutato miraggio” suggerisce un cambiamento di prospettiva, una disillusione che lo lascia “quasi rapito”, attonito di fronte alla nuova, più cruda, realtà.
Strofa 13 e 14: Il Sogno di un’Arte Reproba e la Bestemmia
E sogno allor la magica
Circe col suo corteo
D’alci e di pardi, attoniti
Nel loro incanto reo.
E il cielo, altezza impervia.
Derido e di protervia
Mi pasco e di velen.E sogno un’Arte reproba
Che smaga il mio pensiero
Dietro le basse imagini
D’un ver che mente al Vero
E in aspro carme immerso
Sulle mie labbra il verso
Bestemmïando vien.
Dopo la fuga dei sogni ideali, il poeta si volge verso un’altra forma d’arte, quella “reproba” (malvagia, condannabile). Questa arte è associata a Circe, simbolo di seduzione e trasformazione in bestia, e a un corteo di animali attoniti nel loro “incanto reo”. Il poeta deride il “cielo, altezza impervia”, nutrendosi di “protervia” (arroganza) e “veleno”. L’Arte “reproba” lo spinge verso “basse immagini”, verso “un ver che mente al Vero”, cioè una verità terrena e imperfetta che si oppone alla Verità ideale. Il verso finale è potentissimo: “Sulle mie labbra il verso / Bestemmïando vien”. L’atto creativo, che prima era spinto dall’illusione e dall’Ideale, ora si manifesta come blasfemia, come espressione di ribellione e disprezzo. È il trionfo della parte “demoniaca” e malvagia del dualismo.
Strofa 15 e 16: La Vita come Agitarsi Eterno
Questa è la vita! l’ebete
Vita che c’innamora.
Lenta che pare un secolo,
Breve che pare un’ora;
Un agitarsi alterno
Fra paradiso e inferno
Che non s’accheta più!Come istrïon, su cupida
Plebe di rischio ingorda,
Fa pompa d’equilibrio
Sovra una tesa corda,
Tale è l’uman, librato
Fra un sogno di peccato
E un sogno di virtù.
Le ultime due strofe riassumono la condizione umana, definendo la vita come “ebete” (stupida, insensata) ma al tempo stesso capace di “innamorare”. È un paradosso temporale (“Lenta che pare un secolo, / Breve che pare un’ora”) che ne sottolinea la natura contraddittoria. La vita è un “agitarsi alterno / Fra paradiso e inferno / Che non s’accheta più!”, una continua oscillazione senza pace. La poesia si chiude con una similitudine che condensa il senso del dualismo: l’uomo è come un “istrïon” (acrobata, giocoliere) che, davanti a una “cupida plebe di rischio ingorda”, fa “pompa d’equilibrio / Sovra una tesa corda”. L’uomo è “librato” (in equilibrio precario) “fra un sogno di peccato / E un sogno di virtù”. La vita è una performance, una lotta costante per mantenere un equilibrio impossibile tra le forze opposte che lo animano.
Temi e Stile
- Il Dualismo Interiore: È il tema centrale, espresso attraverso una serie di antitesi e ossimori (luce/ombra, farfalla/verme, angelo/demone, canti/pianti, rosei/neri, paradiso/inferno, peccato/virtù). Boito esplora la scissione dell’io, la coesistenza di impulsi contrastanti.
- La Condizione Umana: Una visione pessimistica e nichilista della vita, vista come un’esistenza futile, governata da un Dio indifferente o malevolo. L’uomo è fragile, un “homunculus” destinato alla sofferenza e alla distruzione.
- L’Arte e l’Ispirazione: L’arte è sia un rifugio (l’illusione che spinge ai “canti”) sia un campo di battaglia per il dualismo interiore, potendo manifestarsi come “Arte eterea” (ideale) o “Arte reproba” (blasfema, legata al “ver che mente al Vero”).
- La Scapigliatura: La poesia è un manifesto della Scapigliatura per i suoi temi (ribellione, pessimismo, rifiuto del conformismo, attrazione per il “brutto” e il “vero”) e per il suo stile (linguaggio a tratti crudo, immagini forti, uso di ossimori e antitesi).
- Stile e Linguaggio:
- Linguaggio Forte e Incisivo: Boito usa termini potenti (“immondo”, “bestemmia”, “torbida”, “tetro tedio”, “velen”, “reproba”, “ebete”).
- Metafore e Similitudini: Ricchezza di immagini che rendono tangibile il conflitto interiore (farfalla/verme, cherubino/demone, rosario degli anni, istrione sulla corda).
- Anafora: La ripetizione di “Ecco perché” e “E sogno” crea un ritmo incalzante e sottolinea la causa delle manifestazioni del dualismo.
- Struttura Circolare: La poesia inizia e finisce con l’affermazione del dualismo, chiudendo il cerchio della riflessione sulla condizione umana.
- Musicalità: Nonostante i temi cupi, la poesia mantiene una certa musicalità, tipica di Boito compositore, attraverso l’uso del metro e delle rime.
Conclusione
“Dualismo” di Arrigo Boito è un’opera emblematica che cattura l’essenza della Scapigliatura e la profonda crisi esistenziale dell’individuo moderno. Attraverso una serie di immagini potenti e contraddittorie, il poeta esplora la scissione tra gli impulsi opposti che animano l’essere umano, la sua fragilità di fronte a un’esistenza governata da un destino crudele e la sua ricerca di un senso, anche nell’arte, che però si rivela anch’essa ambivalente. La poesia è un grido di ribellione e disillusione, ma anche una lucida analisi della condizione umana, condannata a un eterno “agitarsi alterno fra paradiso e inferno”.

Son luce ed ombra; angelica
Farfalla o verme immondo,
Sono un caduto chèrubo
Dannato a errar sul mondo,
O un demone che sale,
Affaticando l’ale,
Verso un lontano ciel.
Ecco perchè nell’intime
Cogitazioni io sento
La bestemmia dell’angelo
Che irride al suo tormento,
O l’umile orazione
Dell’esule dimone
Che riede a Dio, fedel.
Ecco perchè m’affascina
L’ebbrezza di due canti,
Ecco perchè mi lacera
L’angoscia di due pianti,
Ecco perchè il sorriso
Che mi contorce il viso
O che m’allarga il cuor.
Ecco perchè la torbida
Ridda de’ miei pensieri,
Or mansüeti e rosei.
Or violenti e neri;
Ecco perchè, con tetro
Tedio, avvicendo il metro
De’ carmi animator.
O creature fragili
Dal genio onnipossente!
Forse noi siam l’homunculus
D’un chimico demente,
Forse di fango e foco
Per ozïoso gioco
Un buio Iddio ci fé
E ci scagliò sull’umida
Gleba che c’incatena,
Poi dal suo ciel guatandoci
Rise alla pazza scena,
E un dì a distrar la noia
Della sua lunga gioia
Ci schiaccerà col piè.
E noi viviam, famelici
Di fede o d’altri inganni,
Rigirando il rosario
Monotono degli anni,
Dove ogni gemma brilla
Di pianto, acerba stilla
Fatta d’acerbo duol.
Talor, se sono il dèmone
Redento che s’indìa,
Sento dall’alma effondersi
Una speranza pia
E sul mio buio viso
Del gaio paradiso
Mi fulgureggia il sol.
L’illusïon — libellula
Che bacia i fiorellini
— L’illusïon — scoiattolo
Che danza in cima i pini
— L’illusïon — fanciulla
Che trama e si trastulla
Colle fibre del cor,
Viene ancora a sorridermi
Nei dì più mesti e soli
E mi sospinge l’anima
Ai canti, ai carmi, ai voli;
E a turbinar m’attira
Nella profonda spira
Dell’estro idëator.
E sogno un’Arte eterea
Che forse in cielo ha norma,
Franca dai rudi vincoli
Del metro e della forma,
Piena dell’Ideale
Che mi fa batter l’ale
E che seguir non so.
Ma poi, se avvien che l’angelo
Fiaccato si ridesti,
I santi sogni fuggono
Impäuriti e mesti;
Allor, davanti al raggio
Del mutato miraggio,
Quasi rapito, sto.
E sogno allor la magica
Circe col suo corteo
D’alci e di pardi, attoniti
Nel loro incanto reo.
E il cielo, altezza impervia.
Derido e di protervia
Mi pasco e di velen.
E sogno un’Arte reproba
Che smaga il mio pensiero
Dietro le basse imagini
D’un ver che mente al Vero
E in aspro carme immerso
Sulle mie labbra il verso
Bestemmïando vien.
Questa è la vita! l’ebete
Vita che c’innamora.
Lenta che pare un secolo,
Breve che pare un’ora;
Un agitarsi alterno
Fra paradiso e inferno
Che non s’accheta più!
Come istrïon, su cupida
Plebe di rischio ingorda,
Fa pompa d’equilibrio
Sovra una tesa corda,
Tale è l’uman, librato
Fra un sogno di peccato
E un sogno di virtù.