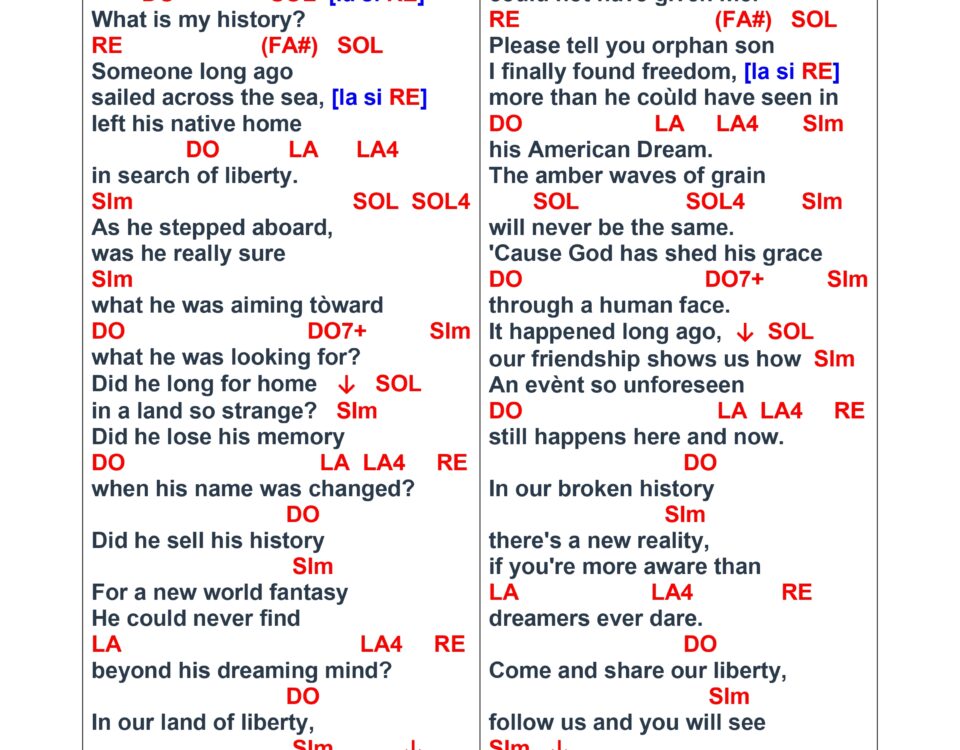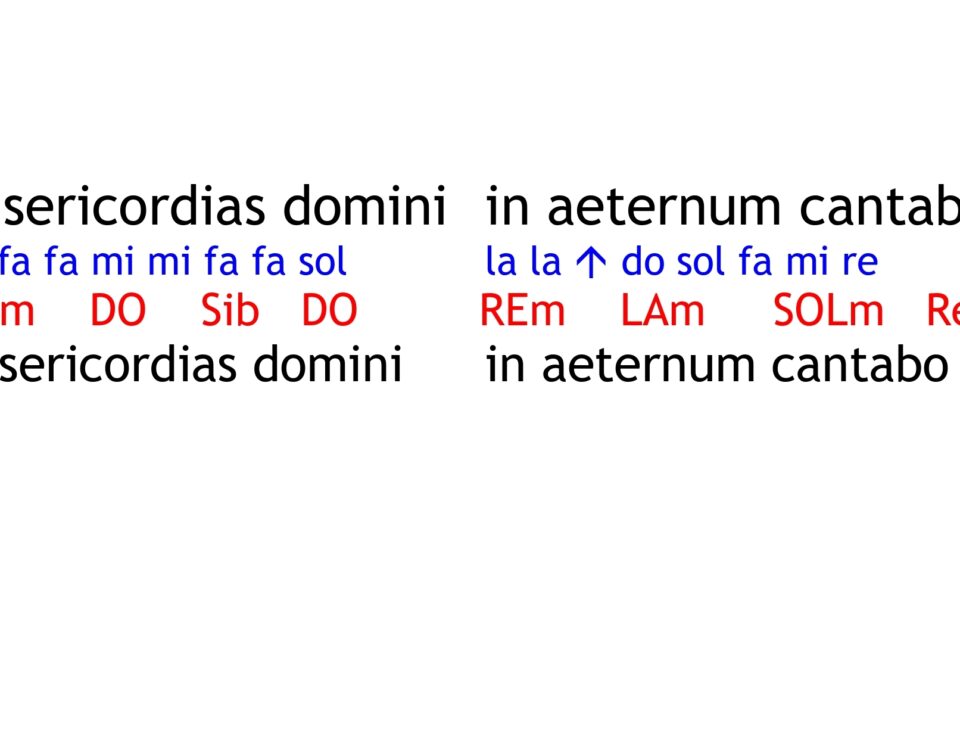Introduzione al secondo capitolo dei Promessi Sposi
28 Dicembre 2019
L’introduzione dell’anonimo al romanzo di Manzoni
28 Dicembre 2019📚 Analisi della Fine del Capitolo Primo e dell’Inizio del Capitolo Secondo de ‘I Promessi Sposi’
La transizione tra il Capitolo Primo e il Capitolo Secondo de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni è fluida e cruciale, fungendo da ponte narrativo e approfondendo la psicologia dei personaggi di fronte al sopruso di Don Rodrigo. Questi passaggi non solo proseguono l’azione, ma svelano con maestria la viltà del curato, l’ingenuità e la crescente furia di Renzo, e la sottile introduzione della figura di Perpetua, ponendo le basi per il dramma che si dispiegherà.
Fine del Capitolo Primo: La Notte Angosciosa di Don Abbondio
La chiusura del Capitolo Primo è interamente dedicata al tormento interiore di Don Abbondio dopo l’incontro con i Bravi. Manzoni ci introduce nel suo “capo basso”, dove “ronzavano tumultuariamente” pensieri di paura e calcolo egoistico. Lo spavento per i “visacci” e le “parolacce”, unito alla consapevolezza della minaccia di Don Rodrigo – “un signore noto per non minacciare invano” – distrugge il suo “sistema di quieto vivere”, una vita costruita sulla massima prudenza e sull’evitare ogni conflitto.
Il monologo interiore di Don Abbondio rivela una profonda codardia mascherata da ragionevolezza. Egli scarta ogni opzione che implichi un rischio:
- Celebrare il matrimonio: Impensabile, per timore dei Bravi e del “ehm!” rimbombante nella sua mente. Si pente persino di averne parlato con Perpetua.
- Confidare a Renzo l’accaduto: Impossibile, per la paura della reazione del giovane e delle ritorsioni di Don Rodrigo.
- Fuggire: Troppo “impicci, e quanti conti da rendere”, un’opzione impraticabile per la sua indole statica e abitudinaria.
La sua autoassoluzione è patetica e comica: “Che c’entro io? Son io che voglio maritarmi?”. La sua stizza si rivolge contro Don Rodrigo e persino contro Renzo e Lucia, che lo “mettono in travagli”. La sua ipocrisia emerge quando si pente di non aver suggerito ai Bravi di rivolgersi a qualcun altro per l’imbasciata, ma subito si corregge, riconoscendo l’iniquità di tale pensiero. La sua conclusione è sempre la stessa: la sua pelle è più importante di ogni dovere o principio. Manzoni dipinge qui una figura di inetto, la cui debolezza morale è la radice di ogni suo atto di omissione e complicità.
L’entrata in scena di Perpetua, la serva di Don Abbondio, conclude il capitolo. Manzoni la presenta come una figura schietta e fedele, ma anche chiacchierona e “tosta”, capace di “ubbidire e comandare, secondo l’occasione”. La sua apparizione, con la curiosità che subito traspare dal suo “occhi esperti”, prepara il terreno per il dialogo del capitolo successivo, dove la sua loquacità si rivelerà involontariamente decisiva.
Inizio del Capitolo Secondo: La Battaglia Interiore e il Confronto Inevitabile
Il Capitolo Secondo si apre con una riflessione metaforica sulla notte di Don Abbondio, paragonata al sonno del Principe di Condé prima di Rocroi. La differenza è abissale: Condé aveva già “date tutte le disposizioni necessarie”, Don Abbondio “non sapeva altro ancora se non che l’indomani sarebbe giorno di battaglia”. Questa è la “battaglia” del suo animo contro la paura e la sua coscienza.
1. La Strategia del Rinvio di Don Abbondio: Il curato trascorre la notte in “consulte angosciose”, culminate nella decisione di guadagnare tempo, “menando Renzo per le lunghe”. Questa strategia, pur “un po’ leggiera”, si basa sulla sua presunta “autorità” e “antica esperienza” contro un “giovanetto ignorante”. Il suo cinico pensiero (“egli pensa alla morosa; ma io penso alla pelle: il più interessato son io, lasciando stare che sono il più accorto”) conferma la sua priorità egoistica. Questo “fermare l’animo a una deliberazione” gli permette di chiudere occhio, ma il sonno è tormentato da incubi, segno che la sua coscienza, per quanto oppressa dalla paura, non è del tutto muta. La mattina, il suo risveglio è “molto amaro”, segnato dalla dolorosa consapevolezza dell’impiccio, che lo spinge a confermare e ordinare meglio i suoi disegni.
2. L’Arrivo di Renzo: La Gioia Contrastata: L’ingresso di Renzo crea un immediato e potente contrapposto. Mentre Don Abbondio è segnato da paura e calcolo, Renzo arriva “con la lieta furia d’un uomo di vent’anni, che deve in quel giorno sposare quella che ama”. Manzoni ne traccia un ritratto accurato:
- Condizione Sociale: Filatore di seta, professione in decadenza ma che gli consente di “vivere onestamente”, possiede anche un “poderetto”. È “agiato” e “provvisto bastantemente” nonostante la “vera carestia” imminente. È un rappresentante del popolo lavoratore, onesto e previdente.
- Aspetto Esterno: È in “gran gala, con penne di vario colore al cappello, col suo pugnale del manico bello”, con un’aria di “festa e nello stesso tempo di braverìa”. Il suo aspetto esteriore riflette l’ingenua gioia e la fiducia nel futuro.
Il contrasto è evidente nell’accoglimento “incerto e misterioso” di Don Abbondio che si scontra con i modi “gioviali e risoluti” del giovane. Renzo, ingenuo e ottimista, inizialmente non coglie la gravità della situazione.
3. Il Dialogo del Rinvio e la Frustrazione di Renzo: Il dialogo tra Don Abbondio e Renzo è un capolavoro di comicità e drammaticità.
- La Tattica di Don Abbondio: Il curato mette in atto la sua strategia del rinvio, utilizzando un repertorio di scuse patetiche e menzognere:
- Simula un malessere (“non mi sento bene”).
- Parla di generici “imbrogli” (“ci sono degli imbrogli”).
- Si lamenta della sua “troppa bontà” che lo porta a “trascurare il suo dovere” e poi a subire “rimproveri e peggio”.
- Si rifugia nel “latinorum” accennando agli “impedimenti dirimenti” (“Error, conditio, votum, cognatio, crimen…”), un espediente per confondere e intimidire Renzo. Il rifiuto di Renzo (“Che vuol ch’io faccia del suo latinorum?”) è significativo della distanza culturale tra i due e della ribellione del buon senso popolare contro l’abuso della cultura.
- La Crescente Esasperazione di Renzo: Renzo, inizialmente rispettoso, diventa via via più alterato. Il suo senso pratico e la sua impazienza si scontrano con le vaghezze e le menzogne di Don Abbondio. Il suo “Ma, col nome del cielo, non mi tenga così sulla corda, e mi dica chiaro e netto cosa c’è” esprime la sua richiesta di chiarezza e giustizia.
Nonostante l’astuzia di Don Abbondio, Renzo riesce a strappargli solo la promessa di un rinvio di una settimana, che Don Abbondio sperava fosse quindici giorni. Renzo esce, seppur con un inchino “men profondo del solito” e un’occhiata “più espressiva che riverente”, il seme del sospetto è ormai germogliato nella sua mente, che continua a trovare il colloquio “strano”. Questa inquietudine lo spingerà a cercare la verità altrove, preparando il terreno per l’intervento di Perpetua e la successiva, drammatica rivelazione del nome di Don Rodrigo.
Collegamento tra i Capitoli: La Messa in Moto del Dramma
La fine del Capitolo Primo e l’inizio del Capitolo Secondo sono indissolubilmente legati. La paura provata da Don Abbondio nel primo capitolo è la causa diretta della sua strategia evasiva e menzognera nel secondo. La sua viltà non solo impedisce il matrimonio, ma innesca una reazione a catena che disperderà i promessi sposi. Il passaggio da un capitolo all’altro ci mostra la conseguenza immediata del sopruso di Don Rodrigo: non una violenza diretta, ma un’azione indiretta che, attraverso la mediazione della paura di Don Abbondio, sconvolge le vite degli umili. Manzoni, con questa transizione, evidenzia la capillarità del potere arbitrario e le sue ripercussioni sulla quotidianità, preparando il lettore al lungo e tortuoso cammino dei protagonisti.
Testo dell’ultima parte del primo capitolo dei Promessi Sposi
Pensino ora i miei venticinque lettori che impressione dovesse fare sull’animo del poveretto, quello che s’è raccontato. Lo spavento di que’ visacci e di quelle parolacce, la minaccia d’un signore noto per non minacciare invano, un sistema di quieto vivere, ch’era costato tant’anni di studio e di pazienza, sconcertato in un punto, e un passo dal quale non si poteva veder come uscirne: tutti questi pensieri ronzavano tumultuariamente nel capo basso di don Abbondio. — Se Renzo si potesse mandare in pace con un bel no, via; ma vorrà delle ragioni; e cosa ho da rispondergli, per amor del cielo? E, e, e, anche costui è una testa: un agnello se nessun lo tocca, ma se uno vuol contraddirgli… ih! E poi, e poi, perduto dietro a quella Lucia, innamorato come… Ragazzacci, che, per non saper che fare, s’innamorano, voglion maritarsi, e non pensano ad altro; non si fanno carico de’ travagli in che mettono un povero galantuomo. Oh povero me! vedete se quelle due figuracce dovevan proprio piantarsi sulla mia strada, e prenderla con me! Che c’entro io? Son io che voglio maritarmi? Perché non son andati piuttosto a parlare… Oh vedete un poco: gran destino è il mio, che le cose a proposito mi vengan sempre in mente un momento dopo l’occasione. Se avessi pensato di suggerir loro che andassero a portar la loro imbasciata… — Ma, a questo punto, s’accorse che il pentirsi di non essere stato consigliere e cooperatore dell’iniquità era cosa troppo iniqua; e rivolse tutta la stizza de’ suoi pensieri contro quell’altro che veniva così a togliergli la sua pace. Non conosceva don Rodrigo che di vista e di fama, nè aveva mai avuto che far con lui, altro che di toccare il petto col mento, e la terra con la punta del suo cappello, quelle poche volte che l’aveva incontrato per la strada.
 Gli era occorso di difendere, in più d’un’occasione, la riputazione di quel signore, contro coloro che, a bassa voce, sospirando, e alzando gli occhi al cielo, maledicevano qualche suo fatto: aveva detto cento volte ch’era un rispettabile cavaliere. Ma, in quel momento gli diede in cuor suo tutti que’ titoli che non aveva mai udito applicargli da altri, senza interrompere in fretta con un oibò. Giunto, tra il tumulto di questi pensieri, alla porta di casa sua, ch’era in fondo del paesello, mise in fretta nella toppa la chiave, che già teneva in mano; aprì, entrò, richiuse diligentemente; e, ansioso di trovarsi in una compagnia fidata, chiamò subito: “Perpetua! Perpetua!,” avviandosi pure verso il salotto, dove questa doveva esser certamente ad apparecchiar la tavola per la cena. Era Perpetua, come ognun se n’avvede, la serva di don Abbondio: serva affezionata e fedele, che sapeva ubbidire e comandare, secondo l’occasione, tollerare a tempo il brontolìo e le fantasticaggini del padrone, e fargli a tempo tollerar le proprie, che divenivan di giorno in giorno più frequenti, da che aveva passata l’età sinodale dei quaranta, rimanendo celibe, per aver rifiutati tutti i partiti che le si erano offerti, come diceva lei, o per non aver mai trovato un cane che la volesse, come dicevan le sue amiche.
Gli era occorso di difendere, in più d’un’occasione, la riputazione di quel signore, contro coloro che, a bassa voce, sospirando, e alzando gli occhi al cielo, maledicevano qualche suo fatto: aveva detto cento volte ch’era un rispettabile cavaliere. Ma, in quel momento gli diede in cuor suo tutti que’ titoli che non aveva mai udito applicargli da altri, senza interrompere in fretta con un oibò. Giunto, tra il tumulto di questi pensieri, alla porta di casa sua, ch’era in fondo del paesello, mise in fretta nella toppa la chiave, che già teneva in mano; aprì, entrò, richiuse diligentemente; e, ansioso di trovarsi in una compagnia fidata, chiamò subito: “Perpetua! Perpetua!,” avviandosi pure verso il salotto, dove questa doveva esser certamente ad apparecchiar la tavola per la cena. Era Perpetua, come ognun se n’avvede, la serva di don Abbondio: serva affezionata e fedele, che sapeva ubbidire e comandare, secondo l’occasione, tollerare a tempo il brontolìo e le fantasticaggini del padrone, e fargli a tempo tollerar le proprie, che divenivan di giorno in giorno più frequenti, da che aveva passata l’età sinodale dei quaranta, rimanendo celibe, per aver rifiutati tutti i partiti che le si erano offerti, come diceva lei, o per non aver mai trovato un cane che la volesse, come dicevan le sue amiche.
“Vengo,” rispose, mettendo sul tavolino, al luogo solito, il fiaschetto del vino prediletto di don Abbondio, e si mosse lentamente; ma non aveva ancor toccata la soglia del salotto, ch’egli v’entrò, con un passo così legato, con uno sguardo così adombrato, con un viso così stravolto, che non ci sarebbero nemmen bisognati gli occhi esperti di Perpetua, per iscoprire a prima vista che gli era accaduto qualche cosa di straordinario davvero.
“Misericordia! cos’ha, signor padrone?”
“Niente, niente,” rispose don Abbondio, lasciandosi andar tutto ansante sul suo seggiolone.

“Come, niente? La vuol dare ad intendere a me? così brutto com’è? Qualche gran caso è avvenuto.”
“Oh, per amor del cielo! Quando dico niente, o è niente, o è cosa che non posso dire.”
“Che non può dir neppure a me? Chi si prenderà cura della sua salute? Chi le darà un parere?…”
“Ohimè! tacete, e non apparecchiate altro: datemi un bicchiere del mio vino.”
“E lei mi vorrà sostenere che non ha niente!” disse Perpetua, empiendo il bicchiere, e tenendolo poi in mano, come se non volesse darlo che in premio della confidenza che si faceva tanto aspettare.
“Date qui, date qui,” disse don Abbondio, prendendole il bicchiere, con la mano non ben ferma, e votandolo poi in fretta, come se fosse una medicina.
“Vuol dunque ch’io sia costretta di domandar qua e là cosa sia accaduto al mio padrone?” disse Perpetua, ritta dinanzi a lui, con le mani arrovesciate sui fianchi, e le gomita appuntate davanti, guardandolo fisso, quasi volesse succhiargli dagli occhi il segreto.
“Per amor del cielo! non fate pettegolezzi, non fate schiamazzi: ne va… ne va la vita!”
“La vita!”
“La vita.”
“Lei sa bene che, ogni volta che m’ha detto qualche cosa sinceramente, in confidenza, io non ho mai…”
“Brava! come quando…”
Perpetua s’avvide d’aver toccato un tasto falso; onde, cambiando subito il tono, “signor padrone,” disse, con voce commossa e da commovere, “io le sono sempre stata affezionata; e, se ora voglio sapere, è per premura, perché vorrei poterla soccorrere, darle un buon parere, sollevarle l’animo…”
Il fatto sta che don Abbondio aveva forse tanta voglia di scaricarsi del suo doloroso segreto, quanta ne avesse Perpetua di conoscerlo; onde, dopo aver respinti sempre più debolmente i nuovi e più incalzanti assalti di lei, dopo averle fatto più d’una volta giurare che non fiaterebbe, finalmente, con molte sospensioni, con molti ohimè, le raccontò il miserabile caso. Quando si venne al nome terribile del mandante, bisognò che Perpetua proferisse un nuovo e più solenne giuramento; e don Abbondio, pronunziato quel nome, si rovesciò sulla spalliera della seggiola, con un gran sospiro, alzando le mani, in atto insieme di comando e di supplica, e dicendo: “per amor del cielo!”
“Delle sue!” esclamò Perpetua. “Oh che birbone! oh che soverchiatore! oh che uomo senza timor di Dio!”
“Volete tacere? o volete rovinarmi del tutto?”
“Oh! siam qui soli che nessun ci sente. Ma come farà, povero signor padrone?”
“Oh vedete,” disse don Abbondio, con voce stizzosa: “vedete che bei pareri mi sa dar costei! Viene a domandarmi come farò, come farò; quasi fosse lei nell’impiccio, e toccasse a me di levarnela.”
“Ma! io l’avrei bene il mio povero parere da darle; ma poi…”
“Ma poi, sentiamo.”
“Il mio parere sarebbe che, siccome tutti dicono che il nostro arcivescovo è un sant’uomo, e un uomo di polso, e che non ha paura di nessuno, e, quando può fare star a dovere un di questi prepotenti, per sostenere un curato, ci gongola; io direi, e dico che lei gli scrivesse una bella lettera, per informarlo come qualmente…”
“Volete tacere? volete tacere? Son pareri codesti da dare a un pover’uomo? Quando mi fosse toccata una schioppettata nella schiena, Dio liberi! l’arcivescovo me la leverebbe?”
“Eh! le schioppettate non si danno via come confetti: e guai se questi cani dovessero mordere tutte le volte che abbaiano! E io ho sempre veduto che a chi sa mostrare i denti, e farsi stimare, gli si porta rispetto; e, appunto perché lei non vuol mai dir la sua ragione, siam ridotti a segno che tutti vengono, con licenza, a…”
“Volete tacere?”
“Io taccio subito; ma è però certo che, quando il mondo s’accorge che uno, sempre, in ogni incontro, è pronto a calar le…”
“Volete tacere? È tempo ora di dir codeste baggianate?”
“Basta: ci penserà questa notte; ma intanto non cominci a farsi male da sé, a rovinarsi la salute; mangi un boccone.”
“Ci penserò io,” rispose, brontolando, don Abbondio: “sicuro; io ci penserò, io ci ho da pensare.” E s’alzò, continuando: “non voglio prender niente; niente: ho altra voglia: lo so anch’io che tocca a pensarci a me. Ma! la doveva accader per l’appunto a me.”
“Mandi almen giù quest’altro gocciolo,” disse Perpetua, mescendo. “Lei sa che questo le rimette sempre lo stomaco.”
“Eh! ci vuol altro, ci vuol altro, ci vuol altro.”
Così dicendo prese il lume, e, brontolando sempre: “una piccola bagattella! a un galantuomo par mio! e domani com’andrà?” e altre simili lamentazioni, s’avviò per salire in camera. Giunto su la soglia, si voltò indietro verso Perpetua, mise il dito sulla bocca, disse, con tono lento e solenne: “per amor del cielo!” e disparve.

Testo del secondo capitolo dei Promessi Sposi
CAPITOLO II.
Si racconta che il principe di Condè dormì profondamente la notte avanti la giornata di Rocroi: ma, in primo luogo, era molto affaticato; secondariamente aveva già date tutte le disposizioni necessarie, e stabilito ciò che dovesse fare, la mattina. Don Abbondio in vece non sapeva altro ancora se non che l’indomani sarebbe giorno di battaglia; quindi una gran parte della notte fu spesa in consulte angosciose. Non far caso dell’intimazione ribalda, nè delle minacce, e fare il matrimonio, era un partito, che non volle neppur mettere in deliberazione. Confidare a Renzo l’occorrente, e cercar con lui qualche mezzo…. Dio liberi! “Non si lasci scappar parola…. altrimenti…. ehm!” aveva detto un di que’ bravi; e, al sentirsi rimbombar quell’ehm! nella mente, don Abbondio, non che pensare a trasgredire una tal legge, si pentiva anche dell’aver ciarlato con Perpetua. Fuggire? Dove? E poi! Quant’impicci, e quanti conti da rendere! A ogni partito che rifiutava, il pover’uomo si rivoltava nel letto. Quello che, per ogni verso, gli parve il meglio o il men male, fu di guadagnar tempo, menando Renzo per le lunghe. Si rammentò a proposito, che mancavan pochi giorni al tempo proibito per le nozze; — e, se posso tenere a bada, per questi pochi giorni, quel ragazzone, ho poi due mesi di respiro; e, in due mesi, può nascer di gran cose. — Ruminò pretesti da metter in campo; e, benché gli paressero un po’ leggieri, pur s’andava rassicurando col pensiero che la sua autorità gli avrebbe fatti parer di giusto peso, e che la sua antica esperienza gli darebbe gran vantaggio sur un giovanetto ignorante. — Vedremo, — diceva tra sé: — egli pensa alla morosa; ma io penso alla pelle: il più interessato son io, lasciando stare che sono il più accorto. Figliuol caro, se tu ti senti il bruciore addosso, non so che dire; ma io non voglio andarne di mezzo. — Fermato così un poco l’animo a una deliberazione, potè finalmente chiuder occhio: ma che sonno! che sogni! Bravi, don Rodrigo, Renzo, viottole, rupi, fughe, inseguimenti, grida, schioppettate.

Il primo svegliarsi, dopo una sciagura, e in un impiccio, è un momento molto amaro. La mente, appena risentita, ricorre all’idee abituali della vita tranquilla antecedente; ma il pensiero del nuovo stato di cose le si affaccia subito sgarbatamente; e il dispiacere ne è più vivo in quel paragone istantaneo. Assaporato dolorosamente questo momento, don Abbondio ricapitolò subito i suoi disegni della notte, si confermò in essi, gli ordinò meglio, s’alzò, e stette aspettando Renzo con timore e, ad un tempo, con impazienza.
Lorenzo o, come dicevan tutti, Renzo non si fece molto aspettare.

Appena gli parve ora di poter, senza indiscrezione, presentarsi al curato, v’andò, con la lieta furia d’un uomo di vent’anni, che deve in quel giorno sposare quella che ama. Era, fin dall’adolescenza, rimasto privo de’ parenti, ed esercitava la professione di filatore di seta, ereditaria, per dir così, nella sua famiglia; professione, negli anni indietro, assai lucrosa; allora già in decadenza, ma non però a segno che un abile operaio non potesse cavarne di che vivere onestamente. Il lavoro andava di giorno in giorno scemando; ma l’emigrazione continua de’ lavoranti, attirati negli stati vicini da promesse, da privilegi e da grosse paghe, faceva sì che non ne mancasse ancora a quelli che rimanevano in paese. Oltre di questo, possedeva Renzo un poderetto che faceva lavorare e lavorava egli stesso, quando il filatoio stava fermo; di modo che, per la sua condizione, poteva dirsi agiato. E quantunque quell’annata fosse ancor più scarsa delle antecedenti, e già si cominciasse a provare una vera carestia, pure il nostro giovine, che, da quando aveva messi gli occhi addosso a Lucia, era divenuto massaio, si trovava provvisto bastantemente, e non aveva a contrastar con la fame. Comparve davanti a don Abbondio, in gran gala, con penne di vario colore al cappello, col suo pugnale del manico bello, nel taschino de’ calzoni, con una cert’aria di festa e nello stesso tempo di braverìa, comune allora anche agli uomini più quieti. L’accoglimento incerto e misterioso di don Abbondio fece un contrapposto singolare ai modi gioviali e risoluti del giovinotto.
— Che abbia qualche pensiero per la testa, — argomentò Renzo tra sé, poi disse: “son venuto, signor curato, per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa.”
“Di che giorno volete parlare?”
“Come, di che giorno? non si ricorda che s’è fissato per oggi?”
“Oggi?” replicò don Abbondio, come se ne sentisse parlare per la prima volta. “Oggi, oggi… abbiate pazienza, ma oggi non posso.”
“Oggi non può! Cos’è nato?”
“Prima di tutto, non mi sento bene, vedete.”
“Mi dispiace; ma quello che ha da fare è cosa di così poco tempo, e di così poca fatica…”
“E poi, e poi, e poi…”
“E poi che cosa?”
“E poi c’è degli imbrogli.”
“Degl’imbrogli? Che imbrogli ci può essere?”
“Bisognerebbe trovarsi nei nostri piedi, per conoscer quanti impicci nascono in queste materie, quanti conti s’ha da rendere. Io son troppo dolce di cuore, non penso che a levar di mezzo gli ostacoli, a facilitar tutto, a far le cose secondo il piacere altrui, e trascuro il mio dovere; e poi mi toccan de’ rimproveri, e peggio.”
“Ma, col nome del cielo, non mi tenga così sulla corda, e mi dica chiaro e netto cosa c’è.”
“Sapete voi quante e quante formalità ci vogliono per fare un matrimonio in regola?”
“Bisogna ben ch’io ne sappia qualche cosa,” disse Renzo, cominciando ad alterarsi, “poiché me ne ha già rotta bastantemente la testa, questi giorni addietro. Ma ora non s’è sbrigato ogni cosa? non s’è fatto tutto ciò che s’aveva a fare?”
“Tutto, tutto, pare a voi: perché, abbiate pazienza, la bestia son io, che trascuro il mio dovere, per non far penare la gente. Ma ora… basta, so quel che dico. Noi poveri curati siamo tra l’ancudine e il martello: voi impaziente; vi compatisco, povero giovane; e i superiori…. basta, non si può dir tutto. E noi siam quelli che ne andiam di mezzo.”
“Ma mi spieghi una volta cos’è quest’altra formalità che s’ha a fare, come dice; e sarà subito fatta.”
“Sapete voi quanti siano gl’impedimenti dirimenti?”
“Che vuol ch’io sappia d’impedimenti?”
“Error, conditio, votum, cognatio, crimen,
Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas,
Si sis affinis,….”
cominciava don Abbondio, contando sulla punta delle dita.
“Si piglia gioco di me?” interruppe il giovine. “Che vuol ch’io faccia del suo latinorum?
“Dunque, se non sapete le cose, abbiate pazienza, e rimettetevi a chi le sa.”
“Orsù!….”
“Via, caro Renzo, non andate in collera, che son pronto a fare…. tutto quello che dipende da me. Io, io vorrei vedervi contento; vi voglio bene io. Eh!…. quando penso che stavate così bene; cosa vi mancava? V’è saltato il grillo di maritarvi….”
“Che discorsi son questi, signor mio?” proruppe Renzo, con un volto tra l’attonito e l’adirato.
“Dico per dire, abbiate pazienza, dico per dire. Vorrei vedervi contento.”
“In somma….”
“In somma, figliuol caro, io non ci ho colpa; la legge non l’ho fatta io. E, prima di conchiudere un matrimonio, noi siam proprio obbligati a far molte e molte ricerche, per assicurarci che non ci siano impedimenti.”
“Ma via, mi dica una volta che impedimento è sopravvenuto?”
“Abbiate pazienza, non son cose da potersi decifrare così su due piedi. Non ci sarà niente, così spero; ma, non ostante, queste ricerche noi le dobbiam fare. Il testo è chiaro e lampante: antequam matrimonium denunciet….”
“Le ho detto che non voglio latino.”
“Ma bisogna pur che vi spieghi….”
“Ma non le ha già fatte queste ricerche?”
“Non le ho fatte tutte, come avrei dovuto, vi dico.”
“Perchè non le ha fatte a tempo? perchè dirmi che tutto era finito? perchè aspettare….”
“Ecco! mi rimproverate la mia troppa bontà. Ho facilitato ogni cosa per servirvi più presto: ma…. ma ora mi son venute…. basta, so io.”
“E che vorrebbe ch’io facessi?”
“Che aveste pazienza per qualche giorno. Figliuol caro, qualche giorno non è poi l’eternità: abbiate pazienza.”
“Per quanto?”
— Siamo a buon porto, — pensò tra sè don Abbondio; e, con un fare più manieroso che mai, “via,” disse: “in quindici giorni cercherò,…. procurerò….”
“Quindici giorni! oh questa sì ch’è nuova! S’è fatto tutto ciò che ha voluto lei; s’è fissato il giorno; il giorno arriva; e ora lei mi viene a dire che aspetti quindici giorni! Quindici…” riprese poi, con voce più alta e stizzosa, stendendo il braccio, e battendo il pugno nell’aria; e chi sa qual diavoleria avrebbe attaccata a quel numero, se don Abbondio non l’avesse interrotto, prendendogli l’altra mano, con un’amorevolezza timida e premurosa: “via, via, non v’alterate, per amor del cielo. Vedrò, cercherò se, in una settimana….”

“E a Lucia che devo dire?”
“Ch’è stato un mio sbaglio.”
“E i discorsi del mondo?”
“Dite pure a tutti, che ho sbagliato io, per troppa furia, per troppo buon cuore: gettate tutta la colpa addosso a me. Posso parlar meglio? via, per una settimana.”
“E poi, non ci sarà più altri impedimenti?”
“Quando vi dico…”
“Ebbene: avrò pazienza per una settimana; ma ritenga bene che, passata questa, non m’appagherò più di chiacchiere. Intanto la riverisco.” E così detto, se n’andò, facendo a don Abbondio un inchino men profondo del solito, e dandogli un’occhiata più espressiva che riverente.
Uscito poi, e camminando di mala voglia, per la prima volta, verso la casa della sua promessa, in mezzo alla stizza, tornava con la mente su quel colloquio; e sempre più lo trovava strano. L’accoglienza fredda e impicciata di don Abbondio, quel suo parlare stentato insieme e impaziente, que’ due occhi grigi che, mentre parlava, eran sempre andati scappando qua e là, come se avesser avuto paura d’incontrarsi con le parole che gli uscivan di bocca, quel farsi quasi nuovo del matrimonio così espressamente concertato, e sopra tutto quell’accennar sempre qualche gran cosa, non dicendo mai nulla di chiaro; tutte queste circostanze messe insieme facevan pensare a Renzo che ci fosse sotto un mistero diverso da quello che don Abbondio aveva voluto far credere. Stette il giovine in forse un momento di tornare indietro, per metterlo alle strette, e farlo parlar più chiaro; ma, alzando gli occhi, vide Perpetua che camminava dinanzi a lui, ed entrava in un orticello pochi passi distante dalla casa. Le diede una voce, mentre essa apriva l’uscio; studiò il passo, la raggiunse, la ritenne sulla soglia, e, col disegno di scovar qualche cosa di più positivo, si fermò ad attaccar discorso con essa.
“Buon giorno, Perpetua: io speravo che oggi si sarebbe stati allegri insieme.”
“Ma! quel che Dio vuole, il mio povero Renzo.”
“Fatemi un piacere: quel benedett’uomo del signor curato m’ha impastocchiate certe ragioni che non ho potuto ben capire: spiegatemi voi meglio perché non può o non vuole maritarci oggi.”
“Oh! vi par egli ch’io sappia i segreti del mio padrone?”
— L’ho detto io, che c’era mistero sotto, — pensò Renzo; e, per tirarlo in luce, continuò: “via, Perpetua; siamo amici; ditemi quel che sapete, aiutate un povero figliuolo.”
“Mala cosa nascer povero, il mio caro Renzo.”
“È vero,” riprese questo, sempre più confermandosi ne’ suoi sospetti; e, cercando d’accostarsi più alla questione, “è vero,” soggiunse, “ma tocca ai preti a trattar male co’ poveri?”
“Sentite, Renzo; io non posso dir niente, perché… non so niente; ma quello che vi posso assicurare è che il mio padrone non vuol far torto, né a voi né a nessuno; e lui non ci ha colpa.”
“C‘hi è dunque che ci ha colpa?” domandò Renzo, con un cert’atto trascurato, ma col cuor sospeso, e con l’orecchio all’erta.
“Quando vi dico che non so niente… In difesa del mio padrone, posso parlare; perché mi fa male sentire che gli si dia carico di voler far dispiacere a qualcheduno. Pover’uomo! se pecca, è per troppa bontà. C’è bene a questo mondo de’ birboni, de’ prepotenti, degli uomini senza timor di Dio…”
— Prepotenti! birboni! — pensò Renzo: — questi non sono i superiori. “Via,” disse poi, nascondendo a stento l’agitazione crescente, “via, ditemi chi è.”

“Ah! voi vorreste farmi parlare; e io non posso parlare, perché… non so niente: quando non so niente, è come se avessi giurato di tacere. Potreste darmi la corda, che non mi cavereste nulla di bocca. Addio; è tempo perduto per tutt’e due.” Così dicendo, entrò in fretta nell’orto, e chiuse l’uscio. Renzo, rispostole con un saluto, tornò indietro pian piano, per non farla accorgere del cammino che prendeva; ma, quando fu fuor del tiro dell’orecchio della buona donna, allungò il passo; in un momento fu all’uscio di don Abbondio; entrò, andò diviato al salotto dove l’aveva lasciato, ve lo trovò, e corse verso lui, con un fare ardito, e con gli occhi stralunati.
“Eh! eh! che novità è questa?” disse don Abbondio.
“Chi è quel prepotente,” disse Renzo, con la voce d’un uomo ch’è risoluto d’ottenere una risposta precisa, “chi è quel prepotente che non vuol ch’io sposi Lucia?”
“Che? che? che?” balbettò il povero sorpreso, con un volto fatto in un istante bianco e floscio, come un cencio che esca del bucato. E, pur brontolando, spiccò un salto dal suo seggiolone, per lanciarsi all’uscio. Ma Renzo, che doveva aspettarsi quella mossa, e stava all’erta, vi balzò prima di lui, girò la chiave, e se la mise in tasca.
“Ah! ah! parlerà ora, signor curato? Tutti sanno i fatti miei, fuori di me. Voglio saperli, per bacco, anch’io. Come si chiama colui?”
“Renzo! Renzo! per carità, badate a quel che fate; pensate all’anima vostra.”
“Penso che lo voglio saper subito, sul momento.” E, così dicendo, mise, forse senza avvedersene, la mano sul manico del coltello che gli usciva dal taschino.
“Misericordia!” esclamò con voce fioca don Abbondio.
“Lo voglio sapere.”
“Chi v’ha detto…”
“No, no; non più fandonie. Parli chiaro e subito.”
“Mi volete morto?”
“Voglio sapere ciò che ho ragion di sapere.”
“Ma se parlo, son morto. Non m’ha da premere la mia vita?”
“Dunque parli.”
Quel “dunque” fu proferito con una tale energia, l’aspetto di Renzo divenne così minaccioso, che don Abbondio non poté più nemmen supporre la possibilità di disubbidire.
“Mi promettete, mi giurate,” disse “di non parlarne con nessuno, di non dir mai…?”
“Le prometto che fo uno sproposito, se lei non mi dice subito subito il nome di colui.”
A quel nuovo scongiuro, don Abbondio, col volto, e con lo sguardo di chi ha in bocca le tanaglie del cavadenti, proferì: “don…”
“Don?” ripetè Renzo, come per aiutare il paziente a buttar fuori il resto; e stava curvo, con l’orecchio chino sulla bocca di lui, con le braccia tese, e i pugni stretti all’indietro.

“Don Rodrigo!” pronunziò in fretta il forzato, precipitando quelle poche sillabe, e strisciando le consonanti, parte per il turbamento, parte perché, rivolgendo pure quella poca attenzione che gli rimaneva libera, a fare una transazione tra le due paure, pareva che volesse sottrarre e fare scomparir la parola, nel punto stesso ch’era costretto a metterla fuori.
“Ah cane!” urlò Renzo. “E come ha fatto? Cosa le ha detto per…?”
“Come eh? come?” rispose, con voce quasi sdegnosa, don Abbondio, il quale, dopo un così gran sagrifizio, si sentiva in certo modo divenuto creditore. “Come eh? Vorrei che la fosse toccata a voi, come è toccata a me, che non c’entro per nulla; che certamente non vi sarebber rimasti tanti grilli in capo.” E qui si fece a dipinger con colori terribili il brutto incontro; e, nel discorrere, accorgendosi sempre più d’una gran collera che aveva in corpo, e che fin allora era stata nascosta e involta nella paura, e vedendo nello stesso tempo che Renzo, tra la rabbia e la confusione, stava immobile, col capo basso, continuò allegramente: “avete fatta una bella azione! M’avete reso un bel servizio! Un tiro di questa sorte a un galantuomo, al vostro curato! in casa sua! in luogo sacro! Avete fatta una bella prodezza! Per cavarmi di bocca il mio malanno, il vostro malanno! ciò ch’io vi nascondevo per prudenza, per vostro bene! E ora che lo sapete? Vorrei vedere che mi faceste…! Per amor del cielo! Non si scherza. Non si tratta di torto o di ragione; si tratta di forza. E quando, questa mattina, vi davo un buon parere… eh! subito nelle furie. Io avevo giudizio per me e per voi; ma come si fa? Aprite almeno; datemi la mia chiave.”
“Posso aver fallato,” rispose Renzo, con voce raddolcita verso don Abbondio, ma nella quale si sentiva il furore contro il nemico scoperto: “posso aver fallato; ma si metta la mano al petto, e pensi se nel mio caso…”
Così dicendo, s’era levata la chiave di tasca, e andava ad aprire. Don Abbondio gli andò dietro, e, mentre quegli girava la chiave nella toppa, se gli accostò, e, con volto serio e ansioso, alzandogli davanti agli occhi le tre prime dita della destra, come per aiutarlo anche lui dal canto suo, “giurate almeno…” gli disse.
“Posso aver fallato; e mi scusi,” rispose Renzo, aprendo, e disponendosi ad uscire.
“Giurate…” replicò don Abbondio, afferrandogli il braccio con la mano tremante.
“Posso aver fallato,” ripetè Renzo, sprigionandosi da lui; e partì in furia, troncando così la questione, che, al pari d’una questione di letteratura o di filosofia o d’altro, avrebbe potuto durar dei secoli, giacché ognuna delle parti non faceva che replicare il suo proprio argomento.
“Perpetua! Perpetua!” gridò don Abbondio, dopo avere invano richiamato il fuggitivo. Perpetua non risponde: don Abbondio non sapeva più in che mondo si fosse.
È accaduto più d’una volta a personaggi di ben più alto affare che don Abbondio, di trovarsi in frangenti così fastidiosi, in tanta incertezza di partiti, che parve loro un ottimo ripiego mettersi a letto con la febbre. Questo ripiego, egli non lo dovette andare a cercare, perché gli si offerse da sé. La paura del giorno avanti, la veglia angosciosa della notte, la paura avuta in quel momento, l’ansietà dell’avvenire, fecero l’effetto. Affannato e balordo, si ripose sul suo seggiolone, cominciò a sentirsi qualche brivido nell’ossa, si guardava le unghie sospirando, e chiamava di tempo in tempo, con voce tremolante e stizzosa: “Perpetua!” La venne finalmente, con un gran cavolo sotto il braccio, e con la faccia tosta, come se nulla fosse stato. Risparmio al lettore i lamenti, le condoglianze, le accuse, le difese, i “voi sola potete aver parlato,” e i “non ho parlato,” tutti i pasticci in somma di quel colloquio. Basti dire che don Abbondio ordinò a Perpetua di metter la stanga all’uscio, di non aprir più per nessuna cagione, e, se alcun bussasse, risponder dalla finestra che il curato era andato a letto con la febbre. Salì poi lentamente le scale, dicendo, ogni tre scalini, “son servito;” e si mise davvero a letto, dove lo lasceremo.
Renzo intanto camminava a passi infuriati verso casa, senza aver determinato quel che dovesse fare, ma con una smania addosso di far qualcosa di strano e di terribile. I provocatori, i soverchiatori, tutti coloro che, in qualunque modo, fanno torto altrui, sono rei, non solo del male che commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano gli animi degli offesi. Renzo era un giovine pacifico e alieno dal sangue, un giovine schietto e nemico d’ogni insidia; ma, in que’ momenti, il suo cuore non batteva che per l’omicidio, la sua mente non era occupata che a fantasticare un tradimento. Avrebbe voluto correre alla casa di don Rodrigo, afferrarlo per il collo, e… ma gli veniva in mente ch’era come una fortezza, guarnita di bravi al di dentro, e guardata al di fuori; che i soli amici e servitori ben conosciuti v’entravan liberamente, senza essere squadrati da capo a piedi; che un artigianello sconosciuto non vi potrebb’entrare senza un esame, e ch’egli sopra tutto… egli vi sarebbe forse troppo conosciuto. Si figurava allora di prendere il suo schioppo, d’appiattarsi dietro una siepe, aspettando se mai, se mai colui venisse a passar solo; e, internandosi, con feroce compiacenza, in quell’immaginazione, si figurava di sentire una pedata, quella pedata, d’alzar chetamente la testa; riconosceva lo scellerato, spianava lo schioppo, prendeva la mira, sparava, lo vedeva cadere e dare i tratti, gli lanciava una maledizione, e correva sulla strada del confine a mettersi in salvo. — E Lucia? —

Appena questa parola si fu gettata a traverso di quelle bieche fantasie, i migliori pensieri a cui era avvezza la mente di Renzo, v’entrarono in folla. Si rammentò degli ultimi ricordi de’ suoi parenti, si rammentò di Dio, della Madonna e de’ santi, pensò alla consolazione che aveva tante volte provata di trovarsi senza delitti, all’orrore che aveva tante volte provato al racconto d’un omicidio; e si risvegliò da quel sogno di sangue, con ispavento, con rimorso, e insieme con una specie di gioia di non aver fatto altro che immaginare. Ma il pensiero di Lucia, quanti pensieri tirava seco! Tante speranze, tante promesse, un avvenire così vagheggiato, e così tenuto sicuro, e quel giorno così sospirato! E come, con che parole annunziarle una tal nuova? E poi, che partito prendere? Come farla sua, a dispetto della forza di quell’iniquo potente? E insieme a tutto questo, non un sospetto formato, ma un’ombra tormentosa gli passava per la mente. Quella soverchieria di don Rodrigo non poteva esser mossa che da una brutale passione per Lucia. E Lucia? Che avesse data a colui la più piccola occasione, la più leggiera lusinga, non era un pensiero che potesse fermarsi un momento nella testa di Renzo. Ma n’era informata? Poteva colui aver concepita quell’infame passione, senza che lei se n’avvedesse? Avrebbe spinte le cose tanto in là, prima d’averla tentata in qualche modo? E Lucia non ne aveva mai detta una parola a lui! al suo promesso!
Dominato da questi pensieri, passò davanti a casa sua, ch’era nel mezzo del villaggio, e, attraversatolo, s’avviò a quella di Lucia, ch’era in fondo, anzi un po’ fuori. Aveva quella casetta un piccolo cortile dinanzi, che la separava dalla strada, ed era cinto da un murettino. Renzo entrò nel cortile, e sentì un misto e continuo ronzìo che veniva da una stanza di sopra. S’immaginò che sarebbero amiche e comari, venute a far corteggio a Lucia; e non si volle mostrare a quel mercato, con quella nuova in corpo e sul volto. Una fanciulletta che si trovava nel cortile, gli corse incontro gridando: “lo sposo! lo sposo!”
“Zitta, Bettina, zitta!” disse Renzo. “Vien qua; va su da Lucia, tirala in disparte, e dille all’orecchio… ma che nessun senta, né sospetti di nulla, ve’… dille che ho da parlarle, che l’aspetto nella stanza terrena, e che venga subito.” La fanciulletta salì in fretta le scale, lieta e superba d’avere una commission segreta da eseguire.
Lucia usciva in quel momento tutta attillata dalle mani della madre. Le amiche si rubavano la sposa, e le facevan forza perché si lasciasse vedere; e lei s’andava schermendo, con quella modestia un po’ guerriera delle contadine, facendosi scudo alla faccia col gomito, chinandola sul busto, e aggrottando i lunghi e neri sopraccigli, mentre però la bocca s’apriva al sorriso. I neri e giovanili capelli, spartiti sopra la fronte, con una bianca e sottile dirizzatura, si ravvolgevan, dietro il capo, in cerchi moltiplici di trecce, trapassate da lunghi spilli d’argento, che si dividevano all’intorno, quasi a guisa de’ raggi d’un’aureola, come ancora usano le contadine nel Milanese. Intorno al collo aveva un vezzo di granati alternati con bottoni d’oro a filigrana: portava un bel busto di broccato a fiori, con le maniche separate e allacciate da bei nastri: una corta gonnella di filaticcio di seta, a pieghe fitte e minute, due calze vermiglie, due pianelle, di seta anch’esse, a ricami. Oltre a questo, ch’era l’ornamento particolare del giorno delle nozze, Lucia aveva quello quotidiano d’una modesta bellezza, rilevata allora e accresciuta dalle varie affezioni che le si dipingevan sul viso: una gioia temperata da un turbamento leggiero, quel placido accoramento che si mostra di quand’in quando sul volto delle spose, e, senza scompor la bellezza, le dà un carattere particolare. La piccola Bettina si cacciò nel crocchio, s’accostò a Lucia, le fece intendere accortamente che aveva qualcosa da comunicarle, e le disse la sua parolina all’orecchio.

“Vo un momento, e torno,” disse Lucia alle donne; e scese in fretta. Al veder la faccia mutata, e il portamento inquieto di Renzo, “cosa c’è?” disse, non senza un presentimento di terrore.
“Lucia!” rispose Renzo, “per oggi, tutto è a monte; e Dio sa quando potremo esser marito e moglie.”
“Che?” disse Lucia tutta smarrita. Renzo le raccontò brevemente la storia di quella mattina: ella ascoltava con angoscia: e quando udì il nome di don Rodrigo, “ah!” esclamò, arrossendo e tremando, “fino a questo segno!”
“Dunque voi sapevate…?” disse Renzo.
“Pur troppo!” rispose Lucia; “ma a questo segno!”
“Che cosa sapevate?”
“Non mi fate ora parlare, non mi fate piangere. Corro a chiamar mia madre, e a licenziar le donne: bisogna che siam soli. ”
Mentre ella partiva, Renzo sussurrò: “non m’avete mai detto niente.”
“Ah, Renzo!” rispose Lucia, rivolgendosi un momento, senza fermarsi. Renzo intese benissimo che il suo nome pronunziato in quel momento, con quel tono, da Lucia, voleva dire: potete voi dubitare ch’io abbia taciuto se non per motivi giusti e puri?
Intanto la buona Agnese (così si chiamava la madre di Lucia), messa in sospetto e in curiosità dalla parolina all’orecchio, e dallo sparir della figlia, era discesa a veder cosa c’era di nuovo. La figlia la lasciò con Renzo, tornò alle donne radunate, e, accomodando l’aspetto e la voce, come potè meglio, disse: “il signor curato è ammalato; e oggi non si fa nulla.” Ciò detto, le salutò tutte in fretta, e scese di nuovo.
Le donne sfilarono, e si sparsero a raccontar l’accaduto. Due o tre andaron fin all’uscio del curato, per verificar se era ammalato davvero.
“Un febbrone,” rispose Perpetua dalla finestra; e la trista parola, riportata all’altre, troncò le congetture che già cominciavano a brulicar ne’ loro cervelli, e ad annunziarsi tronche e misteriose ne’ loro discorsi.