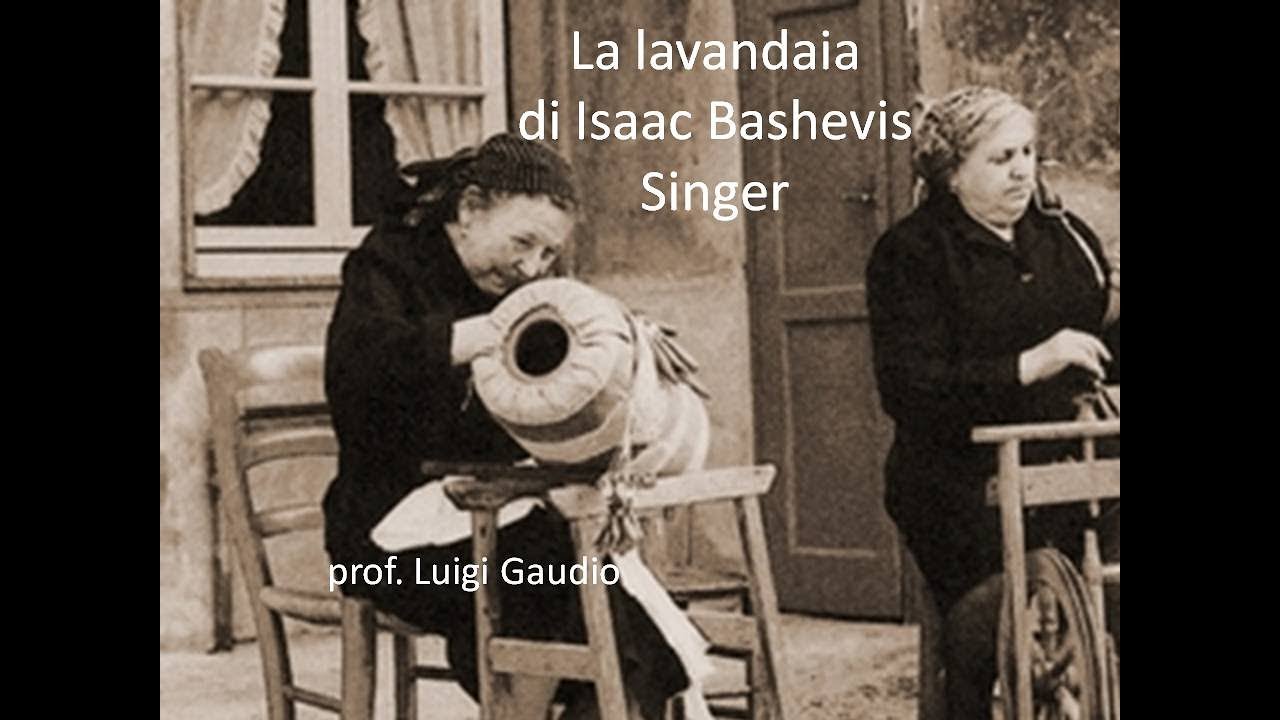
La lavandaia di Isaac Bashevis Singer
28 Dicembre 2019
Non chiederci la parola dagli Ossi di seppia di Eugenio Montale
28 Dicembre 2019📜 Testo, Parafrasi e Analisi della poesia Gloria del disteso mezzogiorno di Eugenio Montale, pubblicata nella raccolta Ossi di seppia (1925)
Testo e parafrasi della poesia
|
Testo Poesie scelte: EUGENIO MONTALE, Ossi di seppia (Torino, Piero Gobetti 1925). Gloria del disteso mezzogiorno il sole, in alto, – e un secco greto. L’arsura, in giro; un martin pescatore Ossi di seppia (Torino, Piero Gobetti Editore 1925). |
Parafrasi:
La luce di un mezzogiorno estivo è intensa e abbagliante , quando il sole è alto nel cielo e tutto appare immerso in una luminosità accecante. In questo momento, le ombre scompaiono quasi del tutto, e gli oggetti sembrano perdere i loro contorni, assumendo un colore pallido e sfumato. Il sole domina la scena, insieme a un paesaggio arido e secco, rappresentato dal “greto” (un letto di fiume asciutto). Nonostante l’aridità e la desolazione, il poeta sente che il suo giorno non è ancora finito: al di là di un muretto, simbolo di confine e limite, si intravede la possibilità di qualcosa di più bello, come un tramonto più intenso e significativo. L’arsura regna sovrana ovunque, ma c’è ancora un segno di vita: un martin pescatore volteggia sopra ciò che resta di un mondo vitale. La pioggia, fonte di rinnovamento e speranza, sembra lontana, ma proprio nell’attesa, nel desiderio di essa, risiede una gioia profonda e compiuta. |
Commento
1. Temi principali
- La luce e l’aridità
Il mezzogiorno descritto da Montale è dominato da una luce intensa e implacabile, che cancella le ombre e rende tutto uniformemente chiaro ma privo di profondità. Questa immagine riflette un senso di vuoto e di desolazione, simboleggiando forse l’aridità spirituale e l’assenza di significati chiari nella vita moderna. - Il passare del tempo e la speranza
Il poeta riflette sul proprio “giorno”, ovvero la sua esistenza, che sembra avviarsi verso il tramonto. Tuttavia, egli trova conforto nell’idea che il meglio debba ancora venire: al di là del “muretto”, simbolo di confini fisici e metaforici, si intravede la possibilità di un rinnovamento o di una bellezza superiore. - La natura e la vita
La natura appare qui come un luogo di contraddizioni: da un lato, c’è l’aridità e lo “squallore”, dall’altro, un martin pescatore, simbolo di vitalità e bellezza, continua a muoversi. Anche la pioggia, pur lontana, rappresenta una speranza di rinnovamento. L’attesa stessa diventa fonte di gioia, suggerendo che il significato della vita risiede spesso nella tensione verso qualcosa di migliore.
2. Simbolismo e immagini
- Il mezzogiorno
Il mezzogiorno è un momento di massima luminosità ma anche di massima aridità. È un’immagine ambivalente, che evoca sia la grandezza della natura sia la sua indifferenza nei confronti dell’uomo. - Il muretto
Il muretto rappresenta un confine, una barriera tra il presente difficile e un futuro carico di promesse. Al di là di esso si intravede un mondo migliore, simboleggiato dal tramonto “più bello”. - Il martin pescatore
Questo uccello è un simbolo di vita e resistenza. Nonostante l’aridità del paesaggio, esso continua a muoversi, rappresentando la persistenza della bellezza e della speranza anche nei momenti più difficili. - La pioggia
La pioggia è un elemento di rinnovamento e fertilità. Sebbene lontana, essa rappresenta la possibilità di un cambiamento positivo. L’attesa della pioggia diventa un atto di fede nella vita stessa.
3. Tono e stile
Il tono della poesia è malinconico ma non disperato. Montale riesce a trasmettere un senso di attesa e speranza, pur descrivendo un paesaggio arido e desolato. Lo stile è denso e simbolico, con immagini che oscillano tra concretezza e astrazione. La struttura della poesia è semplice ma efficace, con versi brevi che enfatizzano la solennità del momento descritto.
4. Contesto storico e letterario
Gloria del disteso mezzogiorno appartiene alla raccolta Ossi di seppia (1925), uno dei capolavori della poesia italiana del Novecento. Questa raccolta riflette spesso il disagio esistenziale dell’uomo moderno, intrappolato in un mondo privo di certezze e significati. Montale, influenzato dalla tradizione leopardiana, esplora temi come la precarietà della vita, il rapporto con la natura e la ricerca di una possibile salvezza.
5. Conclusione
Gloria del disteso mezzogiorno è una poesia che combina una descrizione realistica di un paesaggio estivo con una riflessione profonda sulla condizione umana. Attraverso immagini intense e simboliche, Montale esprime il senso di aridità e desolazione che caratterizza il mondo moderno, ma lascia anche spazio alla speranza e all’attesa di un rinnovamento. La poesia è un esempio magistrale della capacità di Montale di trasformare un’osservazione quotidiana in una meditazione universale.
Riassumendo: “Gloria del disteso mezzogiorno” di Montale è una poesia che combina una descrizione realistica di un paesaggio arido con una riflessione esistenziale sulla condizione umana. Attraverso immagini simboliche e un tono malinconico ma speranzoso, Montale esplora temi come l’aridità spirituale, il passare del tempo e la ricerca di un rinnovamento.
📜 Testo, Parafrasi e Analisi di “Casa sul mare” di Eugenio Montale 🌊, un componimento che chiude la sezione “Mediterraneo” in Ossi di seppia (1925).
Testo e parafrasi della poesia
|
Testo di “Casa sul mare” Il viaggio finisce qui: Il viaggio finisce a questa spiaggia Tu chiedi se così tutto vanisce Il cammino finisce a queste prode Ossi di seppia (Torino, Piero Gobetti Editore 1925). |
Parafrasi:
Il mio cammino termina qui, Ora il tempo scorre uguale e immobile, Il viaggio si conclude su questa spiaggia Tu mi chiedi se tutto finisce così, Vorrei dirti che non è così, Penso che per la maggior parte delle persone Vorrei, prima di arrendermi, indicarti questa via di fuga, Ti offro anche la mia povera speranza. Il mio percorso termina qui, |
🧠 Analisi del testo e struttura
Versi liberi (assenza di rime fisse o schema metrico), come è tipico di Montale, ma con ritmo scandito e pausato, quasi ipnotico.
Il poeta si rivolge a una figura non chiaramente definita — forse sé stesso, forse un interlocutore reale o simbolico — e riflette sul fine di un viaggio, sia esistenziale che conoscitivo. Il tono è dimesso, malinconico, segnato da una stanca consapevolezza.
🌊 Tematiche principali
1. Fine del viaggio e crisi dell’eroismo
“Il viaggio finisce qui: / nelle cure meschine…”
🔸 Il “viaggio” è metafora della ricerca di senso, e la conclusione è amara: non c’è un approdo eroico, ma la banalità della quotidianità.
2. Tempo che si consuma, ciclico e immobile
“Ora i minuti sono eguali e fissi / come i giri di ruota della pompa…”
🕰️ Il tempo non porta più mutamento né crescita: è ripetitivo e sterile, come una macchina che gira a vuoto. È il tempo della disillusione.
3. Assenza di epifanie
“Nulla disvela se non pigri fumi…”
La natura non parla più. La “marina” non rivela nulla di trascendente: solo nebbia e silenzi.
4. Desiderio di salvezza, ma per altri
“Vorrei dirti che no, che ti s’appressa / l’ora che passerai di là dal tempo…”
🔹 Il poeta non crede più nella possibilità di salvarsi o elevarsi, ma desidera che l’altro possa farlo. C’è una speranza delegata, offerta quasi in pegno.
5. L’incomunicabilità e il distacco
“Il tuo cuore vicino che non m’ode…”
💔 L’altro è fisicamente vicino, ma non ascolta: simbolo della solitudine esistenziale, anche nei legami più stretti.
✍️ Stile e simboli
-
Il mare: simbolo ambivalente, da un lato rifugio e infinito, dall’altro luogo di dissolvimento e incertezza.
-
La pompa, la nebbia, i flussi lenti: immagini della monotonia, dell’inerzia, del senso di vacuità.
-
“Ti dono anche l’avara mia speranza”: gesto commovente. Il poeta rinuncia alla speranza per sé, ma la offre a chi gli è caro.
📌 Commento personale
Casa sul mare è una poesia profondamente montalianamente negativa, in cui però sopravvive una scintilla di umanità: anche se non c’è fede in una salvezza personale, si auspica che altri possano trovarla.
Montale afferma, con tutta la sua lucidità, che per i più non c’è salvezza, ma per qualcuno sì, e lascia aperta una via di fuga (sia pur fragile come una “spuma”): è il massimo che si possa dire in un mondo disilluso.
✨ Frase da ricordare
“Ti dono anche l’avara mia speranza.”
🔹 Una resa, ma anche un atto di generosità estrema.
📜 Testo, Parafrasi e Analisi del componimento «Dora Markus» da Le occasioni di Eugenio Montale, con commento critico.
Testo e Parafrasi
|
Testo della poesia “Dora Markus” di Eugenio Montale (da Le Occasioni)
|
Parafrasi[Prima sezione]La poesia si apre con un’immagine di Porto Corsini, un luogo solitario e desolato dove il ponte di legno conduce al mare. Qui, Dora Markus, con un semplice gesto della mano, indica la sua “patria vera”, invisibile all’orizzonte. Da lì, i due proseguono lungo un canale fino alla città, immersa in una foschia primaverile e inerte, priva di memoria. In questo contesto, le parole di Dora brillano come le scaglie di una triglia morente, evocando un senso di irrequietezza e tensione emotiva. La sua ansia interiore è paragonata agli uccelli migratori che, durante le tempeste, sbattono contro i fari: anche la sua dolcezza è una tempesta che non si vede ma che turbinosamente si agita dentro di lei. Montale si chiede come Dora riesca a resistere in questo mondo di indifferenza, forse grazie a un piccolo amuleto (un topo bianco d’avorio) che porta sempre con sé, insieme ai suoi oggetti di bellezza. [Seconda sezione]Ora Dora vive in Carinzia, una regione caratterizzata da stagni e mirti fioriti. Qui, china sul bordo di uno stagno, osserva le carpe che abboccano timidamente o guarda i tigli illuminati dai riflessi del vespro. La sera cala su questa terra umida, portando solo i gemiti delle oche e l’eco di una storia di errori che si riflette nello specchio annerito del passato. La leggenda di Dora è già scritta negli sguardi degli uomini, nei ritratti d’oro e nelle melodie spezzate di un’armonica che risuona nel crepuscolo. Ravenna, simbolo di un passato glorioso, è lontana, mentre una fede crudele distilla veleno. Nonostante tutto, Dora non può sfuggire alla sua voce, alla sua leggenda o al suo destino. Ma ormai è troppo tardi. |
Commento
1. Contesto storico e biografico
“Dora Markus” è una delle poesie più celebri di Eugenio Montale, inserita nella raccolta Le Occasioni . Il testo nasce dalla fusione di due momenti diversi: un primo nucleo ispirato alla bellezza fisica di una ragazza moldava, Dora Markus, incontrata nel 1928, e una seconda parte composta nel 1939, quando l’Europa si avviava verso la Seconda Guerra Mondiale. Questa doppia genesi spiega la complessità del testo, che oscilla tra un tono intimo e personale e una riflessione più ampia sul destino umano e sulle tragedie storiche.
2. Temi principali
- L’irrequietezza esistenziale
Dora Markus è ritratta come una figura inquieta, divisa tra il desiderio di appartenenza e la consapevolezza della propria estraneità al mondo. La sua “dolcezza” è paragonata a una tempesta nascosta, un’energia che turbinosamente si agita dentro di lei senza trovare pace. Questa irrequietezza è simbolo della condizione umana moderna, segnata da un senso di alienazione e precarietà. - Il conflitto tra presente e passato
Nella seconda parte della poesia, il passato di Dora ritorna sotto forma di “storia di errori imperturbati”, incisa in modo indelebile. Lo specchio annerito rappresenta il ricordo distorto e inevitabile del passato, che continua a influenzare il presente. - Il destino e la Storia
La poesia si conclude con un’allusione alle persecuzioni naziste e alla violenza della Storia. La frase “Ravenna è lontana, distilla / veleno una fede feroce” suggerisce come il mondo sia cambiato radicalmente, e come Dora, come molti altri, sia intrappolata in un destino che non può controllare.
3. Simbolismo e immagini
- Il ponte di legno e il mare alto
Questi elementi evocano un confine tra due mondi: quello reale e tangibile e quello invisibile, simboleggiato dalla “patria vera” indicata da Dora. Questo gesto rivela la sua nostalgia per qualcosa di irraggiungibile. - La triglia moribonda
Le parole di Dora sono paragonate alle scaglie iridescenti di una triglia morente, un’immagine che combina bellezza e fragilità. Questo simbolo suggerisce come la sua voce sia preziosa ma destinata a svanire. - Gli uccelli di passo
Gli uccelli migratori che urtano contro i fari rappresentano la lotta dell’individuo contro le forze ostili del mondo. Anche la dolcezza di Dora è una tempesta che la consuma dall’interno. - Lo specchio annerito
Lo specchio è un simbolo potente del passato e della memoria. Riflette una versione distorta di Dora, diventata “diversa” rispetto a ciò che era un tempo. È un’immagine che suggerisce l’ineluttabilità del cambiamento e del tempo. - Il topo bianco d’avorio
L’amuleto che Dora porta con sé è un dettaglio quotidiano che assume un significato profondo. Rappresenta un oggetto di protezione, un piccolo talismano contro l’indifferenza del mondo, ma anche un simbolo della sua fragile esistenza.
4. Tono e stile
Montale adotta un tono malinconico e riflessivo, tipico della sua poesia. Il linguaggio è denso e simbolico, con immagini che oscillano tra concretezza e astrazione. La struttura del testo è frammentaria, riflettendo la complessità emotiva e intellettuale del poeta.
5. Conclusione
“Dora Markus” è una poesia che unisce l’intimità di un incontro personale con una riflessione universale sulla condizione umana. Attraverso la figura di Dora, Montale esplora temi come l’irrequietezza esistenziale, il conflitto tra passato e presente e il peso del destino individuale e storico. La poesia è un esempio magistrale della capacità di Montale di trasformare un episodio privato in una meditazione profonda e universale.
Riassumendo: “Dora Markus” di Montale è una poesia che unisce l’intimità di un incontro personale con una riflessione universale sulla condizione umana, esplorando temi come l’irrequietezza esistenziale, il conflitto tra passato e presente, e il peso del destino individuale e storico. Attraverso immagini simboliche e un tono malinconico, Montale crea un testo denso e profondamente evocativo.
📘Solo Testo della poesia “Dora Markus” di Eugenio Montale (da Le Occasioni)
- [I sezione] Fu dove il ponte di legno
- mette a Porto Corsini sul mare alto
- e rari uomini, quasi immoti, affondano
- o salpano le reti. Con un segno
- della mano additavi all’altra sponda
- invisibile la tua patria vera.
- Poi seguimmo il canale fino alla darsena
- della città, lucida di fuliggine,
- nella bassura dove s’affondava
- una primavera inerte, senza memoria.
- E qui dove un’antica vita
- si screzia in una dolce
- ansietà d’Oriente,
- le tue parole iridavano come le scaglie
- della triglia moribonda.
- La tua irrequietudine mi fa pensare
- agli uccelli di passo che urtano ai fari
- nelle sere tempestose:
- è una tempesta anche la tua dolcezza,
- turbina e non appare,
- e i suoi riposi sono anche più rari.
- Non so come stremata tu resisti
- in questo lago
- d’indifferenza ch’è il tuo cuore; forse
- ti salva un amuleto che tu tieni
- vicino alla matita delle labbra,
- al piumino, alla lima: un topo bianco
- d’avorio; e così esisti!
- [II sezione] Ormai nella tua Carinzia
- di mirti fioriti e di stagni,
- china sul bordo sorvegli
- la carpa che timida abbocca
- o segui sui tigli, tra gl’irti
- pinnacoli le accensioni
- del vespro e nell’acque un avvampo
- di tende da scali e pensioni.
- La sera che si protende
- sull’umida conca non porta
- col palpito dei motori
- che gemiti d’oche e un interno
- di nivee maioliche dice
- allo specchio annerito che ti vide
- diversa una storia di errori
- imperturbati e la incide
- dove la spugna non giunge.
- La tua leggenda, Dora!
- Ma è scritta già in quegli sguardi
- di uomini che hanno fedine
- altere e deboli in grandi
- ritratti d’oro e ritorna
- ad ogni accordo che esprime
- l’armonica guasta nell’ora
- che abbuia, sempre più tardi.
- È scritta là. Il sempreverde
- alloro per la cucina
- resiste, la voce non muta,
- Ravenna è lontana, distilla
- veleno una fede feroce.
- Che vuole da te? Non si cede
- voce, leggenda o destino…
- Ma è tardi, sempre più tardi.
🎤🎧 Audio Lezioni, ascolta il podcast su Giuseppe Ungaretti del prof. Gaudio
Ascolta “Giuseppe Ungaretti” su Spreaker.




