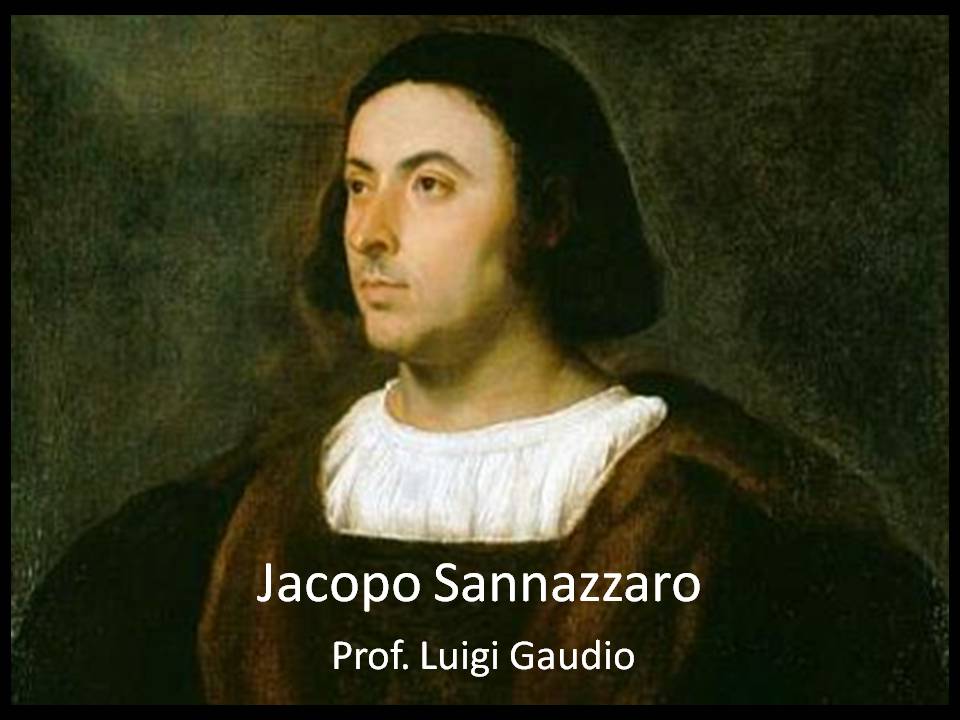
Di male in peggio dall’Arcadia di Jacopo Sannazaro
28 Dicembre 2019
Armeni popolo da conoscere
28 Dicembre 2019Francesco Guicciardini è spesso considerato l’antimachiavelli per la sua visione della politica e della storia, che si distingue in molti punti da quella del suo contemporaneo Niccolò Machiavelli.
Sebbene i due abbiano condiviso un’epoca segnata da grandi sconvolgimenti politici e abbiano affrontato temi simili, come il potere, la fortuna e il ruolo della virtù politica, la loro prospettiva e i loro metodi differiscono profondamente. Guicciardini offre un approccio più pragmatico e scettico rispetto a quello di Machiavelli, e queste differenze sono state così significative da farlo considerare una sorta di “opposto” del pensatore fiorentino.
1. Il realismo di Machiavelli vs il pragmatismo di Guicciardini
Machiavelli è celebre per il suo realismo politico e la sua convinzione che il principe debba agire senza vincoli morali, adottando tutti i mezzi necessari per mantenere il potere e raggiungere i propri obiettivi. Nelle sue opere, come Il Principe e I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Machiavelli promuove un modello di politica basato sull’uso della forza, dell’inganno e della virtù intesa come capacità di adattarsi alle circostanze.
Guicciardini, invece, si allontana da questa visione “universale” e rigida della politica. Nel suo pensiero, la politica è molto più complessa e legata al contesto particolare di ogni situazione. Egli insiste sulla necessità di una “discrezione” politica, ovvero la capacità di valutare di volta in volta le circostanze specifiche per decidere la linea d’azione migliore. Questa visione lo rende più scettico e meno ottimista rispetto alla possibilità di trovare leggi generali per la politica, come invece credeva Machiavelli. Guicciardini si preoccupa meno dell’affermazione del potere a ogni costo e più della gestione attenta e realistica delle circostanze concrete.
2. Il concetto di fortuna
Machiavelli dà un’importanza centrale alla fortuna (il caso, la sorte) nella vita politica, affermando che essa controlla almeno metà delle nostre azioni, mentre l’altra metà è dominata dalla virtù, ovvero dalla capacità dell’uomo di adattarsi e piegare la fortuna a proprio favore. Secondo Machiavelli, il leader deve essere pronto a sfruttare le opportunità che la fortuna gli offre.
Guicciardini, pur riconoscendo l’importanza della fortuna, è molto più scettico riguardo alla possibilità di controllarla o manipolarla. Nelle sue Ricordi, Guicciardini osserva che gli uomini spesso sopravvalutano la loro capacità di influenzare gli eventi, sottolineando invece l’importanza delle circostanze esterne e imprevedibili. Per lui, la fortuna è una forza più inafferrabile e capricciosa, e non può essere domata facilmente dalla virtù umana.
3. Il pessimismo guicciardiniano
Machiavelli, malgrado il suo realismo politico, crede ancora in una certa misura nel potenziale della virtù e della capacità di un leader di plasmare il destino. Machiavelli vede la politica come un’arte dinamica, dove l’individuo può cambiare il corso degli eventi grazie alla sua abilità e audacia.
Guicciardini, d’altra parte, è molto più pessimista sulla possibilità dell’azione umana di cambiare davvero il corso della storia. Per lui, le azioni dei singoli sono spesso limitate e frustrate dalle circostanze esterne, e l’uomo è raramente in grado di controllare il proprio destino. Questa visione emerge chiaramente nei suoi Ricordi, dove si mostra disincantato rispetto alle capacità umane di influire significativamente sulla realtà politica.
4. Il valore della storia
Machiavelli guarda alla storia come una fonte di insegnamenti per i leader politici contemporanei. Nei suoi Discorsi, fa spesso riferimento agli esempi degli antichi Romani per mostrare come le lezioni del passato possano essere applicate alla realtà politica del presente. Per lui, la storia fornisce modelli di comportamento utili per chi vuole governare con successo.
Guicciardini, pur essendo anch’egli uno storico, è più cauto nell’uso della storia come guida per il presente. Crede che le circostanze specifiche di ogni epoca siano talmente diverse da rendere difficile applicare le lezioni del passato in modo diretto. Questa visione critica emerge in opere come la Storia d’Italia, dove Guicciardini mette in luce l’imprevedibilità degli eventi storici e il ruolo decisivo delle contingenze.
5. L’individualismo guicciardiniano
Una delle caratteristiche distintive di Guicciardini è il suo profondo individualismo. Egli è convinto che ogni uomo debba agire per il proprio interesse personale, poiché non ci si può fidare che gli altri agiscano con integrità o per il bene comune. Questo principio, noto come “particulare”, è uno dei temi centrali dei suoi Ricordi. Guicciardini sottolinea che è illusorio pensare che gli uomini siano motivati dal bene collettivo, e che invece sia fondamentale che ogni individuo protegga i propri interessi.
Machiavelli, pur riconoscendo l’importanza dell’interesse personale, ha una visione più collettiva e istituzionale della politica. Nei suoi Discorsi, ad esempio, elogia la repubblica come la migliore forma di governo, poiché permette il coinvolgimento di tutti i cittadini nella difesa della libertà comune. Anche se vede l’egoismo umano come una forza potente, crede che le istituzioni repubblicane possano incanalarlo verso il bene della comunità.
Conclusione
Francesco Guicciardini viene considerato l’antimachiavelli non perché sia contrario a ogni aspetto del pensiero di Machiavelli, ma perché il suo approccio è molto più scettico, individualista e legato alla valutazione concreta delle situazioni. Se Machiavelli cerca di trovare regole generali per il potere politico, Guicciardini sottolinea l’unicità di ogni contesto e la necessità di un giudizio flessibile e pragmatico. Il pessimismo di Guicciardini, la sua enfasi sull’individualismo e la sua visione della storia lo pongono in contrasto con l’ottimismo e la fiducia di Machiavelli nella virtù e nella capacità umana di plasmare il mondo.




