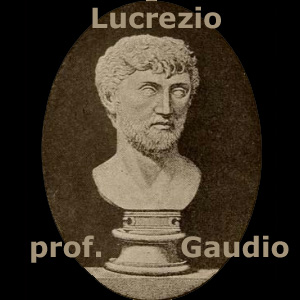
La passione d’amore dal De rerum natura di Lucrezio IV 1129-1140
28 Dicembre 2019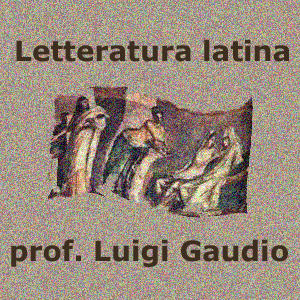
Testimonianze poetiche preletterarie in latino
28 Dicembre 2019I Comuni Italiani tra XII e XIII Secolo: Autonomie, Sviluppo e Conflitti
Il periodo compreso tra il XII e il XIII secolo rappresenta l’apogeo dello sviluppo dei Comuni italiani, un fenomeno politico, sociale ed economico unico nel panorama europeo. Mentre nel resto del continente le monarchie feudali si consolidavano, in Italia centro-settentrionale le città riuscirono a emanciparsi dal potere imperiale e feudale, sviluppando forme di autogoverno che le resero centri di straordinaria vitalità economica, culturale e politica.
1. Origini e Sviluppo del Fenomeno Comunale (XI-XII Secolo)
I Comuni italiani nacquero in un contesto di indebolimento del potere centrale (imperiale e papale) e di forte crescita demografica ed economica delle città.
- Il Ruolo dei Vescovi: Inizialmente, la crisi delle istituzioni feudali aveva visto i vescovi assumere un ruolo di governo all’interno delle città. Attorno alla figura vescovile, si formò un ceto dirigente composto da aristocratici rurali inurbati, giuristi, mercanti e artigiani.
- L’Emancipazione dal Vescovo: Con il tempo, questi ceti, sempre più consapevoli della propria forza economica e sociale, iniziarono a rivendicare maggiore autonomia decisionale rispetto al vescovo. Spesso, l’iniziativa fu presa da associazioni private (coniurationes) di cittadini che giuravano fedeltà reciproca.
- La Dieta di Roncaglia (1158): L’emergere dei Comuni non fu pacifico. L’imperatore Federico I Barbarossa tentò di ripristinare l’autorità imperiale in Italia, rivendicando le “regalie” (diritti di battere moneta, amministrare la giustizia, imporre tasse, levare eserciti, ecc.) che i Comuni si erano appropriati. Questo portò a un lungo scontro.
2. L’Evoluzione Politica Interna: Dalla Consolato al Podestà al Capitano del Popolo
La struttura di governo dei Comuni non fu statica, ma subì significative evoluzioni riflettendo i cambiamenti degli equilibri sociali:
- Fase Consolare (fine XI – metà XII secolo):
- Governo: Il potere era esercitato da un collegio di Consoli (da 2 a 20), eletti annualmente, quasi sempre provenienti dalle famiglie aristocratiche (i milites o nobili).
- Istituzioni: Il cuore della vita politica era il Consiglio Maggiore (assemblea dei cittadini più influenti) e il Consiglio di Credenza (un organo più ristretto per le decisioni importanti). Le decisioni finali erano spesso ratificate dal Parlamento o Arengo (assemblea di tutti i cittadini maschi).
- Conflitti: Questa fase fu caratterizzata dalle lotte tra le fazioni aristocratiche per il controllo del consolato.
- Fase Podestarile (metà XII – metà XIII secolo):
- Governo: Per porre fine alle continue lotte intestine tra le famiglie nobili, si decise di chiamare un Podestà, una figura forestiera (non appartenente alla città), professionista della politica e del diritto. Il podestà rimaneva in carica per un periodo limitato (di solito un anno o sei mesi) e, al termine del mandato, era sottoposto a un esame (sindacato) per verificare la sua condotta.
- Obiettivo: La sua imparzialità e competenza avrebbero dovuto garantire stabilità, ordine pubblico e un’amministrazione più efficiente.
- Efficacia: Inizialmente, questa figura portò maggiore equilibrio e professionalità nella gestione del Comune.
- Fase del Popolo (fine XII – XIII secolo):
- Ascesa del Popolo: Contemporaneamente, cresceva la forza economica e politica del “Popolo“, ovvero i ceti produttivi non nobili (ricchi mercanti, banchieri, artigiani organizzati in Corporazioni o Arti). Questi, pur non essendo esclusi dalla partecipazione politica, sentivano i loro interessi non pienamente rappresentati dalla nobiltà.
- Organizzazione: Il Popolo si organizzò in proprie associazioni (le Società delle Arti e delle Armi) con propri Consigli e, a volte, un proprio “capo” chiamato Capitano del Popolo.
- Doppia Amministrazione: In molti Comuni si sviluppò una sorta di “doppia amministrazione”: quella del Podestà (espressione della nobiltà e della tradizione comunale) e quella del Capitano del Popolo (espressione dei ceti produttivi). Questo portò a nuove tensioni e conflitti.
3. La Lotta per l’Autonomia: Comuni, Impero e Papato
Il XII e XIII secolo furono dominati dalla lotta per il riconoscimento delle autonomie comunali, in particolare contro l’Impero.
- Federico I Barbarossa e la Lega Lombarda: Federico Barbarossa, come già menzionato, tentò di riaffermare i diritti imperiali (le regalie) e di imporre funzionari imperiali nei Comuni. Questo portò a un conflitto aperto. Nel 1167, molti Comuni dell’Italia settentrionale si unirono nella Lega Lombarda, con il sostegno del Papato (Alessandro III), che vedeva nell’Imperatore una minaccia al proprio potere.
- Battaglia di Legnano (1176): L’esercito della Lega Lombarda inflisse una clamorosa sconfitta alle forze imperiali di Federico Barbarossa. Questa vittoria fu cruciale per il futuro dei Comuni.
- Pace di Costanza (1183): Con questa pace, Federico Barbarossa fu costretto a riconoscere le regalie ai Comuni (diritto di battere moneta, di riscuotere tasse, di eleggere i propri magistrati, di fortificare le città), in cambio di un riconoscimento formale della sua sovranità. Fu una vittoria decisiva per le autonomie comunali.
4. Aspetti Economici e Sociali
La prosperità economica fu un pilastro fondamentale dell’autonomia comunale.
- Attività Economiche: I Comuni erano centri di vivace attività manifatturiera (lana, seta, armi), commerciale (lungo le vie fluviali, terrestri e marittime) e finanziaria (banche, prestiti). Città come Firenze, Milano, Venezia, Genova, Pisa, Siena, Lucca divennero potenze economiche di prim’ordine.
- Corporazioni delle Arti: I mestieri e le professioni erano organizzati in Corporazioni (o Arti), che tutelavano gli interessi dei propri membri, regolavano la produzione, fissavano i prezzi e spesso avevano un peso politico significativo.
- Gerarchie Sociali: La società comunale era complessa:
- Nobili/Magnati: L’antica aristocrazia feudale (spesso con castelli rurali e torri in città).
- Popolo Grasso: I grandi mercanti, banchieri, imprenditori delle Arti Maggiori, che acquisirono sempre più potere economico e poi politico.
- Popolo Minuto: I piccoli artigiani, bottegai, lavoratori delle Arti Minori.
- Lavoratori Subalterni: Coloro che non facevano parte di nessuna Arte, spesso privi di diritti politici.
5. I Conflitti Interni: Guelfi e Ghibellini
Il XII e XIII secolo furono anche l’epoca delle aspre lotte intestine che dilaniavano i Comuni:
- Guelfi e Ghibellini: Le città si divisero in fazioni. I Guelfi sostenevano il Papato e le autonomie comunali, mentre i Ghibellini erano sostenitori dell’Imperatore. Queste divisioni erano spesso pretesto per lotte tra famiglie rivali o tra ceti sociali diversi, e portavano a esili, confische e violenze.
- Lotte tra Popolo e Magnati: Nelle città più dinamiche, lo scontro più significativo fu quello tra il Popolo (che voleva estendere la propria partecipazione al potere) e i Magnati (l’antica nobiltà, spesso esclusa o limitata da “leggi antimagnatizie” per via della loro violenza).
6. Crisi e Trasformazione (Fine XIII – XIV Secolo)
Verso la fine del XIII secolo, il sistema comunale iniziò a mostrare segni di crisi. Le continue lotte intestine, l’incapacità di garantire stabilità e la necessità di affrontare una politica esterna più complessa (con l’emergere degli Stati regionali) portarono al progressivo declino delle libertà comunali e all’affermarsi delle Signorie. I Comuni non scomparvero del tutto, ma il potere si concentrò nelle mani di un singolo signore (spesso un Podestà o Capitano del Popolo che aveva saputo sfruttare i conflitti), che avrebbe poi instaurato dinastie ereditarie.
In conclusione, i Comuni italiani del XII e XIII secolo furono un laboratorio politico e sociale straordinario. Essi rappresentarono un’alternativa vitale alle monarchie feudali europee, dimostrando la capacità delle città di autogovernarsi e di generare un’enorme ricchezza economica e culturale. Le loro lotte per l’autonomia, le loro complesse strutture politiche e le loro vivaci dinamiche sociali hanno lasciato un’eredità duratura nella storia italiana ed europea.




